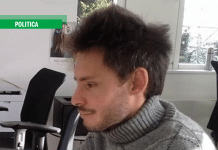Se il cinema ha il pregio di essere definito arte è grazie ad opere come Il regno d’inverno di Nurij Bilge Ceylan (Palma d’oro a Cannes e ora in sala). Si tratta di un film impegnativo, non solo per la durata, 3 ore e 20, ma perché con la sua lenta ritmica temporale, magistralmente condotta, ci chiede di aderire a un’esperienza visiva che è anche “filosofica”.

In questo processo di messa a nudo dell’ipocrisia umana, non solo emerge la tenace resistenza al cambiamento, il bieco conservatorismo nel tutelare il proprio ruolo sociale, ma anche la fragile identità di chi gli sta attorno e vede le ragioni del cuore naufragare di fronte alla brutalità dell’esperienza. L’ex attore incontra la maschera che da sempre indossa, quella del falso sé, e lentamente perde colpi. Trovandosi in una posizione di forza («il mio regno è piccolo, ma io sono il re») controlla e manipola la vita della moglie, così come controlla e decide la vita dei suoi affittuari, ma lo fa senza “sporcarsi le mani”. E il discorso si eleva dalle strutture della società turca ad una riflessione etica di più ampio respiro.
Il politico intride il dramma esistenziale: la carità non serve a nulla, se non per lenire il senso di colpa; il denaro regolamenta e uccide la sincerità dei rapporti umani; l’idealismo astratto pseudoromantico vela l’egotismo e la pretesa di gratitudine. La sfida di Ceylan, a differenza di quanto aveva fatto nelle sue straordinarie opere precedenti, ma in rigorosa continuità con esse, avviene lungo due direttrici: la prima riguarda il modo in cui il cinema e la parola possono restituire le segrete spire del pensiero tra silenzi e voci off che ritagliano l’inespresso; la seconda si svolge sul piano dello stile, perché l’artista rinuncia alla progressione narrativa, per rappresentare la durata interna.
Con paesaggi simbolici che alludono all’immobilità interna dei personaggi, anche qui appare l’altopiano anatolico sepolto dalla neve, sospeso in un inverno senza tempo e senza fine, immerso in una luce livida, in cui l’alba si confonde con il tramonto; tuttavia questi momenti, mai descrittivi, sono squarci di singolare bellezza, che restituiscono con maggiore potenza la claustrofobica perimetratura del teatro da camera, di ascendenza cechoviana, scelta dal regista per rappresentare conflittualità taciute, represse, che irrompono sulla scena con tagliente ferocia, trattenuto dolore, subdola moderazione. Tutti hanno le loro ragioni, eppure la verità è lontana.