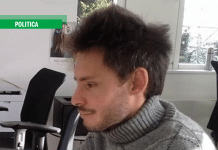Timbuktu del regista mauritano Abderrahmane Sissako è un film di rara bellezza e sospeso incanto, pur trattando il tema dell’orrore jihadista in terra d’Africa.
Lascia senza respiro per le qualità estetiche e la raffinata semplicità del linguaggio, per i temi che affronta con limpida chiarezza e rigore morale, per la narrazione, scevra da retorica, che alla consequenzialità logica preferisce una frammentarietà liricamente avvolgente, dolorosamente profonda.

Il regista si muove tra le contraddizioni con leggerezza di tocco e sottile ironia: i ragazzi giocano una splendida partita, senza pallone ai piedi; la donna, punita a colpi di frusta, grida il suo dolore con un canto straziante; i jihadisti comunicano con i cellulari in inglese; diversamente non riescono a capirsi; il rapper, chiamato a pronunciare di fronte alla videocamera la sharia contro gli infedeli, non riesce più a parlare; il miliziano importuna la donna sposata, accusandola di indecenza, quando il marito non c’è; l’imam cerca di ammorbidire l’ottusità del fanatismo religioso, spiegando in nome di Allah il suo dissenso; le teste degli idoli pagani vengono crivellate di colpi.
Sullo sfondo resta la fuga di una gazzella, inseguita da una jeep, mentre gli uomini fuori campo gridano di non ucciderla, ma sfiancarla, e poi la corsa di un giovane in moto, di un adolescente e di una bimba. Non è importante la meta, visivamente solo la tensione elastica del movimento vitale acquista senso e con esso le corde degli strumenti musicali pizzicate sommessamente, le voci sensuali che sussurrano un canto, gli sguardi delle donne, i colori sgargianti che tagliano la campitura monocroma del deserto, tracce di una resistenza e di una bellezza che non vuole morire.