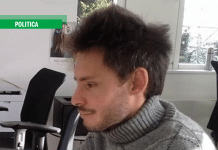Vincitore a Cannes del premio della giuria (ex-aequo con Godard), Mommy è un film da non perdere. Il regista, Xavier Dolan, autore di 5 lungometraggi e un videoclip, a soli 25 anni firma un lavoro sorprendente per forza ritmica e originalità espressiva. Chi vi assiste ha la sensazione di essere proiettato in un vortice di furiosa energia, che colpisce duro la testa e il cuore e in cui tutti remano disperatamente tra i flutti di una vita avara di pienezza e felicità, selvaggiamente ostile, in balia di pulsioni manifeste e latenti, contrappunti interiori esasperati e dissonanti, patologie gravi e immersive.
 Evidenti, per ammissione del regista, i riferimenti autobiografici. La vicenda mostra una madre 46enne, Diane, convocata d’urgenza dalla casa di recupero per minori, dove si trova suo figlio, Steve, affinché se lo riprenda: ha provocato un incendio, ha gravemente ustionato un compagno e, a detta della dirigente, è irrecuperabile. L’alternativa che le si offre è internarlo in una struttura psichiatrica, in virtù di una legge esistente in Canada, per cui i genitori possono decidere di farlo senza necessità di esami e perizie. In una casa fatiscente, dove regnano polvere e caos, madre e figlio si ritrovano a vivere insieme un complesso rapporto di odio e amore, incline a forme di erotismo compiaciuto e altre complicità. Violenti litigi e difficoltà economiche, aggressioni verbali e fisiche, crudeltà e ingiurie polverizzano il tentativo di darsi un’apparenza di normalità come famiglia. Finché non entra nella loro esistenza una vicina di casa, Keyla, ex insegnante in anno sabbatico, bloccata da una balbuzie ai limiti dell’afasia, che diventa amica della madre e riesce a stabilire un rapporto con il ragazzo, riavvicinandolo allo studio.
Evidenti, per ammissione del regista, i riferimenti autobiografici. La vicenda mostra una madre 46enne, Diane, convocata d’urgenza dalla casa di recupero per minori, dove si trova suo figlio, Steve, affinché se lo riprenda: ha provocato un incendio, ha gravemente ustionato un compagno e, a detta della dirigente, è irrecuperabile. L’alternativa che le si offre è internarlo in una struttura psichiatrica, in virtù di una legge esistente in Canada, per cui i genitori possono decidere di farlo senza necessità di esami e perizie. In una casa fatiscente, dove regnano polvere e caos, madre e figlio si ritrovano a vivere insieme un complesso rapporto di odio e amore, incline a forme di erotismo compiaciuto e altre complicità. Violenti litigi e difficoltà economiche, aggressioni verbali e fisiche, crudeltà e ingiurie polverizzano il tentativo di darsi un’apparenza di normalità come famiglia. Finché non entra nella loro esistenza una vicina di casa, Keyla, ex insegnante in anno sabbatico, bloccata da una balbuzie ai limiti dell’afasia, che diventa amica della madre e riesce a stabilire un rapporto con il ragazzo, riavvicinandolo allo studio.
Tuttavia la trama non è prevedibile come ci si può immaginare. Non ci sono deus ex machina in questo dramma familiare e tantomeno gli stereotipi della madre anaffettiva e dell’adolescente border line. Ci sono semmai momenti che ricordano le lacrime amare di Fassbinder e l’urgenza di vita di Truffaut. Tra emozioni contrapposte e pensieri antitetici, i personaggi sono pericolosamente ambivalenti, vibranti e opachi: Steven è un ragazzo con un deficit dell’attenzione, iperattivo, violento eppure sensibile, a cui è venuto a mancare il padre; Diane è una donna sola, che ha sempre do-vuto combattere per tirarsi fuori dagli impicci, compresi i debiti lasciati dal marito, cinica e disillusa; Keyla ha perso il figlio e non sa più qual è il suo ruolo in famiglia e sulla terra.
A dispetto delle grida, tutto è segreto, sfuggente, intimo, intuito attraverso foto e rapidi accenni, come se la vita corresse altrove e l’ebbrezza condensata in pochi istanti di volo leggero sullo skate board potesse sanare le ferite del passato. La macchina da presa, in debito con la fluidità ossessiva di Cassavetes, non dà tregua agli straordinari attori ed esalta la concentrazione parossistica delle situazioni, tra eleganti intarsi di montaggio giocati sul contrasto tra sfocature e rallenti. Il flashforward sotto finale è un momento di effimera illusione e grande poesia delle immagini. L’alternanza dei formati della visione è un’apertura plastica al respiro e alla libertà, che disincaglia il pubblico dalla travolgente amarezza che suggella l’opera. Ma solo per un istante.