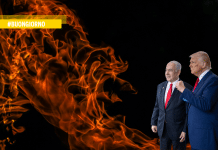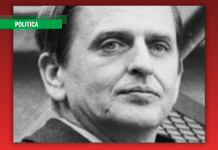«La Storia ci dà già ragione», dice sicuro Manlio Di Stefano, deputato 5 stelle che con Alessandro Di Battista condivide la passione per gli esteri, un wannabe sottosegretario, e che meglio di altri esprime così l’orgoglio del Movimento 5 stelle, che si considera meglio di Podemos, dei gemelli diversi spagnoli, colpevoli di scendere a patti con la politica, di fare politica, politica delle alleanze. Colpa mortale, pare – e non conta nulla che Podemos abbia comunque eletto 72 deputati. La politica, per il Movimento 5 stelle, è irriformabile, almeno per quel che riguarda i partiti.
Quindi niente alleanze: è la sacra regola. Che sia il Pd, che sia Forza Italia o che sia Izquierda unida non fa differenza. «Sinceramente non capisco cosa stupisca quelli che commentano la sconfitta elettorale di Podemos», dice ancora Di Stefano: «per quale motivo un elettore dovrebbe affidarsi ad un partito nuovo, che si propone come rivoluzionario e alternativo, ma si presenta in coalizione con l’estrema sinistra di Izquierda Unida? Se devo votare una finta novità per essere poi tradito come i greci con Tsipras, allora preferisco votare direttamente per i vecchi partiti almeno so cosa mi aspetta».
La regola, per Di Stefano, è quindi universale, e vale – «inosservata» – da anni, vale anche per il passato: «Volete un esempio italiano?», continua Di Stefano: «la Lega Nord». «Nata per mandare a casa “Roma ladrona” e Berlusconi “il mafioso” (parola di Bossi), è finita ad allearsi col Cavaliere per la smania di andare subito al Governo, e adesso è seppellita in un consenso da partito minore intorno al 10 per cento». La Lega, in effetti, tra il 1994 e il 1996 Berlusconi lo chiamava «Berluskàz», Bossi tuonava contro «il grande fascista di Arcore» (10 aprile 1995, La Repubblica), diceva «ci risponda, Berlusconi: da dove vengono i suoi soldi?». E deve avergli dato spiegazioni convincenti, Berlusconi, evidentemente. «Capite», è sempre Di Stefano a parlare, «perché siamo sempre più convinti che l’intransigenza verso la parte marcia del sistema sia un valore inestimabile?
Pensate se ci fossimo alleati con Bersani tre anni fa o se Beppe Grillo avesse lasciato Renzi provare a sedurci a quel famoso tavolo, oggi saremmo una minoranza qualsiasi in Parlamento». Di Stefano ne è convinto – rimuove il fatto che Beppe Grillo un tempo chiese di poter partecipare alle primarie del Pd – ma è convinto. E in effetti a Grillo fu il partito democratico a dire di no – e fu quella l’occasione dell’epica previsione di Piero Fassino: «Grillo si faccia un suo partito e vediamo quanto prende!», disse l’ex sindaco di Torino, la cui seconda profezia riguarda la sconfitta (e quindi la vittoria) di Chiara Appendino. Non l’avesse mai detto, Fassino, forse ora Grillo sarebbe un Civati più riccio e agitato. Quello che dice Di Stefano, lo dice, con toni più moderati, anche Luigi Di Maio.
Il candidato premier in pectore del Movimento 5 stelle la teoria la spiega così: «Noi crediamo che i partiti non si possano salvare dall’interno», dice il giovane leader, che piace ormai anche a un pezzo di establishment e a un pezzo di destra, «anche perché puntualmente le forze di rinnovamento che ci sono vengono fermate o non riescono a portare a termine il loro progetto». «Con i partiti», dunque, «non si possono fare alleanze». I partiti sono il male, e un po’ lo sono anche le alleanze in sé. Non per nulla, quando il Movimento 5 stelle si è brevemente seduto al tavolo del confronto sulla legge elettorale, una delle tre richieste consegnate a Renzi (insieme alle preferenze e all’eliminazione dei capolista bloccati) era il premio alla lista e non più alla coalizione, come invece prevedeva la prima versione dell’Italicum. E quest’ultimo passaggio, la richiesta sull’Italicum mossa ai tempi, in coerenza con la regola ferrea sulle alleanze, che ci aiuta a parlare del rapporto tra 5 stelle e legge elettorale.
Perché se oggi i grillini dicono che l’Italicum non si può cambiare ma «va buttato tutto intero» – come dice Danilo Toninelli, deputato -, non sempre hanno detto così. Un tempo lo avrebbero modificato, mentre oggi Di Maio scommette che sarà il Pd a toccarlo, e per convenienza: «Io», dice, «penso che proveranno a proteggersi», che lo modificheranno sia se dovesse vincere il sì al referendum costituzionale – perché comunque il Movimento 5 stelle rischia di prendere il ricco premio di maggioranza e, a quel punto, governare – sia perché «se vince il No al referendum e si vota con l’Italicum per la Camera e con il proporzionale al Senato né il M5s né altri possono governare». È probabile che sia così, e il posizionamento di Dario Franceschini tra i favorevoli al ritorno del premio di coalizione sembra confermare la lettura.
Ma è vero anche il contrario. Che il Movimento 5 stelle, cioè, se non preme ora per modificare l’Italicum è perché – si può malignare – vuole vedere l’esito del referendum, forse addirittura sperando che vincano i Sì. Perché è una legge con il premio di maggioranza, se ci si pensa, l’unico ragionevole modo con cui il Movimento 5 stelle può sperare di andare al governo, senza fare alleanze. Dice Di Maio che ci penseranno una volta al governo a mitigare gli effetti di Italicum e riforma costituzionale. Il 50 per cento da soli è però difficile prenderlo, impossibile senza il meccanismo del ballottaggio – che c’è invece nelle città. Questa cosa ai vertici del Movimento – la cui proposta di legge elettorale depositata è proporzionale – la sanno. Ma se gliela fai notare non ottieni risposte valide. «Il Movimento 5 stelle non fa alleanze», ti rispondono. Anche stimolati sulle liste civiche per ora dagli staff dicono che no, «non si fanno alleanze».
Ma chissà che non ci si possa ammorbidire un po’, col tempo. D’altronde, per dire, quant’è che i parlamentari 5 stelle non fanno un’assemblea in streaming? E le riunioni che hanno preceduto la composizione della giunta Raggi, un tempo non avrebbero dovuto farcele vedere? Di soldi dell’indennità, deputati e senatori, eletti nel 2013, devono restituirne molti: per gli europarlamentari, eletti nel 2014, è molto più economico. Anche la regola sul doppio mandato non sembra eterna. Per ora la difendono tutti, sì. Se dici a Roberto Fico ti dice che tutto può essere, c’è sempre chi pensa qualcosa di strano, tipo modificare le regole, ma che quella del doppio mandato non si tocca.
E anche Luigi Di Maio la difende, dice che serve «per moralizzare il sistema». Si dice pronto a tornare a lavorare, Di Maio, che non ha un lavoro in realtà, ma stava avviando una società di e-commerce con i suoi amici di Pomigliano, prima di entrare in Parlamento. Dice che il limite dei due mandati anzi dovrà valere per tutti i parlamentari, di tutti i partiti. Almeno per un po’, però. Perché poi aggiunge: «Oggi servono regole certe, poi un giorno magari potremmo anche tornare indietro. Come Paese». Alleanza, qualche politico a scadenza più lunga, un po’ meno di ideologia post-ideologica.
Questo articolo lo trovi su Left in edicola dal 9 luglio