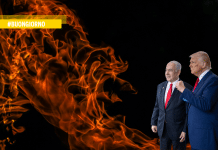«Nel mercato del lavoro si concretizza il nesso tra inferiorizzazione dei migranti e amplificazione della retorica razzista», dice a Left il professor Mauro Ferrari, dell’università Ca’ Foscari. Che si tratti di nuovi schiavi in agricoltura, di donne centroafricane nel mercato della prostituzione, di collaboratrici familiari dei Paesi dell’est (le cosiddette “badanti”), in tutti questi casi e in altri ancora, i due temi, svalutazione del lavoro dei migranti e razzismo, si tengono. La marginalizzazione dei migranti consente ai detentori di quei segmenti del mercato del lavoro – italiani o stranieri che siano, consapevoli o meno che siano – di prosperare (alimentando lavoro nero e forme differenti di sfruttamento) e di mostrare come sia “tollerabile”, o meglio “funzionale”, che masse di diseredati popolino, in assenza di diritti, questi segmenti di territorio e di mercato del lavoro.
Professore, c’è un nesso con l’accentuarsi della crisi?
La crisi economica non ha fatto altro che accentuare queste dinamiche, con un aspetto di continuità rispetto al fenomeno del sottoproletariato e una differenza fondamentale rispetto al passato: oggi è dissolta la – vera o presunta – compattezza dello strato sociale che abitava le fabbriche. Al punto che gli attuali partiti xenofobi trovano ascolto in larga parte proprio tra coloro che in passato riuscivano a manifestare solidarietà internazionaliste, e che invece con sempre maggiore difficoltà riescono oggi a rappresentarsi come un corpo omogeneo. La globalizzazione, nel suo lato oscuro – delocalizzazione industriale, accorpamenti, trionfo del “finanzcapitalismo” -, ha provocato destabilizzazioni importanti, che ora cercano risposte in partiti o movimenti distanti dalle loro origini storiche, ma quanto mai affini al nesso fra crisi, precarietà (o instabilità, o insicurezza) e ricerca di risposte individuali.
Come è cambiato il razzismo in questi anni?
Lo straniero è utilizzato come elemento che porta confusione, instabilità, e quindi respinto con argomenti impropri sia sul piano storico-geografico che su quello antropologico. Nell’elaborazione antropologica classica sono due le modalità di relazione fra due gruppi di individui: da un lato la xenofobia (“vomitare” l’altro), che equivale all’eliminazione di uno o ambedue i gruppi, e dall’altra la xenofilia (“mangiare”, quindi “incorporare” l’altro), cioè viceversa all’assimilazione nel senso più pieno del termine. Tra queste due posizioni estreme è compresa buona parte delle politiche migratorie “modellizzate” nel loro agire normativo: alle due estreme la proposta assimilativa (un’unica identità nazionale), oppure il concepire il migrante come “ospite temporaneo” (da espellere appena possibile) e in posizione intermedia l’ipotesi comunitarista: la compresenza di molti gruppi definiti una-volta-per-tutte e l’assenza di strategie di interazione-integrazione, che rischia di rinforzare le chiusure reciproche. Esiste anche una forte differenza simbolica: nello scambio impari tra soggetti che definiscono le “culture” di altri soggetti, qualcuno “nomina” qualcun altro confermandone insieme l’estraneità e l’inferiorità. Pensiamo ad esempio all’utilizzo spesso inconsapevole del termine “etnia”. Dove sta la reciprocità di questa categoria? Spesso sostituisce la categoria del “razzismo”, ritenuto meno corretto.
Questo articolo continua su Left in edicola dal 16 luglio