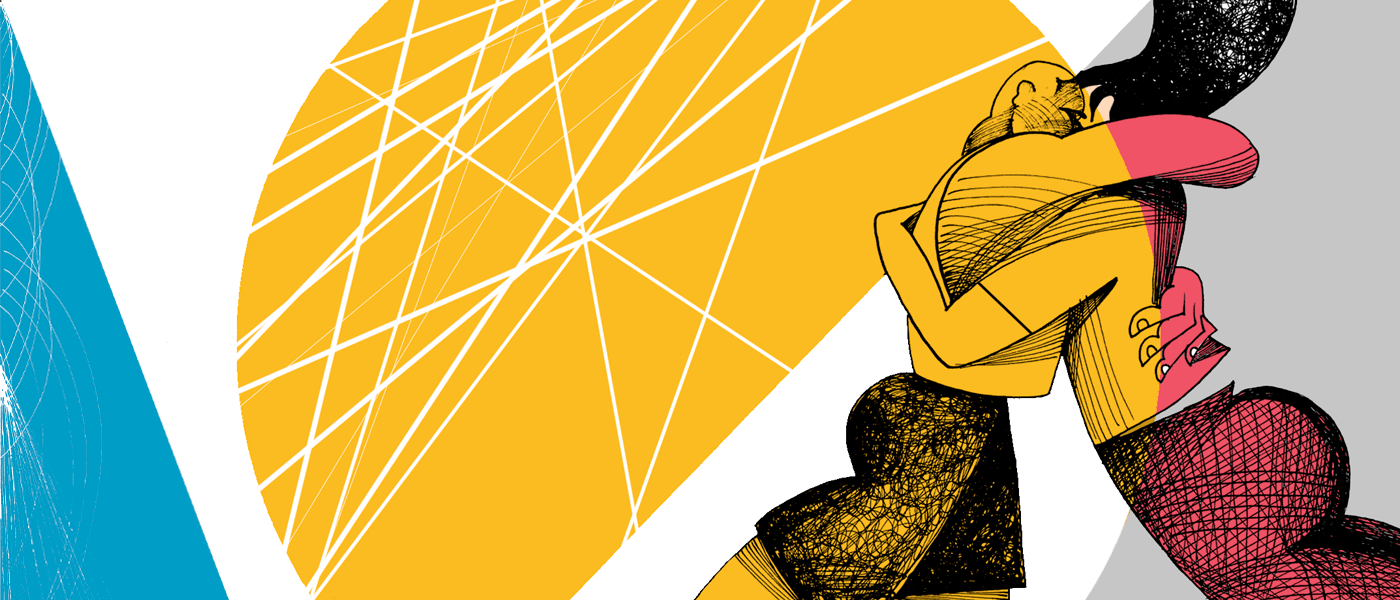Ci si presenta spesso con un nome, un’identità, una definizione. Nessuno, e dico bene, proprio nessuno, conta solo perché è. Sono un viaggiatore, e nei passi c’è un po’ di tutti coloro che ho incontrato nel mio cammino, perciò sono testimone vivo della realtà. Non si è senza gli Altri. E quando pensavo all’Europa a quei tempi, c’era una parola che mi piaceva dire e ripetere a me stesso, all’infinito: accoglienza.
Accoglienza. Come salvezza, forse, o semplicemente come inizio. Sono nato nel cuore dell’Africa, in una terra rossa e arida come il sangue, dove sopravvivere ha quasi del miracoloso. So trarre l’acqua dalle piante, ma non basta più. So zappare la terra per giorni e giorni, ma non piove più. E, nel frattempo, vedo aprirsi senza sosta strade nuove nella sterpaglia e tra i baobab, vedo i camion carichi di merci sfrecciare tutti i giorni sempre più numerosi, verso destinazioni sconosciute ma probabilmente migliori. A casa mia c’è poco, ma abbastanza. Il miglio è diventato raro, vale danaro e io non ne ho, non saprei nemmeno come fare per averne, ma è indispensabile. Per me, e per gli altri per cui sono vivo, è difficile. Ma vorrei vivere e, per farlo, devo andare. Alla paura di lasciare tutto si oppone la speranza dell’Accoglienza. Lì dove vanno le merci, l’oro delle miniere, il metallo, ci sarà posto anche per me. A costo di lavare i piedi dei bianchi, io andrò in Europa. Non per ambizione personale, non per rivalsa, ma semplicemente per esigenza. Poi, sicuramente, sarò accolto.
Il deserto e il mare ti ricordano la vita, per la morte. Vedevo cadere molti intorno a me, sapevo di essere vulnerabile, ma una chance, una sola, una piccola, è migliore di tutto quello che abbiamo lasciato. Sono arrivato nel Paese dei bianchi con tanta stanchezza. Ma c’è l’emozione dell’arrivo, quel brivido che ti svuota di tutte le forze sì, ma sai che ci sarà qualcuno ad accoglierti. C’era il governo. Firmare, firmare, firmare, sempre firmare. Io volevo lavorare, ma dovevo firmare. Ho firmato per mesi e mesi, costretto in strutture chiamate Cie e poi in albergo. Ho compreso che la disperazione e la fame non erano una ragione sufficiente per attraversare il mare. Ho compreso che il valore delle merci è superiore al valore degli umani, ma ho capito anche che non potevo tornare indietro. Qui piove tanto sì, ma non ho né zappa né terra, tutto appartiene ma non a tutti. Ho imparato a mangiare la pasta, il minestrone, a fare colazione col caffè e il latte e, poi, finalmente, è arrivato il permesso di soggiorno. In molti credono che tutti quelli che arrivano con le navi ne siano provvisti e vengano lasciati andare, ma non è esattamente così. Il permesso di soggiorno è la chiave di tutto, puoi scampare alla morte mille volte tra il deserto e il mare, ma senza il permesso di soggiorno è come se non fossi mai partito, perché non conti niente, in nessun modo. Non esisti e, se esisti, vieni rimpatriato.
Accoglienza. Era la mia speranza, eppure ho trovato amministrazione, numeri, preoccupazioni. E razzismo. Di ogni sorta, da chi ti insulta senza che tu gli abbia fatto niente, chiamandoti scimmia e invitandoti a tornartene a casa tua, al ragazzino che ti chiama “ragazzo” con tono di superiorità.
Accoglienza. Il contrario di quel dolore che rode il fegato di qualunque migrante. Conscio di essere, di produrre, di avere diritti, eppure frustrato per il credo di altri esseri umani. È difficile bruciare senza poter urlare. Un immigrato, vive questa condizione.
Accoglienza. Una bella cosa, che non per forza comporta il donare o il dare, a volte basta semplicemente essere per contare.
Accoglienza. E a me veniva in mente una sola parola: Teranga. Andavo nei bar, nelle piazze, in cerca di Teranga. Potevano essere occhi o braccia aperte, potevano essere sorrisi o parole, o anche ascolto. Ho trovato ciò che cercavo in un mosaico, ma in frantumi. Pezzi di sorrisi, frammenti di abbracci, sembianze di integrazione, è stato allora che oltre alla fame di chi era rimasto in Africa aspettandomi, si è aggiunta la mia. Contare e far contare. Teranga è una casa, non un paese, ha un senso non un motto, è una realtà non uno slogan. Doveva partire da me, poiché sapevo molto bene ciò che avrei desiderato trovare. Dovevo costruire una casa per tutti coloro che cercavano fratelli. Un bisogno personale. Sono stato schiacciato, volevo evitare che accadesse ad altri. Volevo arrivare in Europa ed essere accolto, adesso che ero in Europa avrei accolto chi aveva lo stesso sogno.
Ho incontrato Napoli un anno prima della fine del secondo millennio. Più di affascinare, Napoli mi ha rapito, in un dolo che dura da quasi vent’anni. Mi ha preso in ostaggio e mi ha regalato una figlia, compagna eterna del mio cuore e della mia anima. Ma l’amore, a un senso o a due, non basta, la mia vita è cambiata e con essa le mie aspettative. Ero arrivato per tornare, senza realmente mai voler star lontano dalla mia terra, e mi sono ritrovato a sognare casa ovunque essa fosse. Casa, un posto accogliente dove ti spogli di tutto per lasciare te stesso.
Napoli accoglie, e scaglia pietre di ignoranza grosse come la montagna che sovrasta il golfo, ma a casa nessuno si accorge che sei nero, nessuno ti tratta da straniero, nessuno ti compatisce. A casa ti amano e basta. Pensavo a mia figlia, al posto in cui avrei potuto portarla per farle vivere la sua diversità come normalità, volevo una casa in cui a fare da padri e da madri fossero le persone.
Perciò nasce Teranga. Una parola che proviene dal wolof, lingua nazionale del Senegal. Una parola che significa Accoglienza, ma nel senso più ampio del termine: se vieni a casa mia il mio pasto è tuo, il mio letto altrettanto. Ho scelto questo termine perché toglieva ogni barriera nell’accogliere, non esistono classifiche quando si hanno le braccia aperte. Così nasce Teranga, umilmente e senza mobili. In un vicoletto stretto tra le strade di Napoli. Nasce dunque, e presto si riempie di fratelli e sorelle. Portando avanti le regole per cui ogni essere si riflette nel suo simile, e preferendo al successo la fratellanza. Ci siamo aperti al mondo, togliendo ogni velleità d’odio e coltivando l’amore attraverso la semplicità, la cultura, la musica, l’ascolto. Dando assistenza, ma anche donando speranza, affiancando e accogliendo. Non per dare un esempio, ma perché sappiamo bene cosa avremmo voluto e, pertanto, vogliamo restituirlo a chi ne ha necessità.
Presto Teranga è divenuto ciò che si proponeva di essere: un punto di riferimento per chiunque.
Questo racconto continua su Left in edicola dal 13 agosto