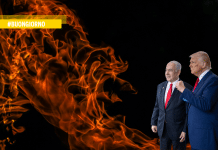In Etiopia i “Paesi amici” – primo fra tutti l’Italia – stanziano fondi per gli aiuti internazionali e investono nell’industria agroalimentare, ignorando le pratiche antidemocratiche del governo di Hailè Mariam Resaleng e distruggendo le comunità locali e l’ambiente.
È quanto riporta il rapporto Che cosa nasconde la Valle dell’Omo? redatto dall’associazione italiana Re:Common in seguito a una missione sul campo che gli autori hanno definito «forzatamente “monca”», per il rifiuto dell’accesso da parte del governo ad alcune zone, come la valle attraversata dal fiume Omo, una delle più frequentate dalle aziende straniere.
In mancanza di contatto diretto con alcuni luoghi importanti per la ricerca, i ricercatori Giulia Franchi e Luca Manes hanno fatto ricorso a testimonianze locali anonime che hanno tracciato un quadro umanitario sconfortante, sia per la violazione dei diritti delle comunità locali costrette a migrare da un giorno all’altro, sia per la repressione del dissenso, sia per il controverso ruolo di enti stranieri pubblici e privati sul territorio, come la Banca Mondiale, la Commissione Europea, i Ministeri e le aziende private.
Per quanto riguarda il nostro Paese, gli autori parlano del “Sistema Italia” in termini di grave responsabilità della cooperazione e dell’industria italiana, che è la prima in Etiopia per numero di accordi e fondi stanziati (dopo l’Afghanistan).
Secondo gli autori del rapporto, l’Italia continua a cercare il suo “posto al sole” all’estero, senza curarsi delle condizioni di democrazia dei paesi in cui investe e si arricchisce, «a suon di contratti per grandi infrastrutture (preferibilmente senza gare d’appalto), di interventi militari a difesa degli interessi di pochi e mascherati da missioni di pace, pompando petrolio e gas, e vendendo armi a regimi repressivi. Il tutto tappandosi poi gli occhi su dove e come quelle stesse armi verranno usate. Tanto poi ci pensa la nostra gloriosa ed empatica cooperazione allo sviluppo alla ricostruzione».
La Valle dell’Omo è una zona di 25 mila chilometri quadrati che prende il nome dal fiume che la attraversa, dove vivono 700 mila persone appartenenti a 16 gruppi etnici distinti. Il fiume Omo è al centro della sopravvivenza delle comunità locali, per l’approvvigionamento dell’acqua e per l’effetto fertilizzante del limo sul terreno dopo le esondazioni annuali.
Secondo alcune fonti protette da anonimato, nella zona dell’Omo è in atto lo stesso esodo di popolazione che ha visto la zona ovest della Gambella spopolarsi nel 2012, quando 70 mila persone sono state cacciate dalle loro terre per lasciare spazio alle industrie agroalimentari.
«Nella Valle – dichiarano gli autori del report – è in corso uno degli accaparramenti di terra più feroci dell’Africa che produce un processo di “villaggizzazione” forzato», pagato anche dalla cooperazione internazionale, che impone alle comunità locali il ricollocamento forzato in altre zone e punisce chi non accetta di abbandonare le terre con arresti e uccisioni arbitrarie.
Il governo di Hailè Mariam Resaleng è considerato uno stimato alleato dell’Occidente e un importante avamposto politico contro l’integralismo islamico, ma il suo rapporto con l’opposizione e il dissenso è discutibile: basti pensare che nel 2010 ha ottenuto il 99,6 per cento dei voti a favore e nel 2015 il 100 per cento.
Secondo Human Rights Watch a novembre 2015 il governo avrebbe ucciso 140 persone e ne avrebbe arrestate altre migliaia per sedare le proteste contro l’espansione dell’amministrazione di Addis Abeba nella regione limitrofa di Oromia. Il ministro delle Comunicazioni Getachew Reda – riporta Re:Common – ha commentato questo rapporto minimizzando i danni della protesta e accusando Human Rights Watch di «compilare report dall’altra parte del pianeta, senza conoscere i fatti realmente».
Secondo i dati del rapporto, nel mese di ottobre di quest’anno si sono verificati 1600 arresti a seguito delle proteste della tribù degli Oromo, nel 2014 45 oppositori del progetto Omo-Kuraz sono stati uccisi e nel 2015 hanno fatto la stessa fine 39 persone della tribù degli Odi.
Sia sul fronte interno che esterno, la retorica governativa tende a stigmatizzare chi punta ancora il dito contro l’Etiopia considerandola un Paese arretrato e autoritario, accusando i detrattori di eccedere di ideologia se non addirittura di perseguire “deplorevoli secondi fini“.
Il sistema di aiuti allo sviluppo, da cui l’Etiopia dipende al 60 per cento, dal 2010 tra trovato spazio nell’economia del Paese grazie al Piano di Crescita e Trasformazione varato dal governo, che prevede la costruzione di grandi impianti infrastrutturali (dighe) e di sviluppo agroindustriale, al fine di entrare in tempi brevi tra i paesi a medio reddito.
Il Piano prevede lo sfruttamento intensivo delle terre a fini industriali, la sedentarizzazione forzata delle comunità locali di agricoltori e allevatori e l’azzeramento delle terre da pascolo come condizioni ideali per favorire la modernizzazione dell’agricoltura.
Sul territorio etiope sono presenti numerose aziende agroalimentari locali e soprattutto straniere: oltre alla piantagione governativa di canna da zucchero Omo-Kuraz Sugar, opera l’italiana Fri-El Green che produce olio di palma e jatropha (un olio vegetale), la turca Omo Valley Farms Cooperation Plc. (coltivazioni), l’indiana Whitefield Cotton Farm Plc, l’italo-etiope OMo Ethio Renewable Energy Pls e l’etiope Sisay Tesfaye Agro Processing.
Per quanto riguarda l’italiana Fri-El Green, che è la più grande della zona (gestisce 30 mila ettari di terreno), fonti locali riportano che l’azienda – da contratto – avrebbe dovuto assicurare alle popolazioni locali pozzi, assistenza sanitaria e scuole, ma nessuno di questi servizi è stato realizzato, tanto che per ricevere cure mediche gli abitanti devono percorrere anche 60 chilometri. In teoria, inoltre, sarebbe anche previsto un risarcimento governativo in caso di uso di terreni sottratti alle comunità locali e le aziende dovrebbero assumere nel personale una buona percentuale di abitanti delle comunità locali. Stando alle testimonianze, nessuna di queste buone pratiche è stata messa in atto finora.
L’esiguità sempre maggiore di terreni a disposizione può, inoltre, creare situazioni di tensione interetnica e transfrontaliera, come è accaduto al confine con il Kenya dove 540 persone hanno perso al vita e altre 65 mila sono sfollate per il conflitto tra i Turkana del Kenya, i Dassaneeh e i Nyangatom dell’Etiopia.
Per diventare il primo produttore di energia idroelettrica dell’Africa, il governo etiope ha appaltato alla società italiana Salini Impregilo la costruzione di un sistema di dighe, le Gibel Gibe, lungo il fiume Omo.
Nel 2004 l’Italia ha stanziato un finanziamento senza precedenti (200 milioni di euro) per la costruzione di Gibel Gibe II, che ha beneficiato di aiuti pubblici da parte del Ministero degli Esteri tramite il Fondo Rotativo per lo Sviluppo. Le dighe, che diventeranno cinque a breve (ora sono tre), – riporta Re:Common – sono state periodicamente citate dai politici italiani come esempi di eccellenza italiana all’estero: nel 2010 il ministro degli Esteri Franco Frattini ha inaugurato la Gibel Gibe II e nel 2015 il premier Matteo Renzi ha presenziato alla presentazione della Gibel Gibe III definendolo “orgoglio italiano”, e, proprio mentre la Survival International (che si occupa di diritti dei popoli nativi) presentava istanza all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) contro la Salini Impregilo per la costruzione della terza diga, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si augurava “tante Salini”.
Secondo le associazioni che si battono per la difesa del territorio, la costruzione delle dighe sul fiume Omo, oltre a sottrarre a intere comunità le loro terre ancestrali, creerà un’inondazione che sommergerà i territori delle tribù della Valle e ridurrà il livello del lago Turkana in Kenya (il più grande lago desertico del mondo), creando una catastrofe ambientale che coinvolgerà 500 mila persone tra etiopi e kenioti.
Gli autori del rapporto concludono che il sostegno acritico dei donatori e di investitori internazionali al Piano di Crescita e Trasformazione e l’adesione al sistema di aiuti allo sviluppo contribuiscono al rafforzamento di pratiche antidemocratiche e repressive del governo attuale. Inoltre, la partecipazione dell’Italia a progetti di sviluppo e di industrializzazione in paesi come l’Etiopia e l’Egitto «è il segno dell’adesione a una logica puramente economica, che mette in secondo piano i diritti principali, come dimostra il caso emblematico di Giulio Regeni».
A proposito di interessi economici in Egitto, il dossier rammenta la visita del generale Fattah al Sisi nel nostro Paese subito dopo il colpo di Stato militare a conferma di un'”amicizia” già sancita con la firma da parte dell’Eni di un contratto record da 850 milioni di euro per l’estrazione del gas nel giacimento egiziano di Zhor.
«Con esecutivi amici come l’Etiopia, l’Egitto e l’Arabia Saudita – conclude il rapporto – è sempre più evidente che il nostro governo mira all’efficacia della sua politica estera in base all’andamento dei bilanci delle grandi multinazionali italiane del petrolio, delle infrastrutture e delle armi. Il rispetto dei diritti umani è ormai un elemento secondario purtroppo».