Un essere umano si fa umano quando si pone di fronte alla morte, ci dicono da secoli filosofi, poeti, antropologi, storici. La morte ci scuote e ci fa umani; e di conseguenza pensiamo che è proprio l’indifferenza nei confronti della morte a segnare la perdita di umanità da parte degli umani, degradati al rango di cose. La morte, però, per scuoterci deve essere visibile ai nostri occhi, presente ai nostri sensi. Dobbiamo, per così dire, toccarla con mano, nella sua concretezza.
Ma quando gli eventi si trascinano nel tempo indefinitamente, e per giunta accadono fuori dalla nostra portata, finiamo per assuefarci perfino alla morte, e non pensarci più. Ogni tragedia diventa una cosa normale, ridotta al rango di una quotidianità automatica, e scompare dall’orizzonte della nostra coscienza. Come un rumore di fondo costante che non udiamo più – e perciò, scomparso alla coscienza, smette di esistere del tutto.
Il solo modo per riportarla al nostra coscienza è tornare a toccarla con mano, nella sua concretezza, ovvero nella sua individualità. Così, quando una singola storia trapassa il muro del silenzio, ci ricordiamo che sì, in quel luogo del mondo si continua a morire, che una tragedia è in corso, che una lotta viene portata avanti, ed è un evento che merita la nostra attenzione, e il nostro sostegno.
Così è nel caso dei curdi, e delle curde. Per questo motivo avevo deciso, tre anni fa, di far romanzo della vita e della morte di una comandante guerrigliera curda, Avesta Harun.
Pochi giorni fa è arrivata la notizia della morte di una giovane guerrigliera di 24 anni, caduta nell’offensiva che i curdi di Ypj e Ypg (le unità combattenti dei curdi siriani) stanno portando avanti per riconquistare Raqqa, la città più importante del presunto “Stato islamico” nei territori siriani. Si chiamava Ayse Deniz Karacagil, ma era da tutti conosciuta come Cappuccio rosso, e in Italia era stata resa celebre dal fumetto di Zerocalcare Kobane calling. Lei non era curda, in realtà, ma una comunista turca che, durante i giorni di Gezi park, aveva resistito alla ormai evidente tirannia di Erdogan, e che, in carcere, aveva conosciuto donne curde che facevano parte delle unità combattenti del Pkk.
Una storia, dunque, che ci fa tornare con la mente e con il cuore in un luogo del mondo dove si vive per degli ideali, valori che si tratta di affermare a costo della propria vita, e ci fa comprendere che la lotta dei curdi non è solo la lotta di liberazione di un popolo, ma la lotta per dei valori universali, che riguardano tutta l’umanità, ed è per questo che persone come Ayse si sono unite a quella lotta. Tra questi valori, centrale – e senza dubbio determinante per la scelta di Ayse – è quello dell’emancipazione della donna come necessariamente preliminare all’emancipazione del genere umano.
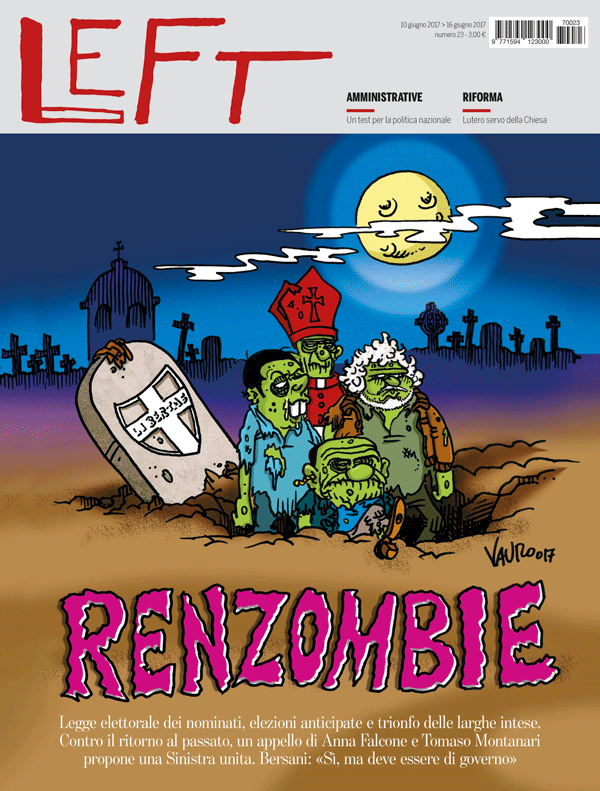
L’articolo prosegue sul numero di Left in edicola
SOMMARIO ACQUISTA





