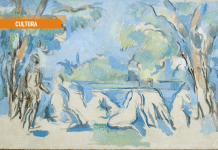In vita fu denigrato dalla critica e contestato dal pubblico benpensante. Ma l’opera del colto e dirompente Édouard Manet ha conosciuto nell’ultimo secolo il giusto riscatto, conoscendo un successo e una attenzione crescenti. Merito anche del suo modo “modernissimo” di rappresentare le donne, di indagarne la psicologia e il narcisismo, in tutte le sue sfumature, dando forme e colori alla bellezza consapevole di sé delle parigine, ma anche raccontando lo sguardo apparentemente sfrontato, ma al fondo drammaticamente freddo, delle prostitute, obbligate a vendere il proprio corpo.
Manet è stato forse il maggiore interprete della vita nella Parigi della seconda metà dell’Ottocento, ne ha saputo rappresentare la vivacità intellettuale e lo scandalo, denunciando silenziosamente l’ingiustizia che colpiva le donne, di cui sosteneva l’emancipazione, seppur dal punto di vista di un alto borghese e impenitente seduttore.
Lo racconta bene la mostra milanese Manet e la Parigi moderna, aperta fino al 2 luglio nelle sale di Palazzo Reale, percorsa da vari fili rossi: la metropoli, l’universo femminile, l’attrazione per la cultura spagnola, il mare. Attraversate le sale abbaglianti che precedono la mostra, dedicate a una esposizione di diamanti, si scivola ancor più volentieri nel buio delle sale dove compaiono come improvvise epifanie l’affascinante ritratto della pittrice Berthe Marisot, eleganti autoritratti in inchiostro al chiaro di luna, visioni di mare in tempesta solcato da una piccola barca in fuga. Un percorso affascinante di luci e ombre, molto teatrale, attraverso opere del Museo d’Orsay selezionate dai curatori Guy Cogeval, Caroline Mathieu e Isolde Pludermacher che nei loro saggi (pubblicati nel catalogo Skira) approfondiscono la genesi colta dei dipinti di Manet e la spregiudicatezza espressiva trasmessa dal libero accostamento dei colori. Una licenza poetica che scatenò le negazioni violente di commentatori e colleghi invidiosi.
Il pubblico borghese dei Salon nel 1865 giudicò l’Olympia di Manet uno scandalo: troppo dirompente troppo reale e presente. Come ricorda Lauretta Colonnelli in Cinquanta quadri (Edizioni Clichy) ricostruendo la vicenda della pittrice e modella Victorine Meuren che si prestò a interpretare la parte della prostituta nel quadro per essere poi scambiata dal pubblico per una prostituta vera. Difficile comprendere allora il dirompente realismo di Manet che non era copia della realtà, ma creazione di immagine che poi risultava più vera del vero. Con tutto ciò che faceva scattare nell’intimo di chi guarda. Quello di Manet era il rassicurante impressionismo di Claude Monet, con i suoi laghi di ninfee né un realismo alla Courbert che non andava oltre la figurazione razionale. Nel 1963 dell’Olympia il pittore impressionista disse che «sembrava la regina di picche appena uscita dal bagno».
In quello stesso anno, Édouard Manet aveva dipinto anche Le déjeuner sur l’herbe dove apparentemente riprendeva il tema del Concerto campestre di Tiziano rappresentando una giovane prostituta nuda sulle rive della Senna con due studenti vestiti di tutto punto. Qui a scatenare lo scandalo, più che il nudo in sé (che già compariva nel precedente rinascimentale) fu l’aver citato modelli alti e antichi togliendo loro ogni “aura”. Come rileva Federica Rovati ne L’arte dell’Ottocento (Einaudi, 2017) ciò che fece arricciare il naso agli organizzatori del Salon che rimandarono indietro il quadro fu «l’onta» di un’opera piena di citazioni a partire dall’incisione di Marcantonio Raimondi tratta dal Giudizio di Paride di Raffaello «abbassando i prestigiosi prototipi a un livello banale, anzi volgare, anziché trasfigurare la realtà su un piano ideale». Evidentemente erano abbastanza colti da cogliere tutte le citazioni ma non abbastanza sensibili da comprenderne il senso.

La copia della Venere di Urbino è tutt’altro che un esercizio accademico: la libertà di tocco e l’eliminazione di alcuni dettagli ne fanno tutt’altro che una riproduzione servile e «fotografica». L’artista trasforma il soggetto emulato lo immette in una nuova visione. Colpisce l’imprevedibilità dei percorsi iconografici di Manet, colpiscono gli accostamenti analogici con i quali sconvolge ogni gerarchia dei generi e «le regole del decoro». Tutto questo appare evidentissimo a Milano davanti a Il balcone, un quadro di Manet tradizionalmente abbinato a Goya e che per l’atmosfera sospesa richiama le Due Dame veneziane di Carpaccio (una precedente mostra curata da Cogeval esplicitava questo nesso) ma lo scrittore Gautier quando vide questa intrigante creazione del 1868 se ne uscì dicendo: «L’artista era in concorrenza con gli imbianchini», stigmatizzando il colore verde del balcone che riprende le persiane, senza guardare alla sinfonia del verde, del bianco, con il rosso del ventaglio di Berthe e del fiore giallo nei capelli della giovane violinista Fanny Claus.
Manet si muoveva su un filo di ricerca continua: «Non ripetere mai il giorno appresso ciò che si è fatto il giorno prima, essere sempre ispirato da qualcosa di nuovo». Così la pittrice e poi cognata Berte Marisot ritratta in questa scena spagnoleggiante appare completamente diversa nel bellissimo ritratto di Berthe con il mazzo di violette (1872). Ancora diversi, forse un poco più freddi, i ritratti degli amici pittori del Caffè Guerbois, dell’amico Zola (con sullo sfondo alcune stampe giapponesi che per Manet furono una preziosa fonte di ispirazione) e quello quasi in dissolvenza di Stéphane Mallarmé, che Manet aveva conosciuto nel 1873. Il poeta e amico lo difese in un lungo articolo sostenendo che Manet era l’unico artista che aveva aperto ad una via nuova impressionisti ai quali rifiutò sempre la propria adesione a proclami. «Monet ama l’acqua, di cui sa rendere in special modo la mobilità e la trasparenza, sia essa di mare o di fiume» notava Mallarmé. «Sisley fissa i momenti fuggitivi della giornata, osserva una nube che passa e sembra dipingerla nel suo volo… Pissarro, il più anziano dei tre, ama l’ombra densa dei boschi, l’estate, le terre rigogliose, e non teme l’impasto che, talvolta, serve a rendere l’aria visibile come bruma luminosa, satura di raggi solari. Non è raro che uno dei tre batta sul tempo Manet, il quale poi, percependo d’un tratto il risultato o l’intenzione, sintetizza tutte le loro idee in un’opera magistrale e definitiva».