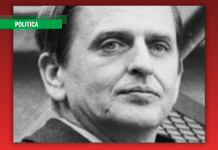Il 26 gennaio, ma nel 1838, un gruppo di poliziotti, – per ordine del governo coloniale e del comandante maggiore James Nunn -, attaccò il campo di Kamilaroi a Waterloo Creek, Australia, uccidendo quaranta persone. Un massacro di indigeni. Omicidio, stupro, violenza: perché si doveva fare spazio alle fattorie dei coloni bianchi, i terreni andavano “ripuliti”. Cento anni dopo, nel 1938, il 26 gennaio, un gruppo di aborigeni cominciò a protestare davanti al municipio di Sydney. Per diritti pari, per essere eguali davanti alla legge, nella società. Perché, dicevano i loro striscioni, “aborigines claim citizen rights!”, gli aborigeni vogliono diritti simili a quelli degli altri cittadini. Chiedevano uguaglianza.
Il 26 gennaio del 1988 persone da tutta l’Australia si diedero appuntamento nella capitale per “la lunga marcia per la giustizia, la pace, la speranza”. E soprattutto per ricordare al governo australiano che “loro avevano rubato la nostra terra”, come disse Michael Anderson, un membro della tribù Kamilaroi. Siamo nel 2018, 26 gennaio, 60mila uomini e donne scendono per strada in tutto il Paese, in onore di quel passato di resistenza dei nativi, vogliono che venga messa fine “alla politica razzista”. Il 26 gennaio per loro è diventato il giorno in cui alzare la voce per i diritti dei popoli aborigeni. Quest’anno hanno marciato da Sydney a Canberra, da Brisbane ad Adelaide. Fino a Perth. Non si vedeva questa mobilitazione di massa dagli anni 70. Non è la Giornata nazionale dell’Australia, come vorrebbe il governo, è l’Invasion Day, la giornata dell’invasione.
Il giorno del 26 gennaio infatti è stato scelto come “Giornata dell’Australia”, ma è l’anniversario di un assassinio collettivo di indigeni. È una data che per molti australiani va cambiata, una celebrazione che ricorda solo il sangue del massacro. Ogni gennaio i quotidiani lo ricordano a titoli cubitali, tanto che il primo ministro Malcolm Turnbull è dovuto tornare sulla questione: questa campagna stampa ha reso «il giorno che dovrebbe unire l’Australia e tutti gli australiani un giorno che ci divide, un paese libero dibatte la sua storia, non la nega». La valanga di critiche dalla comunità indigena non si è fatta attendere: il 26 gennaio merita protesta, manifestazione, non celebrazione.
Un anno fa, nel 2017, con i colori ancestrali, – giallo, rosso e nero -, si marciava in segno di disappunto a Melbourne, in migliaia in solidarietà con gli aborigeni. La gente urlava no pride in genocide, nessun orgoglio per il genocidio, always was, always will be aboriginal land, questa è sempre stata e sempre sarà terra aborigena, per ricordare il sangue versato da chi abitava l’Australia prima dell’arrivo dei coloni bianchi. Celebrare ancora questa giornata, il 26 gennaio, come festa nazionale, vuol dire negare quella tragedia, «negare la sovranità calpestata degli indigeni, queste cose non vengono analizzate nel dettaglio dal nostro Paese», ha detto Celeste Liddle, organizzatrice della “marcia del giorno dell’invasione”. L’anno scorso alla marcia c’erano 20mila persone, nel 2018 sono almeno il triplo.
“Una marcia contro l’invasione” è stata organizzata in ogni Stato australiano. Il premier «Turnbull non prende parte a questo dibattito, anzi lo evita», continua Celeste. Il massacro di Waterloo Creek è uno dei 150 massacri registrati, ma molti sono stati unreported, mai riportati. Il primo di cui si hanno tracce risale al settembre del 1874, sei anni dopo l’arrivo della prima flotta a Sydney Cove, quella che dichiarò l’Australia colonia britannica. La lista dei massacri dei nativi per mano di soldati, per mano di prigionieri, per mano dei coloni bianchi è lunga, ma sarebbe lunghissima se ci fossero tutte le testimonianze, le prove necessarie. È la storia non raccontata dell’Australia, che gronda sangue. Il numero esatto di nativi uccisi rimane sconosciuto, più di 64mila indigeni furono uccisi dal 1788 al 1930 solo nel Queensland. Raccogliere i dati oggi, tanti anni dopo, è impresa impossibile, ma qualcuno la tenta.
Nel 1838 quando i soldati tornano a Sydney da Waterloo Creek furono accolti come eroi, ci fu un processo, ma nessuno fu condannato. Anzi. Come riporta un giornale dell’epoca, in tribunale un soldato disse che «so bene che siamo colpevoli di omicidio, ma io non ho mai visto un bianco soffrire perché si sparava a un nero».
Cambiare la data della Giornata dell’Australia non cambierà la storia, ma almeno, dicono gli organizzatori della marcia dell’invasione, aiuterà a non negare la verità, a scriverla di nuovo: la mitologia della nuova, moderna Australia è nata nel sangue degli indigeni, dei nativi. Come ha detto ancora la Liddle «gli aborigeni non marciano perché non sono contenti della data della celebrazione, noi marciamo perché ci opponiamo alla celebrazione di quell’invasione. Stiamo combattendo per una causa più profonda qui». È impossibile che in questa data, – il 26 gennaio- , che per alcuni è lutto nazionale, il Paese si unisca sotto un solo simbolo, sotto un’unica bandiera, un solo colore, in nome dell’amore per una patria che ha dato la morte invece che la libertà a parte della popolazione che ancora la abita.
«Chiederci di celebrare il 26 gennaio è come chiederci di ballare sulle tombe dei nostri antenati» ha reso noto Reconciliation Australia, un’organizzazione indipendente: «è una festa nazionale dal 1994, è una data che è stata già cambiata, bisognerebbe farlo di nuovo, se vogliamo davvero raggiungere unità tra tutti gli australiani». Linda Byrney, deputata laburista, prima donna indigena eletta a rappresentare il popolo al governo, non è “un’abolizionista”, – come vengono chiamati quelli che vogliono cancellare questa data dal calendario -, ma ha detto che è il giorno in cui pensare davvero «e profondamente alla verità, alla vera storia di questo Paese». Solo quando verrà riconosciuta e detta ad alta voce, forse, ci sarà davvero qualcosa da celebrare.