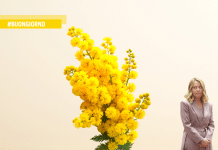Tra i numerosi, e riuscitissimi, aforismi di Ennio Flaiano ce n’è uno che si è rivelato un po’ meno indovinato degli altri: «Capire la Cina non è soltanto noioso, ma inutile». Così scriveva il grande giornalista e critico cinematografico abruzzese sull’Impero Celeste nel Frasario essenziale per passare inosservati in società. Più lungimirante si è invece dimostrato Napoleone Bonaparte che nel lontano 1816 disse: «Lasciate dormire la Cina perché al suo risveglio il mondo tremerà». Anche se nato come commento di natura militare, l’opinione del generale francese si è avverata sul piano economico. Ed è quindi quanto mai importante, e utile, cercare di capire la Cina e la sua sorprendente ascesa nel mercato globale, tra innegabili successi e altrettante contraddizioni. Nei giorni che vedono milioni di lavoratori spostarsi per tornare alla loro città d’origine per festeggiare il Capodanno Cinese, la festività più importante del Paese equivalente al nostro Natale e che quest’anno cade il 16 febbraio, abbiamo incontrato un affermato studioso italiano, Ivan Franceschini, che sulla Cina ha scritto nel 2016 un piccolo ma prezioso libro, ancora attuale: Lavoro e diritti sulla in Cina. Politiche sul lavoro e attivismo operaio nella fabbrica del mondo (ed. Il Mulino), nato come risultato del progetto sul lavoro cinese in prospettiva globale al quale ha lavorato come Marie Curie Fellow all’Università Ca’ Foscari di Venezia e all’Australian Centre on China in the World di Canberra.
Una domanda preliminare ma necessaria. È ancora corretto definire la Cina come la “fabbrica del mondo”, alla luce dell’incremento medio dei salari dei lavoratori e dell’aumento delle produzioni ad alto contenuto tecnologico delle industrie cinesi?
È vero che i salari in Cina – e più generalmente il costo del lavoro – sono cresciuti molto negli ultimi anni sull’onda dell’adozione di una serie di nuove leggi e regolamenti sul lavoro, ed è anche vero che i lavoratori cinesi hanno tratto vantaggio dai cambiamenti demografici in atto nel Paese, con il loro potere contrattuale rafforzato dall’emergere di quella che è stata definita come una vera e propria ‘carestia di migranti’. Allo stesso tempo, le autorità cinesi hanno lanciato imponenti campagne per l’upgrade industriale nel tentativo di scrollarsi di dosso la reputazione di ‘fabbrica del mondo’. Tuttavia, a dispetto dei progressi in questo senso, e nonostante un numero sempre maggiore di aziende in settori ad alta intensità di lavoro stia trasferendo la produzione dalla Cina ad altre aree dove i costi sono inferiori, la Cina rimane tuttora il centro della manifattura globale.
Negli ultimi mesi, tra novembre e dicembre del 2017, la stampa internazionale ha dato ampio spazio alle notizie degli sgomberi dei lavoratori migranti (per lo più contadini) a Pechino. Secondo le ultime stime sono circa 273 milioni, e vivono in condizioni di estrema precarietà dovuta al mancato ottenimento della registrazione (hukou) nella città dove lavorano, e senza la quale non si ha accesso ai diritti essenziali come l’assistenza sanitaria e l’istruzione. Il motivo ufficiale degli sgomberi è stato la scarsa sicurezza delle case nelle quali abitavano. Ci sono a suo avviso motivi meno nobili dietro la decisione dell’amministrazione pechinese?
In realtà, il dramma che si è svolto alla fine del 2017 è stato il culmine di un lungo processo. Già nel marzo del 2014, un piano ufficiale per la ‘nuova urbanizzazione’ rilasciato dalle autorità centrali cinesi richiedeva l’adozione di severe misure restrittive per contrastare i flussi migratori verso le megalopoli con più di cinque milioni di abitanti. Tre anni dopo, nell’aprile del 2017, le autorità di Pechino hanno annunciato l’intenzione di limitare la popolazione della capitale – che allora si aggirava intorno ai 22 milioni di persone – a non più di 23 milioni entro il 2020. Questo avveniva nel mezzo di piani per riqualificare ampie aree della città che prevedevano l’abbattimento di decine di milioni di metri quadrati – 30 milioni nel 2016, altri 40 milioni nel 2017 – di costruzioni illegali, soprattutto piccoli negozi, ristoranti, bancarelle gestite da migranti. Nell’estate del 2017 ha fatto notizia in Cina l’annuncio che alcuni villaggi ai margini di Pechino – località che ospitano quei lavoratori migranti che non possono permettersi un alloggio nella capitale – avrebbero iniziato a richiedere alla popolazione non locale di pagare una cifra esagerata come una sorta di tassa di soggiorno. Dichiaratamente, questi soldi sarebbero stati usati non solo per coprire i costi dei servizi e della pubblica sicurezza, ma anche per raggiungere l’obiettivo di avere zero migranti all’interno del villaggio. È stato in questo contesto che nel novembre del 2017, quando un incendio in una palazzina alla periferia di Pechino abitata soprattutto da migranti ha causato la morte di diciannove persone, le autorità cinesi hanno colto la palla al balzo per iniziare un’opera generale di ‘pulizia’ di quelli che sono stati definiti gli “strati inferiori della popolazione”. La situazione è presto sfuggita di mano, e nessuno si aspettava la risonanza che la vicenda avrebbe ottenuto a livello mediatico, tanto in Cina quanto all’estero.
Nel suo libro dà conto del cosiddetto “risveglio dei diritti” messo in atto dai lavoratori migranti, in particolar modo da parte dei “migranti di nuova generazione”, generalmente più giovani ed istruiti, lontani dalla dicotomia “sfruttamento/resistenza” con la quale tradizionalmente in Occidente si è sempre inquadrato il lavoratore cinese. Si può parlare, a questo proposito, di una rottura con il passato in direzione di una maggiore consapevolezza dei diritti?
Quello che propongo nel mio libro è in realtà una critica dell’idea del “risveglio dei diritti”. Nell’ultimo decennio si è scritto molto su questo presunto ‘risveglio’ dei lavoratori cinesi, in particolare in occasione di alcuni specifici episodi di mobilitazione operaia in cui i lavoratori hanno avanzato rivendicazioni salariali che andavano ben oltre quanto avevano diritto per legge. Stando a questa narrazione, protagonista della nuova ‘ondata’ di attivismo sarebbe stata la cosiddetta ‘nuova generazione di migranti’, vale a dire quei lavoratori di origini rurali nati negli anni Ottanta e Novanta. Se questi nuovi lavoratori indubbiamente presentano elementi di rottura con il passato in termini di identità, aspettative e abitudini di consumo, presentarli come il motore della lotta operaia in Cina è, a mio avviso, un’esagerazione. Negli ultimi anni, la maggior parte delle proteste dei lavoratori in Cina ha avuto luogo per il mancato pagamento dei contributi previdenziali, oppure in risposta a decisioni aziendali di chiudere gli impianti e rilocare la produzione altrove. A giocare un ruolo fondamentale in questi episodi sono stati lavoratori più anziani, più esperti e maggiormente preoccupati per il proprio futuro post-lavorativo. Da questo punto di vista, l’idea che i giovani migranti siano più attivi è come minimo una semplificazione. Più in generale, l’idea stessa che in Cina stia avendo luogo un ‘risveglio’ dei lavoratori dovrebbe essere presa con le pinze. Se, come dicevo, non mancano episodi in cui lavoratori si sono mobilitati per i propri interessi – in contrasto con la grande maggioranza dei casi di sciopero, in cui i lavoratori si limitano a rivendicare diritti già concessi per legge – questo non è automaticamente indicativo di una tendenza più generale.
A seguito della ricerca che ha svolto sul campo, tra il 2012 e il 2015, con più di 1300 interviste ai lavoratori in 3 diverse città cinesi, a proposito del sindacato conclude: «Quasi i due terzi degli intervistati ignorava o non aveva un’idea chiara del ruolo del sindacato». Quale ritiene sia la causa di questa “irrilevanza” del sindacato cinese e quali sono le conseguenze maggiori per i lavoratori?
In una più recente ricerca che ho realizzato su un campione di lavoratori nel settore tessile ho riscontrato un dato ancor più sorprendente: il 28 percento dei miei 250 intervistati non aveva mai sentito prima la parola cinese per sindacato (gonghui). Questa irrilevanza è dovuta alla struttura stessa del sindacato cinese. In Cina ancora oggi è permesso un solo sindacato, la Federazione nazionale dei sindacati cinesi (Fnsc). Si tratta di un’organizzazione colossale, che nel 2017 contava oltre trecento milioni di membri – quanti dei quali fossero consapevoli di esserne parte non saprei dire. Prima che un sindacato, la Fnsc rimane una tradizionale organizzazione di massa, pensata per funzionare come cintura di trasmissione leninista tra Partito e lavoratori – e non sono parole mie, ma è la retorica usata dai massimi dirigenti cinesi in ogni occasione ufficiale. Se negli ultimi tempi la Fnsc ha dedicato parecchie risorse all’assunzione di personale in grado di fornire assistenza legale nel caso di dispute lavorative, a livello aziendale il sindacato ufficiale si occupa soprattutto dell’organizzazione di attività ricreative per i dipendenti. In molti casi, sebbene sia proibito per legge, i quadri della sezione sindacale aziendale spesso sono manager o parenti dei datori di lavoro e il sindacato aziendale è stabilito solamente pro forma, in risposta a richieste giunte dall’alto. In un contesto simile, c’è ben poco da stupirsi se i lavoratori cinesi non hanno un’idea chiara di cosa sia un sindacato. La conseguenza più evidente dell’assenza di un sindacato indipendente in Cina si riscontra nel fatto che, nel caso di una disputa lavorativa, la maggior parte dei lavoratori cinesi, piuttosto che lottare, sceglie di dare le dimissioni e cercare una nuova occupazione. Senza sindacati indipendenti, per i lavoratori cinesi è molto più difficile – anche se non impossibile – organizzarsi per portare avanti le proprie rivendicazioni, tanto più qualora si renda necessaria una lotta sostenuta nel tempo.
Oltre al sindacato ufficiale, in Cina sono presenti molte Ong del lavoro nate a partire dalla seconda metà degli anni Novanta. Il numero così alto di organizzazioni “non riconosciute” cosa ci dice sul mondo del lavoro cinese?
In realtà, il numero di queste organizzazioni è tutt’altro che alto. Si tratta al massimo di qualche dozzina di organizzazioni, concentrate per lo più nella provincia del Guangdong e in poche altre metropoli costiere, nulla in confronto al numero di lavoratori migranti in Cina e ai loro bisogni. Se non altro, l’esistenza di queste organizzazioni ci racconta del fallimento del tentativo delle autorità cinesi di affidare la rappresentanza dei lavoratori al sindacato ufficiale. Queste Ong infatti giocano un ruolo fondamentale di intermediazione tra i lavoratori e il sistema giuridico cinese, assistendo i lavoratori cinesi là dove le istituzioni preposte a questo scopo falliscono. In alcuni casi, negli ultimi anni, queste Ong si sono spinte al punto di intervenire in dispute collettive, spiegando ai lavoratori come eleggere i propri rappresentanti per avviare una contrattazione collettiva con il proprio datore di lavoro. È stato proprio questo approccio militante che alla fine del 2015 ha portato le autorità cinesi a lanciare un nuovo, pesantissimo giro di vite contro queste organizzazioni. Le Ong del lavoro oggi si trovano ad affrontare difficoltà enormi, tanto per le crescenti difficoltà ad accedere a finanziamenti stranieri – per ovvie ragioni, non esistono forme di finanziamento locali – quanto per il controllo sempre più soffocante delle autorità cinesi sulle loro attività.
Con l’ascesa al potere di Xi Jinping, e con una Cina sempre più proiettata all’estero con interventi infrastrutturali faraonici quali la costruzione della Nuova Via della Seta, si registra qualche miglioramento sul fronte dei diritti dei lavoratori? Si può sostenere, insomma, che il grande sviluppo economico possa contribuire anche allo sviluppo dei diritti? O è solo un auspicio per il futuro?
La vicenda degli sgomberi a Pechino dimostra che sviluppo economico e diritti dei lavoratori non necessariamente vanno di pari passo. In assenza di un movimento dei lavoratori forte e organizzato, ogni avanzamento sul fronte dei diritti rimane sacrificabile. In fondo, i diritti dei lavoratori in Cina sono pur sempre una concessione dall’alto, un ‘regalo’ del Partito alle masse, non una conquista, il che è una differenza non da poco. Per quanto riguarda la Nuova Via della Seta, sebbene mezzo mondo sia intento a discutere – spesso con toni sicofantici – di come approfittare di questa opportunità, quello che manca è proprio un’analisi del possibile impatto sociale di questi investimenti nei paesi destinatari, in particolare in relazione al lavoro. Le ragioni di preoccupazione non mancano. Penso ad esempio alla situazione che si sta verificando in Cambogia – oggetto della mia nuova ricerca – dove massicci investimenti e aiuti incondizionati provenienti dalla Cina stanno non solo avendo pesantissime ripercussioni sociali, ma anche contribuendo a fare terra bruciata delle fragili istituzioni democratiche costruite con fatica negli anni trascorsi dalla fine della guerra civile. Da questo punto di vista, auspicherei più attenzione – o quantomeno l’inizio di un dibattito – sull’impatto sociale, non solo economico, degli investimenti cinesi all’estero, anche in Italia.