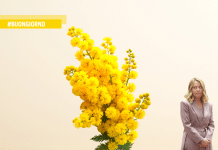Tutti riassolti i 6 poliziotti e i 2 carabinieri imputati dell’omicidio preterintenzionale, sequestro persona, abbandono di incapace, abuso di autorità nei confronti di Giuseppe Uva, il 13 giugno di dieci anni fa, a Varese dopo un arresto illegittimo, secondo la parte civile, e un passaggio in caserma da cui sarebbe uscito così malconcio da essere trasportato in ospedale. I giudici della prima corte d’assise d’appello di Milano presieduti da Maria Grazia Bernini rispetto alla sentenza di primo grado, nell’assolvere tutti gli imputati hanno scagionato con una formula più ampia anche i due carabinieri. Per capire «perché il fatto non sussiste» bisognerà attendere le motivazioni che saranno depositate in 90 giorni. La battaglia per verità e giustizia non è conclusa: «Una sentenza pericolosa. Ovviamente lette le motivazioni faremo subito ricorso in Cassazione», spiega a Left l’avvocato difensore della famiglia Uva, Fabio Ambrosetti – sono sinceramente molto stupito dalla sentenza in particolare sul primo capo di imputazione, il sequestro di persona. Preoccupa soprattutto che ci possa essere una limitazione dela libertà personale quando non ci sono esigenze di identificazione o ragioni reali. Lucia Uva, però è assolutamente soddisfatta almeno nella parte in cui per la prima volta un procuratore le ha detto che aveva ragione e che ha avuto ragione nel proseguire la battaglia».
«Per la prima volta abbiamo avuto la Procura dalla nostra parte», ha detto Lucia Uva, sorella di Giuseppe, stringendo la mano al sostituto pg MassimoGaballo dopo la lettura della sentenza. Gaballo aveva chiesto di condannare a 13 anni i due militari e a 10 anni e mezzo i sei agenti: la morte dell’operaio fu una conseguenza, insieme ad altre cause, tra cui una sua pregressa patologia cardiaca, delle «condotte illecite» degli imputati. Condotte scaturite dalla decisione dei due carabinieri di «dare una lezione» al 43enne, che si sarebbe vantato di una presunta relazione sentimentale con la moglie di uno dei due. Una ricostruzione contro la quale si sono battuti i difensori degli imputati in divisa, tra i quali Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia, lo stesso che nel 2009 da ministro della Difesa sostenne a spada tratta l’estraneità dei carabinieri dalla morte di Stefano Cucchi. «Nessuna macelleria, nessuna azione di violenza» e l’accusa «è stata gonfiata» per effetto «di un aspetto mediatico e televisivo che ha spettacolarizzato la vicenda», ha detto in aula La Russa. In più, il sostituto pg Massimo Gaballo «è arrivato a creare uno scenario, denigrando il lavoro di tutti i pm, dei giudici, dei testimoni e degli avvocati che hanno lavorato a questo processo», a causa «della debolezza degli strumenti accusatori». Per La Russa sul processo ha inciso «un pregiudizio negativo nei confronti delle forze dell’ordine, che è ipotizzabile, perché se un uomo è morto dopo essere stato lecitamente fermato e portato in caserma deve essere ‘per forza’ colpa della polizia e dei carabinieri». Anche un altro dei difensori, Fabio Sgembri, prima di chiedere l’assoluzione per i suoi assistiti e di cancellare pure il reato di sequestro di persona, ha attaccato il pg e pure la sorella di Uva.
È quello che la Corte europea di giustizia ha stigmatizzato come vittimizzazione secondaria, la tendenza a mettere sotto accusa le vittime e i loro familiari nel corso di processi a uomini in divisa. Una tendenza segnalata dall’associazione contro gli abusi in divisa, Acad, che ha seguito il processo con alcuni dei suoi attivisti lombardi e, nei suoi interventi pubblici, anche da Enrico Zucca, procuratore generale a Genova, ora e pubblica accusa del processo Diaz dopo il G8 del 2001. Lucia Uva è corsa dietro al poliziotto Pierfrancesco Colucci dopo la lettura del dispositivo e gli ha stretto la mano in segno di sfida. Con lei anche un altro fratello dell’operaio, Nicola. «Dieci anni che infangano il nome dello zio», ha urlato in aula la nipote di Giuseppe Uva, Angela, subito dopo la lettura del dispositivo con cui sono stati assolti i 2 carabinieri e i 6 poliziotti accusati di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona. Dopo il verdetto, nell’aula ci sono stati momenti di forte tensione.
Giuseppe Uva aveva 43 anni quando fu fermato da due carabinieri mentre stava spostando delle transenne nel centro di Varese. Era notte e, assieme a un amico, voleva solo fare una goliardata. Fu poi trattenuto in caserma per alcune ore e trasportato all’ospedale di Circolo della città lombarda, dove morì per arresto cardiaco la mattina successiva. Secondo i legali di parte civile, l’operaio quella sera fu «arrestato illegalmente» per un reato di lieve entità, ovvero disturbo della quieta pubblica. «Se fosse vivo – hanno spiegato in aula – oggi Uva avrebbe risposto per i fatti di quella notte con una contravvenzione da 150 euro». Poi, durante il loro intervento davanti alla Corte d’Assise d’Appello hanno continuato, sottolineando che «nel processo di primo grado nessuno ha voluto scoprire la verità, tutti quelli che dicono qualcosa contro i carabinieri sono considerati falsi testimoni. Per dire che un teste è inattendibile lo devi dimostrare: cercare riscontri contro i testimoni si fa solo nei processi contro i carabinieri». «Quattro euro di ‘risarcimento simbolico’ e che i due carabinieri e sei poliziotti imputati si spoglino per sempre della divisa», era stata la richiesta formulata in aula, tramite i suoi legali, da Lucia Uva. La proposta di risarcire la sorella della vittima con un euro per ogni capo di imputazione contestato originariamente agli imputati era già stata avanzata in primo grado dagli avvocati Alberto Zanzi e Fabio Ambrosetti al Tribunale di Varese, che nel 2016 ha assolto gli imputati da tutte le accuse. «Non voglio che vadano in carcere – ha detto Lucia Uva parlando con i cronisti fuori dall’aula – ma che si spoglino della divisa che portano».