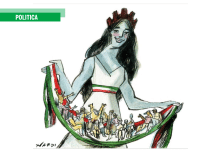In Senegal non c’è alcuna guerra. C’è però chi scappa. Alle calcagna non un esercito, ma flotte di pescherecci, pronti ad aggredire economicamente le coste senegalesi. «Se continuano così lasceranno un deserto liquido. I nostri pesci moriranno tutti, annientati dalla pesca selvaggia degli stranieri». Karim Sall, pescatore esperto e sindacalista di mille battaglie, è preoccupato per il suo villaggio. A Joal Fadiouth, come in tutto il Senegal, la pesca è il motore trainante di tutta l’economia.
L’oceano sbatte sulla piroga che ci porta a largo. Un capitano adulto, accompagnato da un equipaggio di giovanissimi, con anche due bambini. Si va a largo, si martella sul legno della piroga, per far rumore e spaventare i pesci. Si calano le reti. Cernie, sardinelle e sogliole che vengono tirate su. Quest’oceano è ricco di pesce, ma non lo è più come un tempo. Con le piroghe non ci si può spingere troppo in là nel mare. All’orizzonte si vedono dei mostri metallici, battelli di multinazionali della pesca che prendono il pesce in acque senegalesi, lavorandolo direttamente su quelle imbarcazioni: vere e proprie industrie.
Il più giovane della piroga prepara un tè alla menta su di un braciere tenuto a bada durante tutta la missione in mare. Si contano i pesci. Chi pesca da qualche anno sa che con questi numeri è difficile tirare avanti.
«Io ho provato a partire in piroga. Siamo arrivati a Tenerife. Eravamo in 40. Durante il viaggio ho visto morire anche tre persone, tra cui una donna incinta. Dopo 45 giorni ci hanno…