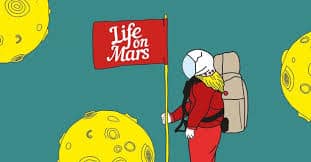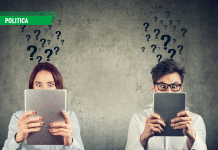Cosa significa resistenza culturale? Dobbiamo resistere? A cosa? E se stiamo resistendo, in che modo lo stiamo facendo? Queste sono state le prime domande che hanno dato il via a “Life on Mars”, evento di networking nato con lo scopo di favorire l’incontro, avviare discussioni e scambi, condividere pratiche e metodologie che caratterizzano o che stanno influenzando il settore culturale in ambito internazionale e in Italia. Partendo dalla mia ricerca in corso che si focalizza sull’analisi del rapporto tra le politiche culturali e il ruolo della società civile individuando proprio il contesto culturale come arena privilegiata di analisi, “Life on Mars – Toward a Metamorphosis?” ha riunito rappresentanti di reti internazionali e istituzioni culturali come European Cultural Foundation, IETM – International network for contemporary performing arts, Assitej International, On the Move; tanti istituti di rappresentanza culturale come Goethe, Institut français, Creative Scotland; e ancora, reti locali dal Portogallo, istituzioni dalla Bulgaria, Corea del Sud, Francia, organizzazioni e movimenti LGBTQ+ Croati, spazi di creazione in Ungheria, rappresentati dalla Commissione Europea, le fondazioni bancarie italiane e tanti altri.
Tutti, speaker e partecipanti, sono stati invitati a condividere i propri programmi, strategie e pratiche in risposta alla diffusa crisi politica, culturale ed economica. Ma a cosa resistiamo? E quali sono i modelli che possono effettivamente introdurre delle pratiche culturali e politiche innovative a sostegno di una società inclusiva e democratica?
“Life on Mars” è stato preceduto da una road-map, un giro d’Italia fatto di workshop, laboratori, riflessioni collettive, sviluppato nella primavera-estate 2019 e che ha portato all’individuazione di parole-chiave, contraddizioni e necessità che riguardano il settore culturale. Tra questi, ad esempio, la necessità di avere tempo per creare e per trovare strategie che superino la frammentazione che sta incidendo significativamente sulla qualità del lavoro creativo e politico. Some emerse parole come resilienza, che è apparsa purtroppo come un’attitudine indispensabile per rimettere al centro il diritto di esistere nelle nostre diversità; attivismo culturale, inteso come determinazione a salvaguardare valori democratici di inclusione culturale attraverso concreta pratiche artistiche. Altre parole emerse sono state empatia, ma al tempo stesso, manipolazione e paura; e poi passione, ma anche instabilità e poi comunità e cittadinanza, legacy e sostenibilità.
Dove siamo oggi?
Quelli riportati sono solo alcuni dei concetti emersi in pochi mesi, ma che riflettono uno stato di difficoltà generalizzata e che vanno collocati in uno scenario allargato. Il riaffermarsi del concetto di frontiera, la riduzione drastica del supporto economico degli operatori pubblici e privati, la crisi ambientale e l’impatto di forme neo-liberiste nelle nostre vite hanno significativamente cambiato il modo di produrre cultura. A questo si è collegata la persistente introduzione di parametri di valutazioni quantitativi ad opera di istituzioni nazionali, europee ed internazionali che ha mortificato la forza trasformativa del rapporto qualitativo che si innesca tra organizzazioni locali, spettatori e cittadini, a cui si aggiungono le tante forme di individualismo politico e la frammentazione e privatizzazione dei welfare nazionali, che hanno ridotto i nostri spazi di cooperazione e immaginazione.
Siamo in un nuovo ordine glocale. In questo ambiente le città assumono sempre più la forma di spazi in cui nuove sperimentazioni culturali e politiche prendono corpo, anche se talvolta portano alla luce evidenti difficoltà nel rapporto con le aree rurali e gli spazi più periferici. Accade in Europa, basti pensare alla Brexit, negli Stati Uniti, con le elezioni di Donald Trump, e prende sempre più forma in Brasile, Hong Kong e in altri luoghi del pianeta. Come appreso dal diffondersi delle proteste nel 2011, queste trasformazioni acquisiscono forza se collegate in una prospettiva globale. Del resto, siamo sempre più consapevoli che il nostro agire locale è interconnesso indissolubilmente con le narrative globali.
Osservando il contesto culturale, la definizione di un nuovo ordine glocale, sta avvenendo a causa di una mancata strategia culturale dei governi nazionali. Ad esempio, alla drastica riduzione delle risorse finanziarie pubbliche si è accompagnata una preoccupante assenza di visione di politica culturale, in grado di sopperire a tale crisi tramite la creazione di infrastrutture culturali e sociali; ciò ha inoltre generato da parte delle organizzazioni culturali, e delle città stesse, la necessità di intraprendere strategie di sostenibilità miste, fatte di servizi individuati a base locale, finanziamenti Europei diretti, forme cooperative a base mutualistica e spesso di carattere transfrontaliere. Sempre più spesso, in questo scenario, la cooperazione culturale cross-border si è presentata come l’ultima spiaggia per mantenere una vitalità e libertà artistica (nonché di espressione in genere).
Tutto questo vive all’interno della complessa e spesso conflittuale relazione tra le forme ‘top-down’ del fare politica e la spinta ‘bottom-up’ della società civile, dell’attivismo politico e culturale. In questo, il settore culturale si presenta ancora – nonostante i tanti limiti istituzionali – come uno spazio simbolico e concreto in cui queste forze, anche sul territorio del conflitto, possono incontrarsi e generare nuovi modelli di cooperazione e di forme di democrazia a base partecipativa.
Verso un rinnovato senso di cooperazione culturale?
A nostro avviso è necessario un rinnovato progetto politico e culturale che non può prescindere dai significativi cambiamenti di sistema e dalle istanze che nuovi modelli stanno portando alla luce. Se è vero che le istituzioni culturali rischiano spesso di assumere forme monolitiche, è vero anche che hanno la potenzialità di essere spazi in cui contraddizioni, diversità, conflitti e nuove forme di politica culturale vengono sperimentate. In questa prospettiva si colloca il concetto di resistenza culturale, che non è un’attitudine passiva, ma piuttosto una forma trasformativa che si basa su processi di immaginazione, o meglio co-immaginazione, capaci di costruire nuovi modelli in risposta alle pressioni di una politica neoliberista globale che riduce gli spazi di creazione ed immaginazione (culturale, politica, sociale). Come detto da Chantal Mouffe, questa non è l’unica possibilità per le nostre democrazie.
Azioni di resistenza, e quindi attivismo culturale, sono rintracciabili all’interno delle istituzioni (locali, nazionali, europee, globali) ad opera di pochi motivati dirigenti o funzionari che cercano di sostenere – anche se in modo discontinuo – il settore creativo che con difficoltà trova canali di espressione. Oppure ad opera di nuove organizzazioni definite ‘intermedie’ che, in risposta al vuoto della politica culturale, propongono nuovi indirizzi di policy prendendosi carico del rischio d’impresa. O ancora, all’interno di progetti di cooperazione culturale transfrontaliera che insistono sull’inclusione sociale e che creano processi attraverso cui integrare i ‘nuovi’ cittadini, che sperimentano forme leaderless di gestione, che generano laboratori politici in giro per l’Europa portando al centro nuove esplorazioni di democrazia partecipativa. Ed anche ad opera di artisti che sempre più agiscono su territori non deputati cercando di generare spazi di socialità fondamentali per nutrire una società frammentata, spaventata, mal informata, che si muove in un contesto economico incerto.
Come affermato dal sociologo Pascal Gielen, le azioni civili a base culturale portano alla luce ciò che non è visibile ed offrono l’opportunità di vivere i confini, le periferie, gli spazi pubblici comuni differentemente, attribuendo un rinnovato valore al vivere civile e civico. Pertanto, co-immaginare può significare favorire processi artistici (e sociali) che includano i diversi segmenti delle nostre società; si riferisce alla consapevolezza del nostro ruolo sociale, artistico e politico che si colloca tra la sfera locale e quella globale; offre l’opportunità di superare la distinzione tra il “noi” e “loro” e andare oltre la paura ed il senso di incertezza su cui diversi governi hanno costruito le proprie agende populiste (non ultima la recente storia italiana). Procedere alla volta di un processo di co-immaginazione significa favorire la creazione di procedimenti legali e infrastrutturali che mettano in sicurezza l’effettiva partecipazione della partecipazione della società civile e promuovano maggiore democrazia e inclusione.
Questo è il motivo per il quale, a nostro avviso, la cultura non è un luogo sicuro ed imparziale. Perché ha la capacità di generare trasformazioni sociali e politiche attraverso i propri processi artistici, senza alcuna restrizione dell’immaginazione artistica.
scritto in collaborazione con Cristina Carlini, Cristina Cazzola, Carlotta Garlanda, Giulio Stumpo, ed Eleonora De Caroli
Life on Mars è stato curato dall’impresa sociale Liv.in.g. – Live Internationalization Gateway, fondata da Cristina Carlini, Cristina Cazzola, Carlotta Garlanda, Giuliana Ciancio, Giulio Stumpo, con la collaborazione di Eleonora De Caroli e con il contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, “Life on Mars” – nella sua edizione 2019 intitolata “Toward a Metamorphosis?” – ha individuato come tema centrale proprio quello della “resistenza culturale”.