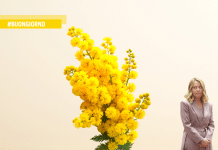Cecilia ha 23 anni, è di Firenze e studia Medicina a Careggi. Da sempre vicina alla causa curda, tre mesi fa ha deciso di recarsi nel nord-est della Siria per unirsi a Heyva Sor a Kurd (la Mezzaluna Rossa curda, organizzazione locale nata nel 2012, partner della Mezzaluna Rossa Kurdistan) per poter mettere le proprie competenze al servizio del Rojava.
Non è la prima volta che visita il Kurdistan: a marzo, infatti, era stata per più di due settimane con Uiki, l’Ufficio d’Informazione del Kurdistan in Italia, nei territori del Kurdistan turco, il Bakur, insieme a un gruppo di osservatori internazionali per verificare che, durante le elezioni amministrative in cui si candidava il partito filo-curdo Hdp, non ci fossero irregolarità.
È stata evacuata da Qamishlo venerdì sera 11 ottobre, poche ore dopo l’inizio dell’aggressione turca, mercoledì 9 ottobre, ed è rientrata a Firenze il 16 ottobre. L’ho incontrata giovedì 17 – poche ore prima della “tregua” (si legge “richiesta di resa”) turca – al polo universitario di Novoli, a Firenze, a margine di un’iniziativa dello Spazio Autogestito – vendita di kebab a prezzi popolari per raccogliere fondi per la Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia.
Cosa ti ha spinto ad andare in Rojava?
Principalmente gli ideali. Sono voluta partire per essere partecipe e avere la possibilità di osservare con i miei occhi, imparare qualcosa in prima persona di quel modello che ho sempre considerato incredibile. Volevo andare e condividere questa esperienza sul campo. E volevo, sì, entrare all’interno di questo territorio da attivista, ma – avendo io una formazione di tipo sanitario – anche facendo qualcosa di effettivo, nel mio ambito.
Cos’hai trovato là?
Sono arrivata proprio nel primo momento di pace dopo otto anni di guerra, quindi in una fase di forte ricostruzione: delle strutture cittadine, delle infrastrutture, dei trasporti, di miglioramento delle strutture ospedaliere. Finalmente si poteva risparmiare dal punto di vista di spese e sforzi investiti nella difesa militare.
Sul piano sanitario e umanitario, invece, ancora prima dell’aggressione turca la situazione era già critica, perché parliamo della presenza di campi profughi che vanno dalle 10mila alle 70mila persone, con difficoltà ulteriori – per il fatto che non sono riconosciuti – per quanto riguarda i rifornimenti e il supporto internazionale. Tuttavia era davvero un momento di crescita e ripartenza, che è stato completamente minato da questo attacco.
Che impressione ti ha fatto il confederalismo democratico messo in pratica, con la sua rivoluzione femminista, ecologista, anti-capitalista?
Le cose ovviamente hanno bisogno del loro tempo per passare dalla teoria alla pratica in maniera completa e condivisa, con la partecipazione attiva di tutti. Ma in Rojava ogni cosa tende verso il modello del confederalismo democratico, con un grande lavoro per implementarlo dove ancora non c’è, mobilitandosi subito su alcuni punti fondamentali. Come ad esempio la difesa della donna, con l’apertura immediata dei centri femminili e la prevenzione ginecologica. I consigli cittadini, poi, sono ovunque, sono capillari. Ogni cosa che viene fatta rientra all’interno della visione del confederalismo. Ad esempio, quando hanno dovuto creare la rete di trasporti pubblici, hanno usato solo veicoli elettrici, per quanto questo fosse molto più difficile, molto più costoso.
Di cosa ti occupavi come volontaria?
Quando sono arrivata, all’inizio, lavoravo direttamente in un ospedale da campo, all’interno del campo profughi di Al-Hawl. Dopo poco ho iniziato a lavorare come coordinatrice sanitaria, quindi ero responsabile di sei strutture e lì mi occupavo del rifornimento farmaci, di gestire il personale, organizzare queste cliniche sotto l’aspetto logistico. E poi della parte di comunicazione, raccogliendo informazioni dagli ospedali, quindi della scrittura di report sulla situazione delle malattie nelle varie zone. Comunque anche in ambito sanitario sono parecchio avanti in Rojava.
In che modo?
Da un lato il progetto è avanzatissimo perché ha veramente l’obiettivo della capilarizzazione più totale, partendo dalle visite domiciliari. E non nel senso che il paziente chiama il medico a casa, ma proprio si bussa porta per porta tramite gli operatori sanitari, per fare prevenzione e copertura. Dall’altro, però, attualmente anche la parte sanitaria è fortemente sotto attacco turco: le ambulanze e gli ospedali vengono bombardati e si devono fermare. Quindi rimangono poche strutture aperte e con una difficoltà di movimento delle ambulanze e del sistema emergenziale in generale enorme. Inoltre è stata presa l’autostrada che collega Qamishlo ad Aleppo e che era quella su cui viaggiavano anche i rifornimenti. E, ripeto, parliamo della presenza di campi profughi con 70mila persone che, con la partenza delle Ong, si ritrovano adesso ad affrontare una situazione di totale incertezza.
Chi rimane?
In questo momento solo Heyva Sor e tutto quello che è la sua componente locale dei comitati della salute.
La Turchia è accusata di aver utilizzato napalm e fosforo bianco durante i suoi attacchi. E le immagini, terribili, che arrivano dal Rojava sembrerebbero confermarlo.
Sì, ci sono stati, pare, attacchi con armi chimiche. C’è un po’ di ritardo nelle conferme perché per andare a dire al mondo che sono armi chimiche hai bisogno di fare una serie di test sui pazienti colpiti che, in questo momento, i medici giù non sono in grado di effettuare. Quindi hanno difficoltà a dichiararlo. Per ora c’è solo la prova visiva, perché sono armi abbastanza riconoscibili per quello che fanno sui corpi rispetto a una bomba normale. E ci sono testimonianze di dottori che ti dicono: “Io non te lo posso far vedere nel vetrino, ma ti sto dicendo che queste sono armi chimiche”.
Che racconti ti arrivano da chi è rimasto?
I compagni giù, nell’ambito sanitario, esprimono preoccupazione sul fatto che l’esercito turco e i gruppi jihadisti filo-turchi stanno avanzando ben oltre l’autostrada e oltre i 30km oltre il confine. E prendono di mira gli ospedali. Se si ferma l’ospedale di Tell Temer è un casino, perché quella è la struttura più vicina al fronte che in questo momento sta lavorando davvero a ritmi serrati.
Poi ci sono le voci che arrivano dai compagni combattenti, quelli che lottano sul fronte, e sono ancora peggio. Da Sere Kaniye in particolar modo, dove adesso il nemico sta puntando a circondarli. Stanno resistendo all’interno della città e ne hanno ripreso una parte in questi giorni, però è una situazione in bilico, perché gli altri attaccano da terra con i jihadisti e dal cielo con la copertura aerea. È arrivata anche una testimonianza dagli internazionalisti, dodici compagni che stanno combattendo lì, che suonava tanto come una lettera di addio. Tell Abyad, invece, è completamente caduta, però dentro ci sono dei compagni che fanno guerriglia. Le informazioni che arrivano da Tell Temer riguardano l’uso delle bombe a tappeto, come è avvenuto ad Afrin: le stesse modalità, con poche perdite dal punto di vista turco, perché vengono mandate avanti le bande jihadiste per fare gli attacchi.
Cosa possiamo fare noi da qua?
Un sacco di cose! Ci sono delle raccolte fondi attualmente in corso per rispondere direttamente all’emergenza. Ce n’è una della Mezzaluna Rossa di Livorno, e i soldi vanno interamente nelle casse di Heyva Sor.
Dal punto di vista politico, poi, dobbiamo fare pressione sul nostro governo e sull’Unione Europea per lo stop, anche retroattivo, alla vendita di armi alla Turchia, e per cancellare il suo processo di adesione alla Ue. I cittadini italiani, poi, dovrebbero puntare a un boicottaggio pieno della Turchia (prodotti, vacanze) e delle cosiddette banche armate.
Inoltre c’è stato un rafforzamento Nato all’interno della Turchia stessa, con un contingente italiano di 130 soldati e una batteria di missili terra-aria puntati per prevenire o rispondere a un attacco siriano in territorio turco. Bisogna chiedere di ritirarli. O di orientarli nella direzione opposta. Servirebbe infatti un contingente di tutti gli Stati europei che faccia da cuscinetto diplomatico e che blocchi gli attacchi, una forza di interposizione.
Insomma, possiamo fare un lavoro enorme all’interno dei nostri Stati, che è una cosa che i compagni da giù non possono fare. Loro, sul campo, resistono alla guerra combattendo, noi, da qui, possiamo prendere parte attiva nella resistenza facendo pressione sui governi.