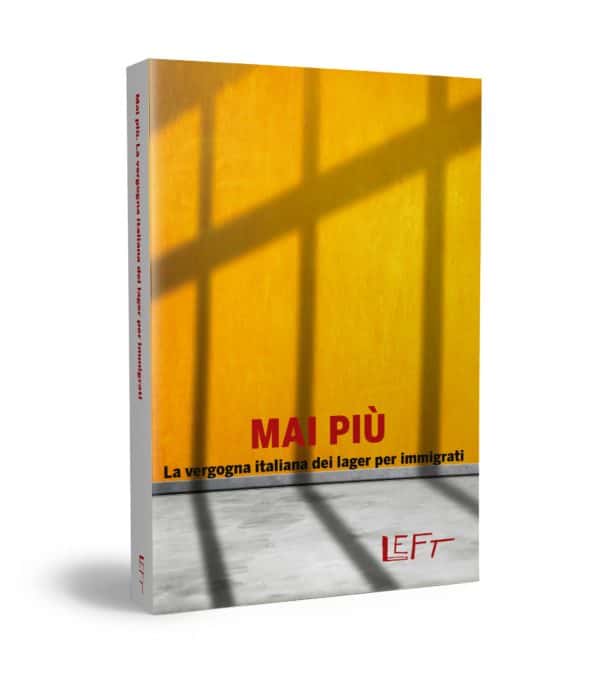«Centri di permanenza temporanea e assistenza» fu il nome che venne dato alle prime strutture di detenzione amministrativa per migranti sorte in Italia dopo l’approvazione della legge Turco-Napolitano. Correva l’anno 1998 e già da allora si diceva, nel centro sinistra, che bisognava coniugare accoglienza e sicurezza, ponendo l’accento sempre più sul secondo termine. I Cpta, acronimo delle strutture (ma la «a» di assistenza venne dimenticata), vennero realizzati in maniera improvvisata prima ancora di dare loro un quadro normativo. Per la prima volta nel nostro Paese, nel resto d’Europa era già prassi, si potevano privare le persone della libertà personale in virtù del fatto che la loro presenza non era considerata regolare. La finalità dei centri riguardava gli «stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera non immediatamente eseguibile». Persone che non avevano commesso reati, rinchiuse per ciò che erano. Per facilitare i rimpatri delle persone non gradite, l’allora ministro dell’Interno Giorgio Napolitano si affrettò a siglare i primi accordi bilaterali di riammissione con alcuni Paesi del Nord Africa che raramente produssero i risultati sperati. I centri, in cui si poteva restare rinchiusi fino ad un mese in attesa dell’espulsione, nacquero da un giorno all’altro e senza organicità.
ACQUISTA IL LIBRO
Nel 2006 si aprì il Cpt di Gradisca D’Isonzo, ribattezzatola «Guantanamo italiana» per l’uso di tecnologia avanzata atta a impedire fughe, rivolte, socialità eccessiva fra gli “ospiti”. Sì, perché chi vi era trattenuto non era considerato detenuto bensì ospite, al punto che se riusciva a fuggire, nonostante si scatenassero cacce all’uomo, gli addetti alla vigilanza delle strutture non potevano essere perseguiti per negligenza. A Ragusa ne aprì uno solo per donne in pieno centro città con telecamere interne alle stanze delle “ospiti” e con personale quasi esclusivamente maschile, chiuse quello di Agrigento per difficoltà di gestione e ne venne aperto uno a Caltanissetta (località Pian Del Lago), si spostò quello di Bari, per pochi mesi ne restò aperto uno a Trieste mentre nelle altre città si rese difficile la loro realizzazione. Per l’opposizione degli enti locali, o più spesso perché popolazione, movimenti sociali – insieme alle difficoltà di reperire strutture idonee – ne impedirono la realizzazione. Come nel caso di Corridonia, nel maceratese. Nel frattempo, nel 2002, era entrata in vigore la Bossi-Fini, che raddoppiava i tempi massimi di trattenimento (da 30 a 60 giorni) ma si andava rapidamente dimostrando il fallimento di tale approccio all’immigrazione. I centri sin dalla loro apertura si erano dimostrati luoghi da cui si tentava di fuggire e in cui si moriva. La notte di Natale del 1999 veniva trovato morto, nel Cpt di Ponte Galeria, Mohamed Ben Said, 39 anni, mascella rotta e forse imbottito di psicofarmaci.
C’è un calcolo macabro scomparso dalla storia ufficiale, quello di coloro che hanno perso la vita a causa della detenzione in questi spazi in cui non valevano e non valgono nemmeno le garanzie dei regolamenti penitenziari, spazi pensati esclusivamente come zoo temporanei per persone. Per parecchi anni, soprattutto fino al 2007, si sono realizzate mobilitazioni per chiedere la chiusura dei centri – la più grande a Torino nell’inverno 2002 -, numerose e praticamente in ogni città in cui c’erano Cpt o dove si minacciava di aprirli. I “clandestini”, in parte rinchiusi nei centri dopo periodi di detenzione in cui non erano stati identificati, i cui provvedimenti di convalida del trattenimento erano affidati a giudici di pace (mai utilizzati fino a quel momento per autorizzare la limitazione della libertà personale), una volta non rimpatriati tornavano fuori in condizioni di irregolarità, con l’obbligo di lasciare entro pochi giorni il territorio nazionale. Solo propaganda insomma e costruzione della fortezza escludente per rinchiudere il “nemico interno” e dimostrare che lo Stato si prende cura della sicurezza dei cittadini. Nel 2006 venne istituita una Commissione indipendente per analizzare il funzionamento dei Cpt, presieduta dal diplomatico Staffan De Mistura, che presentò un suo rapporto il 1 febbraio del 2007. La conclusione era pilatesca: i Cpt non dovevano essere chiusi ma «superati», riducendo al minimo il numero delle persone da trattenere, il tutto proprio mentre si riconosceva il fallimento di tali strutture. Nel 2009 col cambio di governo, il nuovo ministro dell’Interno, Roberto Maroni, incentivò invece l’utilizzo dei trattenimenti. I Cpt cambiarono acronimo diventando Cie (Centri per l’identificazione e l’espulsione), rompendo almeno una ipocrisia lessicale di fondo, e si portò a sei mesi il tempo massimo di trattenimento, trasformandoli di fatto in carceri senza neanche gli elementi propri di un sistema penitenziario e dando via così a un ciclo di rivolte e sommosse.
Nel 2011 il governo arrivò a vietare a giornalisti, operatori di organizzazioni umanitarie non accreditati, amministratori locali e a tutte le altre figure esterne, l’accesso ai Cie. Da un appello di alcuni operatori dell’informazione raccolto dalla Federazione nazionale della stampa e dalla mobilitazione di settori sensibili di società nacque la campagna LasciateCIEntrare. Il successivo governo Monti, con la ministra Cancellieri, sospese l’efficacia della circolare che vietava l’accesso ai centri ma il potere di limitare le visite restò nelle mani dei prefetti. Nel frattempo furono tante le rivolte che scoppiarono e portarono a dover chiudere sezioni dei centri quando non le intere strutture. In poco tempo i Cie aperti si ridussero a quattro, ma intanto si stava entrando già nel periodo vicino ai giorni nostri. Il ministro Minniti rinominò i centri che diventarono Cpr (Centri di permanenza per il rimpatrio). In tutti questi cambiamenti di acronimi ci sono modifiche normative che illustreremo in seguito, ma il tentativo – da anni perseguito – è quello di aprirne almeno uno in ogni regione. Infine, menzioniamo due capitoli che meriterebbero da soli ulteriori e attenti approfondimenti. Per l’autunno 2019 sono previste mobilitazioni per impedire la riapertura o la apertura di Cpr e per denunciare l’inaccettabile prolungamento a 180 giorni dei termini massimi di trattenimento in queste strutture, come previsto dal primo decreto sicurezza firmato da Salvini, mentre alcune forze politiche vorrebbero si arrivasse al tetto di 18 mesi di detenzione.
Il futuro dei Cpr è incerto. Tutti i tentativi di dichiararli incostituzionali sono falliti seppure la stessa sovraordinante direttiva europea 115/2008 consideri il trattenimento come una estrema ratio e non la norma. Il decreto sicurezza permette ad oggi di trattenere chi risulta privo dei requisiti per restare in Italia anche in luoghi diversi dai Cpr ritenuti idonei. Quali sono? Zone aeroportuali, camere di sicurezza, sezioni riservate di penitenziari? Tutto è possibile con le nuove norme. Le strutture di detenzione amministrativa sono state pensate e potenziate per proteggere i confini europei e garantire la sicurezza interna, ma si sono rivelate enormi voragini in cui sparivano persone, soldi pubblici e moriva lo Stato di diritto. Una ragione in più per parlarne con maggior cognizione di causa e per tornare a chiederne a gran voce la definitiva abolizione, anche in quanto istituzioni totali dove neanche i più elementari diritti delle persone possono essere rispettati. Ps. Il testo che segue e che proponiamo è un lavoro collettivo che non può, ovviamente, esaurire del tutto quanto accaduto in ventuno anni. Non troverete alcune tra le molte vicende importanti nell’ambito delle politiche sull’immigrazione e mancheremo di citare molte persone che negli anni si sono impegnate sui temi qui narrati o che hanno dato vita a mobilitazioni e campagne. Sono numerose le soggettività che hanno provato a far sì che questo angolo nero della Storia italiana non venisse rimosso o dimenticato. Ma questa è soprattutto una storia di donne e uomini che abbiamo incontrato, che in prima persona hanno pagato le conseguenze di un sistema ingiusto, alcuni perdendo anche la vita. A loro è dedicato questo lavoro, perché nessuno possa più dire domani: «io non sapevo».