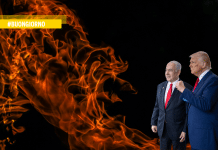Il termine genocidio, coniato nel 1944 dall’avvocato polacco Raphael Lemkin per indicare “l’insieme di azioni progettate e coordinate per la distruzione degli aspetti essenziali della vita di determinati gruppi etnici, allo scopo di annientare i gruppi stessi”, rimanda immediatamente all’immane tragedia della Shoah: la peggiore, forse, fra le tante che hanno purtroppo funestato il “secolo breve”. Ha scritto Marek Edelman: «Per una persona dotata di una psiche normale, è difficile comprendere che si possa assassinare gli esseri umani solo perché hanno un determinato colore di capelli e di occhi, solo perché hanno origini diverse» (Il ghetto di Varsavia lotta, Giuntina). Ciò che maggiormente colpisce e lascia attoniti, studiando lo sterminio degli Ebrei d’Europa – come Raul Hilberg ha intitolato il suo monumentale saggio, frutto di una ricerca durata tutta la vita – è la fredda razionalità con la quale operò il nazionalsocialismo, attuando sistematicamente, e in un arco di tempo relativamente breve – dal 1933 al 1945 – l’emarginazione, la persecuzione ed infine l’eliminazione fisica di circa sei milioni di esseri umani. Un’organizzazione estremamente precisa ed efficiente, quella messa in piedi dal Nsdap (Nazionalsozialistische deutsche arbeitpartei, Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi), era alla base del sistema concentrazionario, consistente in centinaia di campi, sei dei quali erano Vernichtungslager – letteralmente “campi di annientamento”, cioè di messa a morte – Treblinka, Sobibor, Auschwitz-Birkenau, Chelmno, Majdanek, Belzec.
Oltre che nei Lager, si moriva nelle stragi perpetrate nell’Europa dell’Est dagli Einsatzgruppen tramite fucilazioni di massa o con l’uso dei Gaswagen (autocarri convertiti in camere a gas), nonché nel famigerato “Progetto T4”. Quest’ultimo, avente come specifico obiettivo l’eliminazione fisica di portatori di handicap e malati di mente – considerati esponenti di un’umanità degradata e quindi inferiore («vite indegne di essere vissute», secondo la definizione del vocabolario nazista) e perciò pericolosi, in quanto potenziali agenti di contaminazione per la purezza della Volksgemeinschaft (“comunità di popolo”) ariana – prende il nome dall’indirizzo dell’istituto berlinese nel quale venne avviato, al numero 4 della Tiergartenstrasse.
Per anni la gigantesca macchina di morte nazista operò praticamente indisturbata, grazie all’indifferenza di molti Paesi (Stati Uniti compresi) e alla fattiva collaborazione di altri – prima fra tutte l’Italia fascista, che nel 1938 varò – del tutto autonomamente – le leggi razziste. Sino all’ideazione – scartate altre ipotesi, alcune delle quali bizzarre come quella di procedere al trasferimento coatto di tutti gli Ebrei in Madagascar – della Endlosung, la “soluzione finale”, durante la Conferenza di Wansee, il 20 gennaio 1942. Stücke, cioè “pezzi”, venivano definite le persone che, caricate come bestie sui Sonderzüge (“Treni speciali”) erano destinate quasi tutte alla morte nei Lager. «Soluzione finale», «risoluzione della questione ebraica», «pezzi», «treni speciali»: l’asettica neutralità del linguaggio della burocrazia nazista ulteriormente aggiunge, se possibile, orrore ad orrore. Com’è noto, nei campi oltre agli ebrei vennero deportati anche prigionieri appartenenti ad altre categorie: oppositori politici (furono i primi ad essere internati, nel campo di Dachau, in Baviera), omosessuali, testimoni di Geova, “asociali”. Il gruppo più numeroso dei prigionieri per motivi “razziali”, dopo gli Ebrei, fu quello dei Rom e dei Sinti: circa 500mila persone (ma un computo esatto è reso impossibile dal fatto che spesso queste popolazioni non venivano censite regolarmente) inghiottite dal nulla. Cosa accomunava, secondo la delirante ideologia nazista, i Rom e i Sinti agli Ebrei? Probabilmente soprattutto il fatto di essere, per vari motivi, degli sradicati, privi di patria. Una seria pericolosità sociale veniva attribuita dal razzismo nazista a popoli considerati tradizionalmente nomadi (ma in effetti, costretti nei secoli a spostarsi continuamente in quanto sempre emarginati, esclusi e scacciati, ovunque si trovino, come non si stanca di sottolineare il professor Santino Spinelli, docente di Lingua e Cultura Romanì all’Università di Chieti) come i Rom e i Sinti. Era infatti radicata nell’ideologia razzista la credenza in un’origine biologica, e dunque specificamente genetica, del cosiddetto Wandertrieb, ovvero l'”istinto del nomadismo” (sic!): caratteristica fenotipica che sarebbe stata appunto determinata dall’esistenza in un individuo di uno specifico gene. Anche questi popoli vennero quindi perseguitati dal nazionalsocialismo per motivi razziali, in quanto ritenuti, in base al razzismo biologico, «ariani degenerati, con l’istinto alla criminalità e al nomadismo» (Giovanna Boursier, Lo sterminio degli zingari durante la seconda guerra mondiale, in “Studi storici”, 2, aprile-giugno 1995, anno 36). All’interno del campo di Auschwitz-Birkenau esisteva un settore speciale per gli “zingari” (Zigeuner, 3): lo Zigeunerlager, liquidato durante la notte del 2 agosto 1944, quando in circa tremila tra uomini, donne e bambini trovarono la morte nelle camere a gas. Piero Terracina, che da ragazzo fu testimone di quel tragico evento, ha più volte raccontato il silenzio agghiacciante che improvvisamente, la mattina del giorno seguente, regnava nel campo dove sino a poche ore prima si sentivano le voci dei bambini (tra i pochi ad Auschwitz) rom e sinti. Il Samudaripen (in lingua romanì, “tutti uccisi”, dunque “genocidio”), definito anche, sempre in romanès, Baro Romano Meripen, cioè “la grande morte”, o, più comunemente Porrajmos (“divoramento”), presenta quindi numerosi tratti in comune con la persecuzione e lo sterminio degli ebrei; tuttavia, non si dovrebbe mai perdere di vista la specificità e l’unicità della Shoah sia rispetto al Porrajmos, sia rispetto ad altri genocidi – ad esempio, quello armeno.
Ma perché continuare, oggi, a fare ricerca storica sulla Shoah? Fatta salva la specificità di questo evento, studiare lo sterminio degli Ebrei può essere ancora importante anche per analizzare e mettere a nudo i meccanismi che sono alla radice di ogni genocidio: da quello degli Armeni, ai massacri di Pol Pot in Cambogia, alla guerra fratricida tra Hutu e Tutsi in Ruanda, sino alla “pulizia etnica” nella ex-Jugoslavia. Alla base di tali fenomeni c’è sempre l’annullamento dell’altro come essere umano: per vari motivi – di matrice etnica, politica, religiosa – esso non viene più percepito e considerato tale; a quel punto, se si verificano determinate condizioni storiche e sociali (una grave crisi economica, ad esempio, come accadde in Germania dopo il 1929), è possibile che si realizzi il passaggio dal pensare all’agire, cioè che venga messa in atto l’eliminazione fisica del “diverso”. Di fronte ai risorgenti e sempre più frequenti fenomeni di xenofobia e di razzismo di cui quotidianamente ci narrano le cronache italiane – e non solo – è oggi più che mai di fondamentale importanza tenere sempre viva la memoria di quanto è accaduto nel XX secolo. Conoscere e comprendere le dinamiche storiche che hanno prodotto i genocidi del passato dovrebbe spingerci a riflettere sugli avvenimenti del presente, per costruire un’analisi seria ed approfondita di fenomeni storici attuali come le migrazioni: contro la continua tentazione, alimentata soprattutto da parte di certa destra ultranazionalista, di individuare facili capri espiatori per coprire un evidente vuoto di idee e di contenuti.

Leggilo subito online o con la nostra App
SCARICA LA COPIA DIGITALE