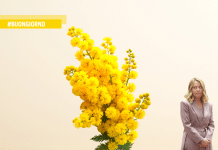Giustizia è fatta. Dopo quasi un anno di proteste che hanno infuocato gli Stati Uniti al grido di «Black lives matter», nel pomeriggio del 20 aprile (le ore 23 in Italia) l’ex poliziotto Derek Chauvin, accusato di aver ucciso George Floyd soffocandolo con il suo ginocchio mentre era in servizio, è stato dichiarato colpevole per tutti i capi di accusa. Ora rischia fino a 75 anni di carcere per omicidio preterintenzionale di secondo grado, omicidio di terzo grado e omicidio colposo. Le ultime parole di Floyd, afroamericano di 46 anni fermato a Minneapolis dalla polizia perché sospettato di aver pagato un pacchetto di sigarette con una banconota da 20 dollari falsa, sono state «I can’t breath», «Non riesco a respirare», una frase che ha fatto il giro del mondo dal 25 maggio scorso ad oggi.
La sentenza sulla colpevolezza di Chauvin rappresenta un momento storico per la lotta alla discriminazione razziale negli Stati Uniti, una decisione così critica da aver richiesto la protezione totale dei giurati popolari che hanno deciso non solo delle sorti di Chauvin, ma di tutti gli States. Mentre le strade di Minneapolis si riempivano di persone in attesa del verdetto, la giuria si riuniva per deliberare in un luogo segreto e senza mai essere apparsa in aula. Era necessario raggiungere una decisione unanime, una clausola che aveva fatto temere addirittura che si potesse palesare l’eventualità di un secondo processo, ma non è stato questo il caso. Sono serviti solo due giorni e 11 ore di seduta per dichiarare Chauvin colpevole e mandare un segnale chiaro, ribadito anche dal presidente Joe Biden subito dopo la lettura della sentenza: nessuno, negli Stati Uniti, è al di sopra della legge. Biden è tornato anche a parlare di una possibile riforma della polizia «per combattere il razzismo sistemico all’interno delle forze dell’ordine», una delle richieste più forti del movimento Black lives matter.
L’abuso di potere della polizia è un grosso problema negli Stati Uniti, soprattutto nei confronti della minoranza afroamericana. Solo l’11 aprile scorso, sempre a Minneapolis, il ventiduenne Daunte Wright è stato ucciso da una degli agenti che lo aveva fermato perché la sua targa risultava scaduta. La poliziotta ha dichiarato che non voleva sparare per uccidere, ma che ha scambiato inavvertitamente la pistola con il taser, il dissuasore elettrico utilizzato per immobilizzare in caso di necessità. Una storia a cui è ben difficile credere, visto che Kimberly Potter, ora dimessasi, era in servizio da 26 anni.
È assai raro che un poliziotto venga dichiarato colpevole in aula per azioni abusanti compiute durante il servizio, per questo la sentenza di ieri è così importante. La morte di Floyd è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso colmo di 400 anni di razzismo sistemico, un vaso che ha iniziato a riempirsi nel 1619, quando con l’arrivo dei primi africani in America la schiavitù ha acquisito una connotazione prettamente etnica.
Se oggi possiamo festeggiare il trionfare della giustizia, però, è soprattutto grazie al coraggio di chi non ha mai abbassato la testa in questi lunghi mesi, dalla famiglia e dagli amici di Floyd fino alle migliaia di manifestanti che hanno occupato le strade di tutto il mondo inginocchiandosi e urlando il suo nome. Ma l’atto di coraggio più importante è stato quello di Darnella Frazier, una ragazza afroamericana di 17 anni (al momento dell’omicidio) che ha deciso di fermarsi a filmare l’aggressione mentre era a passeggio con sua cugina di 9 anni. Dopo averlo messo al sicuro in un negozio, Darnella è tornata per la strada e ha filmato con il suo cellulare i 9 minuti e 29 secondi di inumanità e anaffettività estrema che hanno portato George Floyd alla morte. Poco incline ad apparire in pubblico, la ragazza ha dichiarato più volte che ha deciso di riprendere perché «quello che stava accadendo era chiaramente ingiusto». Il suo video è stata la prova schiacciante della violenza di Chauvin, senza la sua decisione di restare su quel marciapiede con lo smartphone in mano le cose sarebbero andate di certo diversamente.