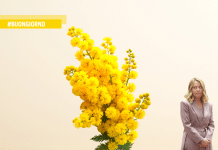Il 25 maggio scorso piazza Tahrir si è riempita in fretta. Autobus carichi di giovani dal sud dell’Iraq hanno raggiunto la capitale, ad annunciarne l’arrivo le foto che si rincorrevano sui social network. La manifestazione era stata organizzata sulla spinta della frustrazione per uno stillicidio senza soluzione di continuità: attivisti e manifestanti freddati uno dietro l’altro, da Nassiriya a Baghdad, e sparizioni forzate senza responsabili.
Nel pomeriggio un cordone di poliziotti presidiava la piazza, lo sguardo quasi assente. Gli agenti hanno lasciato che i manifestanti cantassero, sventolassero bandiere, si riunissero in capannelli per discutere e dibattere. Poi il sole è calato, insieme al caldo asfissiante di un inizio estate iracheno. E il copione si è ripetuto identico a se stesso: spari sulla folla, almeno tre manifestanti uccisi dalla polizia anti-sommossa che si è presa Tahrir mentre l’esercito si ritirava per lasciare agli agenti spazio di manovra. Nei giorni successivi è ricalato il silenzio. La promessa di inchieste indipendenti, ribadita dal premier Mustafa al-Kadhimi, è un rito stanco, vuoto. Come piazza Tahrir: il presidio autogestito lungo un intero anno non c’è più. Le tende sono state distrutte con i bulldozer, i manifesti stracciati e bruciati dalla polizia.
Il Turkish Restaurant – l’enorme palazzo che si affaccia su Tahrir e che affianca l’ingresso al ponte Jumhuriya e alla Green Zone governativa – è tornato a essere uno scheletro inquietante. Del suo ruolo strategico nel mantenimento del presidio rimangono solo i murales. E rimane un cartello che annuncia la creazione di un museo della rivoluzione, ultima trovata governativa dal doppio valore, simbolico e militare: da una parte fingere di dare un ruolo alla protesta nella costruzione di un nuovo Iraq, dall’altra togliere quello spazio alle proteste del futuro, riempiendolo fisicamente di retorica opportunistica.
Sono stati loro, i ragazzi iracheni, la spina dorsale della mobilitazione.
In piazza Tahrir a Baghdad e nelle città del sud, Nassiriya, Bassora, Najaf, ad accendere la ribellione sono state varie classi sociali, disoccupati, poveri, autisti di tuk-tuk divenuti eroi della protesta quando si sono trasformati in mini-ambulanze coraggiose, donne, professionisti, intellettuali. Ma a gestirla e a portarla avanti sono state le nuove generazioni, ricchi e poveri. Giovani che non hanno conosciuto o non ricordano il regime di Saddam Hussein e che non hanno alcuna nostalgia del partito Baath; che erano piccolissimi o nemmeno nati quando gli Stati Uniti sfasciarono il Paese riducendolo a un groviglio di autorità in competizione, divise da muri settari e religiosi. Giovani che si sono fatti ispirare dalle rivoluzioni arabe del 2011 e a cui il web ha mostrato che battaglie identiche alle loro – per…
(Nella foto di Chiara Cruciati, la manifestazione a piazza Tahrir del 25 maggio 2021)

Leggilo subito online o con la nostra App
SCARICA LA COPIA DIGITALE