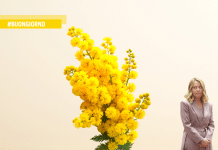Incoraggiando i ragazzi a proteggere dal contagio gli anziani, la senatrice Liliana Segre ha evocato l’immagine di Enea che portava sulle spalle il padre Anchise.
Un’immagine che ha attraversato i millenni e che è entrata nell’immaginario collettivo. I capolavori della letteratura antica ci parlano di valori umani universali. E ci aiutano a capire il presente, scrive il filologo e classicista Maurizio Bettini, docente dell’Università di Siena, in un suo recente libro A che servono i Greci e i Romani, a cui fa seguito, nelle stessa collana Einaudi Homo sum, una affascinante indagine sul “dovere di essere esseri umani”, secondo gli antichi.
Professor Bettini, cosa le suggeriscono le parole della senatrice Segre?
L’immagine di Enea proposta da Liliana Segre mi ha ricordato l’emozione che provocò in Giorgio Caproni la vista di una statua di Enea, con Anchise e Ascanio per mano, eretta in piazza Bandiera, in una Genova bombardata e prostrata dalla guerra. Scriveva Caproni nel suo Il passaggio di Enea: «Enea che in spalla/un passato che crolla tenta invano/di porre in salvo, e al rullo d’ un tamburo/ch’è uno schianto di mura, per la mano/ha ancora così gracile un futuro/da non reggersi ritto». Anchise diventa il simbolo di un passato da conservare – perché la rovina di Troia ne ha messo in pericolo perfino la memoria, così come la Seconda guerra mondiale ha distrutto il passato dell’Europa – e Ascanio è il simbolo del futuro ancora fanciullo, incerto. Questi versi di Caproni costituiscono l’ennesima testimonianza della potente efficacia umana e simbolica che i grandi testi, e i grandi miti, dell’antichità sono ancora capaci di esercitare su noi moderni. Ciclicamente, a seconda dei momenti storici e delle congiunture culturali, il mondo antico ci si ripresenta e con le sue figure, i suoi temi, le sue stesse opere, ci aiuta a capire e pensare il presente. È questo ciò a cui “servono” i Greci e i Romani, la funzione che la conoscenza del passato classico può continuare ad esercitare.
Con Homo sum lei ci invita a rileggere il primo libro dell’Eneide là dove racconta di profughi che fanno naufragio. Fuggono dalla guerra di Troia. Ma sbarcati fortunosamente vengono respinti. Il poema virgiliano ci fa riflettere sulla ferita dei diritti umani negati. Il pensiero corre a ciò che accade nel Mediterraneo a causa di politiche xenofobe?
Come ho scritto nel mio libro, purtroppo l’Eneide ha smesso in qualche modo di essere poesia ed è diventata cronaca. Ciò che nel primo libro dell’Eneide si descrive come finzione poetica – il naufragio dei Troiani nel canale di Sicilia mentre cercano di raggiungere proprio l’Italia, il loro approdo sulle coste della Libia, l’iniziale rifiuto dei Cartaginesi, che vogliono ributtarli in mare, la reazione dei naufraghi, che chiamano «barbari» coloro che respingono il naufrago dal lido e non gli offrono «hospitium», l’accoglienza generosa di Didone, che interviene in loro favore – tutto questo episodio sembra parlarci di ciò che avviene ed è avvenuto oggi: con i migranti respinti dai lidi italiani con i decreti Salvini, e soprattutto, ahimè, le decine di morti nelle acque di quello stesso canale di Sicilia. Virgilio ci mette di fronte a un grande tema umano e giuridico, ma prima ancora culturale: il dovere di porgere la mano al naufrago e di offrire ospitalità agli sventurati che ce la chiedono. «Guardateci da vicino», esclama uno dei Troiani, «non siamo nemici, siamo solo naufraghi!» Oggi purtroppo la xenofobia dilagante, fomentata dagli imprenditori dell’odio e della paura, sta facendo proprio questo: presenta i naufraghi come nemici, come invasori, e, dopo l’avvento dell’epidemia, perfino come untori.
Anche se non c’era un’idea di diritti umani come la conosciamo oggi né qualcosa che assomigliasse alla dichiarazione del ’48, il dovere di essere esseri umani era ben presente nell’antichità greco-romana?
Esisteva, certo, ma con una grande differenza rispetto alla modernità. Non si parlava tanto di “diritti” dell’uomo, come qualcosa che scaturisce dall’interno stesso della persona in quanto umana, ma piuttosto di “doveri” verso l’uomo. Un dovere che imponeva appunto di prestare soccorso al naufrago, di dare acqua o fuoco a chi lo chiedeva, di seppellire i morti, e così via, iscrivendo questo dovere in un orizzonte di carattere religioso: sono gli dèi che vegliano sull’adempimento di questi obblighi e puniscono prima o poi chi li trasgredisce. Quando Creonte, nell’Antigone di Sofocle, si rifiuta di seppellire il corpo di Polinice, in quanto considerato nemico della città (trasgredendo così una norma antichissima e sancita dagli dèi) la città di Tebe è sconvolta. Le parole che Tiresia, l’indovino cieco, pronunzia sono terribili: «Tutti gli altari, tutti i nostri bracieri sono contaminati dai brandelli di carne che uccelli e cani hanno strappato al misero caduto, il figlio di Edipo. Perciò gli dèi non accettano più le nostre preghiere e i nostri sacrifici, né gradiscono la fiamma che si sprigiona dalle cosce delle vittime. E gli uccelli, ingozzati dal grasso sanguinolento di un uomo massacrato, non emettono più suoni che si possano decifrare». Quando penso a tutti i poveri corpi che galleggiano nelle acque del Mediterraneo, restando insepolti, mi vengono sempre in mente queste parole di Tiresia.
Come si conciliava la riflessione sui doveri dei cittadini anche verso migranti e viandanti con la schiavitù che era un fatto strutturale nel mondo antico?
La cultura antica non può certo essere presa come un paradigma di perfezione, di umanità o di dolcezza, come vogliono certe immagini stereotipate della classicità. Quasi che dagli antichi potessimo imparare solo la civiltà. Non è così. La cultura e la società dei Greci e dei Romani presentano aspetti di profonda ingiustizia, che stridono fortemente con la nostra visione del mondo: primo fra tutti la schiavitù, ma anche lo squilibrio nei rapporti fra uomini e donne, la distinzione fra “Greci” da una lato e “barbari” dall’altro (i Romani però furono molto meno chiusi nei confronti dell’alterità di quanto non lo fossero i Greci). La schiavitù, in particolare, era una fenomeno così integrato nella struttura, sociale economica e culturale, del mondo antico, che praticamente nessuna voce si levò mai a contestarne la liceità.
Anche Seneca, che pure scrive una bellissima lettera sulla necessità di trattare gli schiavi in modo più mite ed umano, come lei nota nel libro, «non era certo un abolizionista».
Aveva grandi proprietà e di certo possedeva anche molti schiavi che vi lavoravano. Certe idee, o meglio certe contraddizioni, vengono messe a fuoco solo lentamente, perché interagiscono con modelli culturali che noi non siamo immediatamente in grado di vedere senza una riflessione antropologica. Nel caso della schiavitù, per esempio, l’idea profondamente radicata che gli uomini in realtà non siano tutti uguali: questo spiega per esempio la schiavitù in Grecia (è giusto che i barbari siano schiavi dei Greci, così diceva Euripide ripreso da Aristotele); così come può spiegare il fatto che fino al Cinquecento e oltre si sia accettata la pratica di rendere schiavi africani o nativi americani perché, nella percezione comune, questi esseri non erano veramente “uomini” allo stesso titolo di chi li possedeva, ma appartenevano a uno strato inferiore di umanità. Perché questa pratica così diffusa potesse essere finalmente abolita, doveva farsi strada una concezione non razzista, non differenzialista, degli uomini. Che purtroppo però ancora non si è affermata ovunque.
Il cristianesimo, contrariamente a ciò che si dice di solito, non liberò l’antichità dalla schiavitù. Da questo punto di vista particolarmente subdola fu l’argomentazione di sant’Agostino?
Come vescovo di Ippona, Agostino amministrava terre e schiavi. In campo teorico, giustificava la schiavitù sostenendo (con l’appoggio di opportuni passi biblici) che coloro che erano schiavi, se lo erano, significava che erano peccatori, e Dio aveva voluto così; se poi si trattava di schiavi catturati in guerra, questo mostrava che stavano combattendo una guerra ingiusta. Insomma, gli schiavi rientravano a pieno titolo nel piano della giustizia divina.
Cicerone nel De Officiis parlava di «communia», dei beni essenziali che non possono essere negati agli esseri umani, ovvero a tutti coloro che sono dotati di ragione e di parola. E i bambini che ancora non hanno imparato a parlare?
Lei mi pone una questione sottilmente giuridica! A cui forse non saprò rispondere. Penso però che Cicerone, parlando di umanità in termini di ragione e parola, alludesse al fatto di possedere la “qualità” intrinseca del linguaggio, necessaria a produrre la parola, non alla sua pratica effettiva. E il bambino possiede di certo questa “qualità” anche prima di esercitarla. Ciò non toglie che a Roma l’infante godesse di una considerazione diversa rispetto a quella che ne abbiamo noi: per fare solo due esempi, il nuovo nato doveva essere “sollevato da terra” dal padre per essere riconosciuto figlio legittimo: se questo non avveniva, il bambino poteva essere dato in adozione o venduto schiavo. Ancora, per la morte di un bambino molto piccolo non era necessario prendere il lutto.
Quanto alle donne che in Grecia erano tenute fuori dallo spazio pubblico?
In Grecia la donna non aveva diritti politici, ed era fortemente limitata nella possibilità di possedere e trasmettere i propri beni (a Roma, da questo punto di vista, la posizione delle donne era molto migliore, sia pure con vicende alterne). Questo non significa però che fosse trattata come una schiava. Anzi, gli studi più recenti mostrano come la donna greca non fosse la reclusa nell’oikos che è rappresentata per esempio nell’Economico di Senofonte, ma partecipasse attivamente anche alla vita economica dalla città.
Gli stranieri per i Greci erano barbari, ma poi ne rispettavano gli dèi. Che i Romani addirittura ammettevano nel proprio Pantheon, seppur per egemonizzarli. Nelle società politeiste, c’era un diverso rapporto con l’altro rispetto a quello istituito con il monoteismo e da culture sovraniste e identitarie?
Certo, nella società romana c’era un rapporto di grande apertura verso gli dèi degli altri. Considerati non falsi dèi, o demoni, come è accaduto e accade nelle religioni monoteiste, ma divinità a tutti gli effetti, che potevano essere onorati anche dai Romani stessi. Questo creava indubbiamente un clima di grande apertura culturale, che le società a impronta monoteista stentano ancora a raggiungere.
In conclusione, tornando da dove eravamo partiti, studiare l’antichità greco romana ha un senso non tanto per ritrovare nostre sedicenti radici quanto proprio per ampliare il nostro orizzonte mentale?
Esattamente. Lasciamo perdere le radici, che spesso sono pure invenzioni mitologiche create per scopi politici e ideologici, e cerchiamo piuttosto di utilizzare la cultura antica come palestra di pensiero. La cultura antica, insieme vicina (per continuità storica, linguistica etc.) e lontana (perché gli antichi sono “altri” da noi), costituisce un’occasione straordinaria per confrontarsi con l’alterità culturale.
🆙 Bastano pochi click!
🔴 Clicca sull’immagine oppure segui questo link > https://left.it/abbonamenti
—> Se vuoi regalare un abbonamento digitale, vai sull’opzione da 117 euro e inserisci, oltre ai tuoi dati, nome, cognome e indirizzo mail del destinatario <—
Leggilo subito online o con la nostra App
SCARICA LA COPIA DIGITALE