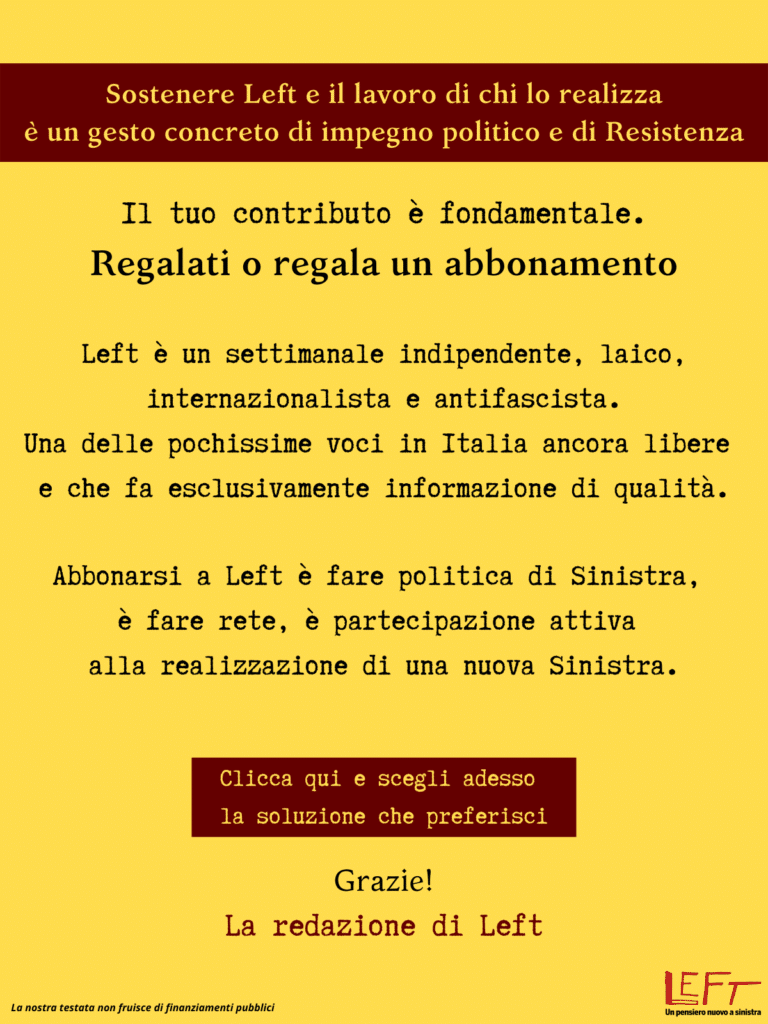Se tendete l’orecchio qui in giro sembra che ci sia ripresa dappertutto. È normale: il governo Draghi ha bisogno di essere confermato dai numeri perché soprattutto dei numeri si interessa e se venisse fuori che i migliori non fanno ripartire nemmeno l’economia (mancando completamente nell’empatia di molti altri aspetti del vivere sociale) il fallimento politico sarebbe difficile da giustificare.
A novembre dell’anno scorso uno dei dati che faceva applaudire commossi i sostenitori del governo era la crescita di 64mila occupati rispetto al mese precedente. Ed è certo una buona notizia. A fare le pulci ai dati Istat però ci si è messo Fulvio Fammoni, presidente della Fondazione di Vittorio, che vale la pena leggere perché la tecnica della “raffredorizzazione” dei problemi e dello sguaiato applauso è sempre dietro l’angolo. Fammoni, sul sito d’informazione della Cgil Collettiva, nota che «se ampliamo la verifica fra questo trimestre e quello precedente, la crescita degli occupati non solo è complessivamente molto bassa (70 mila unità) ma è determinata esclusivamente dall’aumento degli occupati a termine (89 mila), mentre sia i permanenti che gli indipendenti diminuiscono (rispettivamente di 10 mila e 9 mila). Infine su base annua (novembre 2021-novembre 2020) gli occupati dipendenti crescono di 490 mila unità, di cui il 91,5% a termine, pari a 448 mila».
Se volessimo guardare la situazione in modo ancora più largo si potrebbe notare che «se infatti rispetto a gennaio 2021 l’aumento è rilevante, nel confronto con il periodo immediatamente pre-pandemico (febbraio 2020) il numero di occupati è ancora inferiore di 115 mila unità mentre rispetto a novembre 2019 è sotto di 214 mila unità. Se dunque a novembre si è verificato il ritorno a circa 23 milioni di occupati, l’aumento non è ancora sufficiente a colmare il divario con il periodo pre-pandemico e questo è ulteriormente preoccupante se si considera la qualità del mercato del lavoro nel suo complesso».
I problemi intanto rimangono: «Il tasso di occupazione femminile resta ancora al di sotto del 50% e il numero di inattivi rimane il più alto d’Europa; ma il mercato del lavoro italiano contemporaneamente si precarizza nelle fasce più giovani di età (15-34 anni) e complessivamente invecchia per una forte crescita dei lavoratori con più di 50 anni (+297 mila in un anno), con un continuo arretramento degli occupati nella fascia 35-49 anni che, per la prima volta, sono meno degli ultra cinquantenni».
Continua insomma la precarizzazione di un Paese che nonostante la crescita del Pil e i soldi del Pnrr non riesce a migliorare la qualità dell’occupazione, che altro non è che la qualità della vita delle persone. Ha ragione Fammoni quando scrive che «non è accettabile che le risorse generate dalla crescita e l’utilizzo degli investimenti collegati ai fondi europei provochino queste ricadute sul lavoro ed è, quindi, necessario e urgente che queste scelte siano legate molto di più e in modo più vincolante alla quantità e qualità dell’occupazione. Il lavoro e il salario rappresentano, infatti, un parametro sensibile per la qualità e la durata dello sviluppo futuro che non registra i risultati necessari».
Conviene sempre leggerli bene, i numeri.
Buon mercoledì.