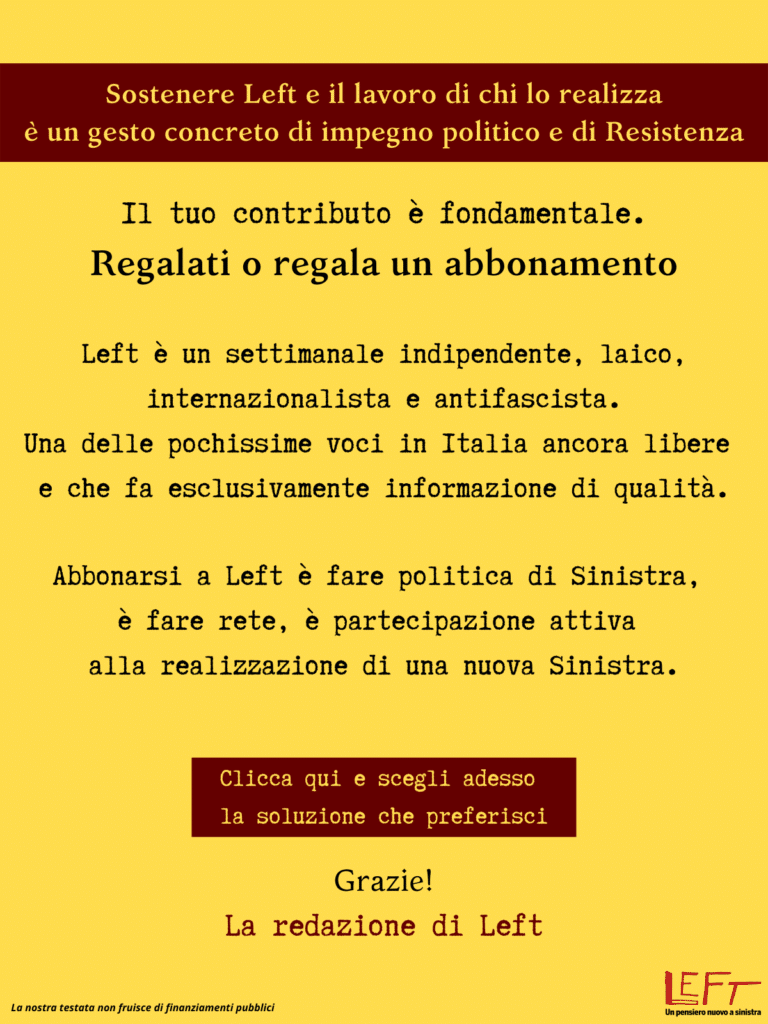Nel 1991, nell’avvio delle trattative che avrebbero portato al varo dell’Euro, Mario Draghi guidò la delegazione italiana nelle riunioni dei funzionari di governo. Guido Carli, che come ministro del Tesoro gli affidò l’incarico, nelle sue memorie affermò che la classe politica italiana non era consapevole di tutte le conseguenze di quella scelta. Cambiava, infatti, la natura stessa della nostra democrazia, la quale da allora avrebbe dovuto esercitarsi non all’interno dei vincoli costituzionali, ma nel rispetto del “vincolo esterno” derivato dall’adesione ad una comunità europea che aveva nel libero mercato il suo elemento costitutivo. Con l’adesione alla moneta unica, lo Stato e i governi non solo furono privati della prerogativa di emettere moneta, ma ne uscirono anche indeboliti nella capacità di influire su variabili chiave per la distribuzione del reddito quali il livello dei tassi di interesse (cioè le condizioni di finanziamento del debito pubblico), le condizioni del lavoro, la possibilità di controllare i movimenti dei capitali, le banche e alcune grandi imprese.
Difficile valutare in che misura il nostro Paese avrebbe potuto seguire una strada diversa: nel mondo la globalizzazione procedeva a tappe forzate, in quasi tutti i Paesi industriali i principi dell’economia mista (cioè di un’economia in larga parte soggetta al controllo pubblico) venivano abbandonati, e in Europa la Germania riunificata ricostituiva la sua forza e stabiliva con la Francia un asse privilegiato. Dunque, forse, l’idea che la sovranità del Paese potesse essere rafforzata, piuttosto che indebolita, mantenendo l’Italia all’interno di quel gruppo di Paesi che decidevano le sorti del continente, aveva la sua ragion d’essere. Di fatto però quel percorso ha condotto ad un cambiamento della natura della nostra democrazia: si sono indeboliti sia le organizzazioni dei lavoratori, sia i partiti della prima Repubblica, che con tutti i loro limiti erano riusciti a ricostruire un sistema democratico sulle ceneri del fascismo. Questi ultimi, in quegli stessi anni, furono anche travolti dallo scandalo di Tangentopoli e, sul versante del Partito comunista, dal collasso dell’Unione Sovietica.
Tra l’adesione alla moneta unica e il crollo del sistema dei partiti, da allora un ruolo sempre crescente fu svolto da un gruppo relativamente ristretto di economisti di formazione neoliberista. La carriera di Draghi, a cavallo tra incarichi pubblici e interessi privati, si è svolta all’interno di questo percorso. Lo ritroviamo, infatti, sempre alla Direzione generale del Tesoro – o meglio sul panfilo della famiglia reale inglese Britannia, da cui tenne un celebre discorso rivolto alle élite finanziarie globali – come artefice delle grandi privatizzazioni, avviate per smantellare la presenza pubblica nell’economia. L’incarico al Tesoro termina col passaggio di Draghi ai vertici di Goldman Sachs, posizione che ricoprì quando la banca d’affari americana truccò i bilanci della Grecia per consentirgli di aderire alla moneta unica. Dopo Goldman Sachs, Draghi tornò in Italia come governatore della Banca d’Italia, posizione che occupò quando il Monte dei paschi di Siena si lanciò nella sconsiderata acquisizione di Antonveneta senza che la vigilanza della nostra Banca centrale avesse nulla da obiettare.
L’indebolimento della sovranità statale generato dalle scelte degli anni Novanta è apparsa in tutta la sua portata quando il 5 agosto 2011, in piena crisi finanziaria, il governatore uscente della Banca centrale europea Jean-Claude Trichet, e il governatore in pectore Mario Draghi, inviarono al governo italiano, allora presieduto da Berlusconi, una lettera dove si indicavano una serie di riforme che il Paese avrebbe dovuto adottare per avere il sostegno della Bce al proprio debito pubblico. Nella lettera erano chieste ulteriori liberalizzazioni, riforme del mercato del lavoro, delle pensioni, tagli agli stipendi pubblici, una riforma costituzionale che prevedesse un vincolo al disavanzo pubblico, l’abolizione delle provincie, indicando per alcuni di questi provvedimenti anche rapidissimi tempi di attuazione. Un gesto al di là del mandato di qualsiasi banca centrale, che riflette una costituzione economica dove la sovranità monetaria, di fatto, confligge con la sovranità democratica. Come esito di questo conflitto, nel novembre dello stesso anno, Berlusconi si dimise e Mario Monti ricevette da Napolitano l’incarico di formare un nuovo governo, anche nella prospettiva di una sua nomina a presidente della Repubblica.
L’ascesa a capo del governo di Monti – membro del Consiglio consultivo di Goldman Sachs, consulente della Coca Cola, con forti legami con la Trilateral, il gruppo Bildelberg e altri organismi privati di orientamento neoliberista -, richiama quanto avvenuto nel febbraio dell’anno scorso: dopo la caduta del secondo governo Conte, nonostante nessun partito lo abbia indicato nel consueto giro di consultazioni, il Presidente della Repubblica Mattarella ha assegnato a Draghi l’incarico di formare il nuovo governo. Anche se per ragioni assai differenti, oggi come nel 2011 le condizioni del nostro Paese destano forti preoccupazioni: l’emergenza sanitaria ha generato un’ulteriore crescita del debito pubblico di tutti i Paesi europei, con quello italiano che ha raggiunto il 155% del Pil.
Va qui chiarito un punto decisivo, che può consentire di comprendere la partita in corso. Anzitutto il problema della gestione del nostro debito non riguarda soltanto noi, in quanto ovunque, per il suo collocamento, un ruolo decisivo lo svolgono le banche centrali. Ma la Banca centrale europea è un organismo che non è sotto il controllo del governo italiano, cosicché la gestione del nostro debito richiede scelte sulle quali il nostro Paese può incidere in modo limitato. In secondo luogo, un elevato debito pubblico non è necessariamente un problema per noi, o per la stabilità dell’economia globale. I debiti pubblici, infatti, sono ormai assolutamente necessari per assicurare il funzionamento del sistema bancario, dove fungono da garanzia per i “contratti Repo”, cioè i prestiti a termine che le banche si concedono reciprocamente per coprire squilibri di liquidità. Il sistema finanziario pertanto ha necessità assoluta di titoli pubblici il cui valore sia stabile nel tempo. Quando nel marzo 2020 i titoli del debito americano cominciarono ad essere venduti in quantità massicce, indicando che stava venendo meno un pilastro fondamentale della stabilità finanziaria, la Federal reserve intervenne immediatamente. Sempre nel marzo 2020, per prevenire una nuova crisi, anche la Banca centrale europea intervenne con un programma straordinario di acquisti dei titoli del debito (Pepp).
Il dilemma in cui si trovano oggi l’Italia e l’Europa è che da un lato la stabilità dei nostri titoli del debito (come di quelli francesi e tedeschi, cioè dei principali Paesi debitori) è necessaria per il funzionamento del sistema finanziario, dunque deve essere garantita dalla Bce; dall’altro questa garanzia non è prevista dallo statuto della Bce che vieta il finanziamento monetario del debito dei Paesi membri. La Bce è dunque costretta ad intervenire, e dal 2011 interviene, con operazioni che hanno dato luogo a controversie e anche a battaglie legali. La soluzione a questo dilemma è che, di fatto, per il rilievo internazionale che hanno le nostre scelte interne, il Paese venga commissariato: come Napolitano assegnò l’incarico a Monti, che impose l’austerità nel 2012, Draghi funge oggi da garante perché il Paese avvii ulteriori riforme nella direzione della modernizzazione neoliberista. Al di là di ogni valutazione su quali riforme abbiano un impianto condivisibile, e quali no, con l’accettazione del Pnrr qualsiasi governo entri in carica nei prossimi anni ha un programma in larga parte già definito, con uno scadenzario da rispettare, pena la perdita dell’accesso ai fondi europei. Ma i governi sono sovrani, dunque potrebbe profilarsi, ancora una volta, uno scontro su quali siano i luoghi della sovranità: il rispetto del “vicolo esterno” o la sovranità del Parlamento e della nostra democrazia. Le pressioni affinché Draghi assuma la Presidenza della Repubblica, e da questa posizione funga da garante, o forse commissario del Paese, derivano da qui.
Nella sostanza siamo ad uno snodo cruciale della storia del Paese, come anche dell’Europa e della moneta unica. La sinistra ha costituito la sua identità nell’adesione al progetto europeo, progetto che si è svolto all’insegna del neoliberismo e l’ha condotta a perdere la fiducia di quelle classi sociali che nel secolo scorso hanno fatto la sua forza. La destra cerca di cavalcare il malcontento, e nella prossima legislatura potrebbe essere maggioranza in Parlamento, senza che la sua posizione sull’Europa sia del tutto chiara. In un momento in cui da più parti si avanzano proposte su come superare quei trattati che per decenni hanno giustificato le politiche di austerità, il nostro Paese potrebbe svolgere un ruolo di rilievo. Per svolgere questo ruolo sarebbe necessaria una classe politica che non scelga scorciatoie: né quelle tecnocratiche, subalterne all’ideologia neoliberista ancora dominante in Europa, né quelle che vorrebbero un recupero della sovranità senza la consapevolezza dei nessi inestricabili che legano il nostro destino a quello degli altri Paesi del continente. La scelta del presidente della Repubblica, del quale al momento in cui scriviamo non sono ancora noti gli esiti, è un passaggio cruciale per il nostro futuro e per la nostra democrazia.