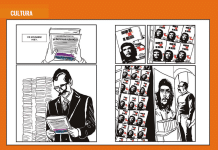Videoartista, regista, fotografa, talento poliedrico, Shirin Neshat da anni porta avanti una sua originalissima ricerca visiva sui temi dell’esilio, dello sradicamento, dell’identità femminile, creando immagini poetiche di «una bellezza che non lascia scampo».
Basta pensare al potente bianco e nero e ai versi della poetessa iraniana Forough Farrokhzad, scritti a mano sulla pelle che contrassegnano il progetto Le donne di Allah (1993-1997) che l’ha fatta conoscere in tutto il mondo.
Pensiamo anche a film visionari come Uomini senza donne e, soprattutto, al recente The land of dreams – capolavoro cinematografico scritto con Jean-Claude Carrière e Shoja Azari – in cui racconta di una giovane donna, come lei di origini iraniane, che il Census spedisce a casa della gente per registrare i loro sogni come forma di controllo sociale; compito che Simin svolge in maniera silenziosamente eversiva.

Aida è un’opera che parla di guerra, di esilio. Shirin Neshat, lei ha approfondito molto questi aspetti nell’allestimento che ha debuttato nel 2017 con Muti sul podio. Possiamo dire che la sua è una lettura fortemente politica di questo classico verdiano?
Aida è un’opera molto interessante e complicata. In un certo senso è una celebrazione delle guerre, della brutalità. Ma al tempo stesso è un’opera che parla di amore. Mi colpiscono molto il dilemma dei protagonisti, le questioni esistenziali sottese alla trama, ma anche il peso della religione, della dittatura, delle armi, dell’invasione e la sofferenza che genera. Nel mio lavoro mi sono spesso occupata di tematiche simili. Specialmente da un punto di vista femminile. E Aida ci parla di una donna intrappolata in più mondi. Sì, è vero, la mia lettura è molto politica. Si parla di un tema purtroppo attuale, la guerra, ma è molto importante per me leggere tutto questo dal punto di vista della vita delle persone. Aida è un’opera che ci interroga anche su questo. Come possiamo sopravvivere in tempo di guerra e violenza come esseri umani?
Si rivede in Aida in un certo modo?
Tutti i protagonisti qui sono importanti e davvero tragici. Aida è una donna costretta all’esilio, è dilaniata, divisa fra l’amore per uomo che ha invaso il suo Paese e l’amore per la terra natia. Ovviamente io non mi trovo in quella situazione. Però sono una donna che vive in esilio, divisa fra l’appartenenza al mio Paese di nascita, l’Iran, e un nuovo Paese, gli Usa, che mi ha dato una possibilità, ma che è anche ingabbiato nelle contraddizioni del suo presente e del suo passato, indelebilmente segnato dall’aggressione dei coloni ai nativi americani.
Veniamo a Simin, l’esile e magnetica protagonista di The land of dreams, (presentato a Firenze da Lo schermo dell’arte 2021). Nel film la ragazza dice di essere nata a Cincinnati, ma è un’immigrata. Come molti immigrati in America è il sangue della nazione, ma non viene riconosciuta. Colpisce che negli States gli immigrati siano chiamati dreamers, ma poi…
Il mio film è un po’ una parodia, una satira proprio di tutto questo, fin dal titolo, Land of dreams, terra dei sogni. In un certo senso l’identità degli Stati Uniti è sempre stata quella di dare una chance a tutti i dreamers per un nuovo inizio. Io stessa ne sono stata un esempio tipico. Sono un “prodotto” della rivoluzione iraniana, ho tagliato i ponti con il mio Paese, con i miei familiari, per sfuggire alla dittatura. Ho dovuto cercare di farmi strada come giovane donna in un Paese straniero. Ti puoi realizzare come individuo, questo gli Usa lo permettono. Simin è un po’ come Aida combattuta internamente fra passato e presente. Il suo passato e la violenza la inseguono.

Il passato di Simin è molto duro e pesante, lei è come disconnessa dal presente. Vive in un Paese adottivo ma fa fatica a integrarsi nella vita americana. Per molti versi vive solo nella sua immaginazione. Quando ti trovi a crescere fra due culture hai il vantaggio di svilupparne una terza. Simin, come molti di noi, non è “pura”, è un ibrido, così appare agli occhi degli altri. Lei stessa si sente divisa fra memorie del passato e la realtà presente in cui vive, ma a cui non riesce del tutto a rapportarsi.
Ma proprio per questo suo vivere di spigolo riesce a gettare uno sguardo nuovo sugli Stati Uniti denunciando uno Stato paranoico che attraverso un censimento cerca di controllare i sogni dei suoi cittadini. Perché lo Stato americano ha così paura delle minoranze, delle donne, degli artisti?
Come nel caso di Aida, anche questo personaggio deve affrontare un intero mondo di istituzioni politiche e religiose soverchianti. The land of dreams racconta la storia di Simin, ma anche una storia molto più grande che va al di là di lei. Il film è ovviamente una favola distopica, ma illumina un’America che diventa sempre più sospettosa verso i cittadini, che si sente minacciata dal loro inconscio, dalla loro immaginazione. Per questo impone un regime di sorveglianza e controllo. Certo non ce lo saremmo aspettati dagli Usa, che nell’immaginario sono sempre stati il Paese della democrazia. Ma gli States si stanno trasformando in uno Stato autoritario, governato da dittatori. Lo racconto come licenza artistica. Ma non possiamo non pensare a quanto è successo con Trump. Non possiamo non pensare a quanto deliberato dalla Corte suprema contro l’aborto e sul climate change in chiave negazionista. In questa prospettiva, le persone hanno sempre meno potere sulla propria vita e l’istituzione ne ha sempre di più. The land of dreams è una black comedy ma ci racconta cosa potrebbe accadere in futuro in America.
Con Women of Allah lei ha espresso una forte critica al fondamentalismo religioso che è diventato di Stato dopo la rivoluzione in Iran, cancellando l’identità delle donne. Qualcosa di simile rischia di accadere negli Usa, con l’avanzata delle Chiese evangeliche? Uno spezzone di The land of dreams mostra giovani donne asservite a un grottesco predicatore.
Si è vero, ai miei esordi con Le donne di Allah volevo raccontare l’oppressione religiosa che d’un tratto incombeva sulla società iraniana. Raccontavo come il regime degli ayatollah controllasse i cittadini cercando di forzarli ad essere religiosi osservanti, spazzando via i valori laici della società persiana, opprimendo le persone. Ciò che oggi dovrebbe spaventare è che gli Usa assomigliano sempre di più all’Iran. Mi sembra ogni giorno più chiaro. Il fondamentalismo è arrivato fino alla Corte suprema. La sentenza che rende illegale l’aborto a livello federale è frutto di una ideologia religiosa molto pervasiva negli Usa. Dopo molti anni di vita negli Usa, penso di aver acquisito il diritto di poter esprimere una critica, anche perché ho passato più anni della mia vita negli Usa che in Iran. Penso che sia importante vedere gli Stati Uniti per quello che sono, non solo attraverso il filtro del mito che li rappresenta come regno della libertà, della democrazia, dell’autodeterminazione. Come in Iran, purtroppo le persone non hanno più la possibilità di scelta e questo è spaventoso.

È molto interessante questa prospettiva. Quello che penso è che di notte riusciamo ad esprimere ciò che ci muove più nel profondo, anche ciò che ci mette in ansia, ciò che ci agita, ciò che temiamo. Le persone hanno paura della violenza, della morte, della separazione, dell’abbandono, e non importa se sei italiano, iraniano, statunitense, ucraino, quando dormiamo affiorano anche le nostre ansie, le preoccupazioni a cui cerchiamo di non pensare durante il giorno. Raramente faccio bei sogni! Ma il bello dei sogni è che rappresentano dimensioni umane universali, non specifiche di una cultura o di una determinata epoca. Io sono una iraniana che lavora in Occidente e cerco di comunicare sia all’Oriente che all’Occidente. Quando tocco il tema del sogni mi accorgo che è un tema che valica le barriere, i confini. I sogni non hanno bisogno di traduzione, attraversano il tempo.
Nel libro Il terzo Reich dei sogni (Mimesis) Charlotte Beradt narra che persone rinchiuse in un lager si raccontavano sogni per restare vivi, per non perdere la propria identità umana. Su Left ne ha scritto lo psichiatra Domenico Fargnoli, che ha studiato a fondo questo tema.
È meraviglioso, non sapevo nulla di questa storia, cercherò il libro di Beradt!
Ancor più l’arte è un linguaggio universale fatto di immagini che superano le barriere?
Esattamente! E il vantaggio che ho come artista nomade fra varie culture è che io non parlo solo a un certo tipo di persone. Parlo dell’Iran, ma parlo del mondo. Questa è la differenza fra un artista nomade come me e persone che vivono sempre nel loro Paese, che non si spostano mai da lì non solo fisicamente, ma neanche mentalmente.
L’arte può svolgere un ruolo nel superare la crisi che stiamo vivendo?
Viviamo in tempi molti difficili, la pandemia, la guerra, il dramma dei rifugiati, la fame e la carestia che incombono nei Paesi africani. Penso che l’arte sia più importante di sempre, comunica e dà un significato alla nostra lotta. Come artista penso che non abbia senso pensare l’arte oggi come un fatto meramente estetico. Le persone cercano contenuti. È un momento duro, carico di pessimismo, io penso che l’arte possa offrire una visione, una apertura “ottimista”. Penso che sia un momento importante per esprimersi come artista. Cerco di dare il mio contributo, non sempre riesco a raggiungere il massimo dell’espressione, but I dream my best.
* In foto, un fotogramma del film “The land of dreams” di Shirin Neshat
Leggilo subito online o con la nostra App
SCARICA LA COPIA DIGITALE