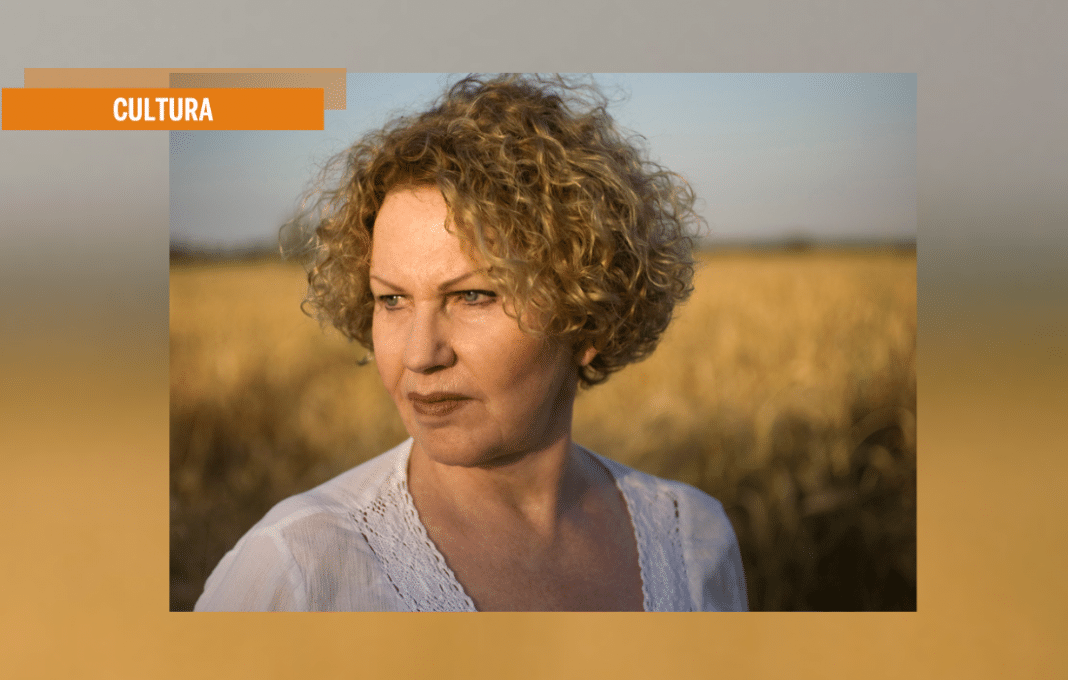Trovai per caso il libro Ricami su ferro di Agi Mishol diversi anni fa su una bancarella di libri usati ad Alfedena, un piccolo borgo abruzzese. «Nata in Romania da genitori di madrelingua ungheresi sopravvissuti alla Shoah. All’età di quattro anni si è trasferita con la famiglia in Israele. Riconosciuta come una delle più importanti e popolari poetesse israeliane contemporanee», leggevo in quarta di copertina. Sfogliando la raccolta di poesie, le uniche tradotte in Italia dalla casa editrice Giuntina, fui colpita dalla loro corporeità, dall’attaccamento al quotidiano, dalla ricerca poetica attraverso quella che è per lei è la sua lingua madre: l’ebraico. «[…] un sole autunnale sorgeva allora/ a Szilàgycseh,/ una zingara ti rivelò in cambio di un’oca/ che avrei visto lontano/ ma nessuno comprese cosa profetizzasse la alef con il kamatz (il suono “a” ma con allusione al fatto che era in ebraico ndr)/ che urlai forte nella stanza. […]», dice in uno degli scritti. Ha pubblicato circa venti raccolte poetiche tradotte in diversi Paesi. Amores è stata da poco pubblicata in Israele mentre altri suoi lavori saranno in uscita con la storica casa editrice tedesca “Hanser”.

Provengo da un luogo difficile, il Medio Oriente, Israele. Una regione tormentata, molto complicata e gravata da guerre e conflitti. La poesia ha bisogno di quiete, molto rara in un posto dove il dramma va in scena ogni giorno. Essere poeti in Medio Oriente vuol dire essere esposti a un baccano politico senza fine, a tensioni e guerre. Un po’ come nella maledizione cinese, “Possa tu vivere in tempi interessanti”. La quiete di cui la poesia ha bisogno è merce rara in un luogo simile. Ci sono poeti che vanno all’estero per scrivere, perché hanno necessità di isolarsi e tenersi al riparo da un simile carico di esposizioni. Questo attrito costante è seccante e li mette in difficoltà. Ricordo un poeta giapponese che in un festival di poesia mi venne vicino e disse di invidiarmi perché vivo in un luogo dove accade così tanto. Non mi definisco un poeta politico, ma in una realtà come la mia è impossibile che la realtà non filtri nella poesia. Soprattutto a livello di linguaggio e immagini. Per esempio, se sto scrivendo versi che parlano di fiori, magari mi si può chiedere perché, mentre intorno a me succede quel che succede, siano i fiori a interessarmi. Se mai la poesia abbia un suo ruolo, questo è di ricordarci chi siamo, e metterci in contatto con gli strati più alti, morali e spirituali, dell’anima. E destare in noi la bellezza, la compassione e la nostra origine. Ricordarci chi siamo, appunto. La poesia non può essere coscritta. Deve essere libera. Come tutti i poeti in Israele, anche io sono in continua oscillazione tra i cannoni e le muse. Tutti noi siamo destinati a oscillare, come pendoli, tra la scrittura poetica impegnata e una scrittura d’evasione, ineludibilmente. Da un lato, ci si aspetta dai poeti che scrivano poesia politica e impegnata, altrimenti si sospetterà che scrivano poesia d’evasione. Ma dall’altro lato, c’è un desiderio di quiete e libertà. Non tutti intendono arruolare il proprio talento al servizio di un tal obiettivo o tal altro. Ci si difende dall’assalto esterno, ma la realtà inevitabilmente filtra sempre. Tutto ciò che si scrive è politico perché la realtà penetra nella poesia, la colonna sonora della mia vita.
Poco dopo aver pubblicato il suo primo libro di poesie, ha ritirato tutte le copie dalle librerie per poi bruciarle. Che significato ha avuto questo suo atto estremo?
Per rispondere alla sua domanda, è importante notare quanto è accaduto negli anni Sessanta, prima dei computer e di internet. Sono cresciuta in un posto piccolo, in una casa senza libri e certe volte ho persino pensato che la poesia fosse una mia personale invenzione. Non conoscevo né poeti né letterati, scrivevo però ciò che provavo. A 17 anni vidi un trafiletto su un quotidiano, la pubblicità di qualcuno che andava alla ricerca di giovani poeti di talento. Andai a Tel Aviv con mia madre, portando con me un quadernetto marrone, dentro c’erano delle poesie scritte a mano nel periodo del liceo, carine anche se infantili e molto immature. L’editore in effetti le apprezzò e mi pubblicò il libro. Quando il libro uscì, mi ero già iscritta all’università per studiare letteratura e quando lo aprii mi resi conto di aver forse messo il carro davanti ai buoi. Mi resi conto cioè d’essere poeta ma di non saper ancora scrivere. Ero un po’ in imbarazzo. Ma magari avevo voglia di sapere cosa si prova ad avere tra le mani un libro col mio nome sopra. Mi resi conto d’essere appena all’inizio del viaggio. Allora ripresi tutte le copie dalle librerie e da tutti quelli che l’avevano ricevuto dai miei genitori, orgogliosissimi, e alcune copie le rubai addirittura nelle biblioteche. Non le ho bruciate in realtà – quella è una metafora! Ho tenuto una sola copia per me, come souvenir. Oggi, dopo tanti anni, qualche volta apro quel primo libro con un po’ di compassione, come se rivedessi le foto di un neonato. Quest’anno per la prima volta l’ho aggiunto al catalogo delle mie pubblicazioni anche se il libro non esiste da nessuna parte salvo che presso di me.
A Hong Kong ha preso parte a un incontro internazionale dal titolo “Poesia e conflitto” per rappresentare Israele. Qual è la sua posizione in merito alla guerra israeliano-palestinese e come può la poesia esserne voce?
Il festival di Hong Kong è stato uno dei più difficili a cui abbia partecipato perché erano presenti dei poeti palestinesi che si sono rifiutati di sedersi con me nel panel in cui ci avevano riuniti. In quel caso ho pensato che se i poeti non riescono a parlarsi, chi altro può riuscirci? Il conflitto israelo-palestinese è complicato, spinoso. Da umanista, appartengo alla compagine a sinistra della mappa. Per me non ci sono differenze tra un’ingiustizia e un’altra, tra una sofferenza umana e un’altra. Come poeta non ho il privilegio di poter chiudere gli occhi. I poeti hanno ricevuto il dono delle parole ma sono anche, soprattutto direi, profondamente impegnati – ognuno nella propria lingua e dentro le circostanze reali in cui gli capita di vivere – nel lavoro più interno, cioè tenere gli occhi aperti, ricordare a tutti noi chi siamo, e mettere tutti noi in contatto con l’essenza umana, spirituale e morale, condivisa da chiunque ovunque.
Le sue poesie sembrano strutturate come un racconto e proprio per questo hanno spesso una “spinta finale”. Cosa ne pensa della forma ibrida di prosa poetica, di questa fusione?
La poesia in forma di prosa, cioè il genere della prosa poetica, ha avuto origine in Francia e in Germania all’inizio del XIX secolo: in effetti è una creatura ibrida che molti poeti (e anche molti prosatori) sono inclini a usare. In ebraico, diversamente da ciò che accade nelle altre lingue, ciò è tipicamente ovvio ed è evidente sulla pagina poiché in poesia le parole sono stampate con una sovra-grafia vocalica (niqqud, N.d.T) mentre in prosa ciò non avviene. Cioè a dire, nel momento in cui si trova davanti un testo in cui appaiono degli elementi vocalici sopra le parole, automaticamente il lettore sa di dover attribuire al testo qualità poetiche e l’energia della poesia. Se si scrive poesia senza questo elemento grafico, ciò significa che si tratta di un testo di poesia epica. La soluzione in ebraico è la poesia in forma di prosa cioè la prosa poetica. Personalmente uso questo genere molto poco.
Definirebbe la sua poesia minimalista? E cosa pensa del minimalismo?
Non descriverei la mia poesia come una poesia minimalista. Ho componimenti lunghi e brevi, a volte solo due o tre versi. Talvolta, e forse questo mi deriva dall’età, dipende dal momento in cui nasce la poesia, un momento in cui tu vedi ciò che anche gli altri vedono, però tu lo vedi in modo diverso, è il cosiddetto “momento: aha!”, il bidimensionale diventa tridimensionale, è un momento di presenza amplificata in cui la poesia comincia a formarsi: il bisogno di relazionarsi con tutto ciò che ti sta attorno scompare. È qualcosa che somiglia agli haiku in un certo senso anche se personalmente non sono molto attratta dagli haiku: rimani con una specie di senso di vanagloria e poi non sai che fartene. Ma anche i componimenti molto lunghi mi parlano poco. Quando mi imbatto in un componimento lungo, mi chiedo sempre se il poeta non sia rimasto incerto tra prosa e poesia in prosa.
Lei rappresenta un intreccio di universi: sua madre e suo padre ebrei di lingua ungherese, suo padre parlava l’ebraico, lei è nata in Romania, precisamente in Transilvania, ma è vissuta dall’età di quattro anni in Israele… In quali aspetti del suo linguaggio, della sua poetica emergono queste contaminazioni culturali?
Sono nata in Transilvania, ora Romania, da genitori ungheresi sopravvissuti all’Olocausto ed emigrati in Israele quando io avevo solo quattro anni. A casa si parlava l’ungherese perché per i miei era già difficile padroneggiare una nuova lingua, ma per me la lingua madre è l’ebraico e non riesco a scrivere né a pensare in altra lingua. Sono altrettanto certa che, a prescindere dal posto in cui fossi nata, sarei comunque diventata poeta. Muovermi tra una lingua e l’altra gioca nell’infanzia un ruolo determinante per la mia sensibilità linguistica perché ho trascorso un lungo periodo nella zona grigia tra lingue diverse e non tutte le parole avevano sinonimi nella nuova lingua. I bambini nati nella propria lingua parlano automaticamente senza riflettere sulle parole e sulle forme idiomatiche ma i bambini come me sono dei traduttori in erba – traducono sé stessi e devono trasporsi in un’altra lingua. Credo che sarei diventata poeta qualunque luogo mi fossi trovata ad abitare, ma attribuisco la dovuta importanza alla lingua e al paesaggio che mi sono toccati, perché essi sono i mattoni che edificano la mia poesia. È questo il materiale da cui traggo le mie metafore, questi gli strumenti che uso per investigare e scovare i comuni denominatori tra i fenomeni, le cui connessioni, per quanto ne so, in genere ci sono nascoste. Il posto dove abito sta a metà tra due aree militari, e gli aerei sono la colonna sonora costante della mia vita. Scrivo in ebraico, che è una lingua antica, bellissima, densa, e contiene una sapienza esoterica che rende ogni componimento poetico più saggio del suo autore.
Possiamo parlare di una poesia al femminile in contrapposizione a quella maschile?
Non ho mai preso parte a eventi in cui la poesia fosse definita “poesia femminile”, e mai mi sono imbattuta in eventi definiti di “poesia maschile”. L’origine della poesia è antecedente alla divisione in maschile e femminile. Ciò detto sono una donna e scrivo, tra le altre cose, della mia esperienza femminile. Storicamente c’è stata effettivamente una innovazione quando le donne hanno cominciato a scrivere e pubblicare. Autrici come le sorelle Brontë o Emily Dickinson e altre anche nella letteratura ebraica sono state in effetti un fenomeno nuovo di grande rilevanza all’ inizio del XX secolo ma è anche venuto il momento di smettere di stupircene.
In un’intervista afferma che l’argomento fondamentale della poesia, di qualunque cosa essa tratti, è la lingua stessa. Nel corso degli anni che tipo di evoluzione c’è stata nella sua scrittura poetica?
È vero, la poesia è un’arte di parole, il modo in cui esse sono disposte, connesse e giustapposte crea una certa elettricità tra loro. I temi fanno una certa differenza ma in ultima analisi è più decisivo il come del cosa. Quanto alla poetica, e cioè ai temi, considero la mia poesia come la colonna sonora della mia vita nel corso del suo viaggio verso la poesia.
Tempo fa c’è stato l’appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Israele e agli ebrei di tutto il mondo: “Mi sto rivolgendo ora agli ebrei nel mondo. Non vedete quello che sta succedendo? Per questo è importante che milioni di ebrei in tutto il mondo non restino in silenzio proprio ora. Il nazismo è nato nel silenzio”. Cosa pensa dell’accostamento del nazismo ai fatti russi-ucraini?
È impossibile mettere le tragedie a confronto. Ho perso degli stretti familiari nell’Olocausto e questo dopotutto ha dettato il corso della mia vita. La memoria è traumatica per qualunque essere umano abbia un cuore, e altrettanto dovrebbe valere ora per la nostra consapevolezza quanto alla sofferenza in Ucraina e ai rifugiati che ne sono fuggiti. Il richiamo all’umanità e alla compassione è un grido universale. La poesia può farsi portatrice di questo richiamo; i governi hanno altre priorità, ristrette e particolari, che confliggono con quell’imperativo universale.
«La nostra casa è aperta, la porta senza chiave e ospiti invisibili entrano ed escono», scrive il poeta Czesław Miłosz nella “Ars Poetica” . Quali sono gli ospiti invisibili nella sua poesia?
È un’affermazione splendida e vera allo stesso tempo. C’è sempre una porta aperta su qualunque cosa entri nel campo visuale. Animali, figure in ordine sparso, poeti, e anche quanti non sono più con noi e frequentemente ci visitano, e quanti di là dal venire al mondo poi si metteranno in viaggio in futuro. Personalmente mi trovo ad uno dei nodi del tragitto, tra coloro che non sono più con noi e coloro che saranno con noi un giorno – ci troviamo tutti in un’unica conversazione continua. Molti animali si affacciano lungo la frequenza, le onde radio, della mia poesia – questo è un punto particolarmente sensibile per me, e a volte si palesano sorprese di tutti i tipi, un uccellino alla finestra o che mi fa l’occhiolino. C’è un’altra stanza sempre aperta per i visitatori inattesi. E grazie a tutto ciò il movimento della poesia è sempre a salire. È una poesia che può elevare ciò che è crudo a un grado di raffinatezza. È la poesia che trasforma la sofferenza in bellezza, e dunque in gioia, ad accendere il desiderio di origine compassione e coscienza.
Traduzione dall’inglese di Daniela Matronola