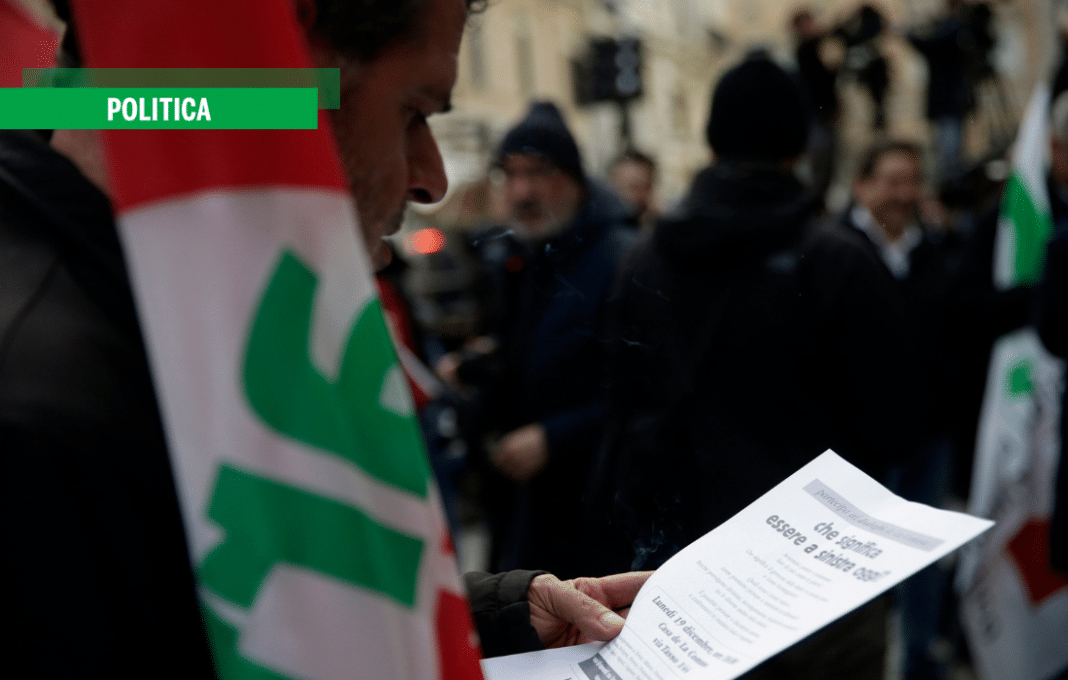Dopo la disfatta elettorale del 4 marzo 2018, Renzi presenta le sue dimissioni, il 12 marzo Maurizio Martina diviene segretario “reggente”. Ma Renzi, pur dimissionario, condiziona pesantemente gli sviluppi politici post-elettorali: dopo una lunga impasse, e il fallimento di una prima trattativa tra il centrodestra e il M5s, Mattarella affida un incarico esplorativo a Roberto Fico, presidente della Camera, che avvia il tentativo di costruire una maggioranza con il Pd. Martina si esprime favorevolmente, ma il 30 aprile, in un’intervista televisiva a Fabio Fazio, Renzi affossa il tentativo di Fico. Ed è singolare che questo episodio oggi venga poco ricordato, e che anzi – anche durante la campagna elettorale – sia stata biasimata l’ambiguità e il trasformismo di Conte e del M5s che hanno governato sia con la Lega sia con il Pd, laddove il primo atto della nuova legislatura fu proprio il tentativo di dialogo con il Pd. […] Martina, il giorno dopo il «siluro» di Renzi, dirà che «è impossibile guidare un partito in queste condizioni…». Fino a quel momento «reggente», Martina verrà poi eletto segretario il 7 luglio dall’Assemblea Nazionale, con l’impegno di rimettere in moto la macchina delle primarie, che si terranno il 3 marzo del 2019. […] Saranno tre i candidati alle nuove “primarie”: Nicola Zingaretti, lo stesso Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Si registra la consueta presenza di massa ai gazebo, oltre un milione e mezzo di votanti; e come al solito anche i commenti riprendono argomenti e toni oramai un po’ triti: questa grande mobilitazione è un «patrimonio da non disperdere», «un tesoro da non sprecare», come recitava il titolo di un editoriale di Ezio Mauro, il giorno dopo. Zingaretti prevale con il 66% dei voti (il 20% a Martina, il 12% a Giachetti, sostenuto da Renzi): sembra aprirsi una fase nuova, torna ad essere segretario del partito un esponente che proviene dai Ds.
«O facciamo una rivoluzione o non ce la faremo», così Nicola Zingaretti, nel suo intervento all’Assemblea Nazionale che si tenne il 13 luglio 2019, dopo un buon risultato ottenuto alle elezioni europee del 26 maggio (il 22,7%). Non era la prima volta, in verità, che si ascoltavano, in quella sede, affermazioni molto critiche sullo «stato del partito» e sulla sua organizzazione; ma le parole di Zingaretti non erano rituali; anzi, suonavano molto schiette e appassionate: «lo voglio dire con molta nettezza… sul partito dobbiamo cambiare tutto perché tutti sappiamo che così non si va più avanti. E lo dico non perché si discute o ci si confronta: io penso che questo sia un gran bene; ma non si può andare avanti così, perché troppo spesso questo partito è un arcipelago di luoghi in cui si esercitano in modo disordinato la sovranità e i differenti modi di praticare la politica e il potere. C’è un gruppo dirigente nazionale attorno a un leader, ma appesantito da un regime correntizio che soffoca tutto. Ci sono realtà territoriali del tutto autonome, separate, feudalità, un’articolazione di gruppi di potere spesso indifferenti alle idee, che si collocano da una parte o dall’altra a prescindere dalle idee, ma con un leader o con un altro a seconda delle convenienze. C’è un patrimonio ancora grande di militanti generosi, di amministratori infaticabili, soprattutto giovani, che lamentano una mancanza di sedi di confronto, una solitudine, uno scarso sostegno da parte dell’insieme del partito. Potrei continuare ma già tutto questo non dà un’immagine di forza e di credibilità alle nostre idee, ma piuttosto di fragilità. Ecco, noi non ce lo possiamo permettere, ma non per noi ma perché il voto ci consegna la responsabilità di essere il pilastro, il baricentro di un’alternativa alla destra e noi dobbiamo rispondere a questa esigenza…, in questo senso il tema del partito va affrontato schiettamente e serve subito una vera e propria rivoluzione, o non ce la facciamo a svolgere il nostro ruolo» [corsivi aggiunti]
In queste parole di Zingaretti è descritto perfettamente ciò che di fatto era divenuto il Pd, ossia un partito in cui il potere dei leader nazionali si fonda su un «arcipelago» di filiere di notabili e potentati locali, che contrattano la propria autonomia e libertà d’azione con il consenso al leader «centrale». È evidente che, in tal modo, le correnti diventano mere cordate di potere, non certo quello che potrebbero e dovrebbero essere in un partito «plurale» e articolato al proprio interno, ossia l’espressione di diverse aree di cultura politica, ma anche di rappresentanza sociale.
[…] La relazione si concludeva con l’annuncio della creazione di una commissione per le modifiche allo Statuto, presieduta dall’ex-segretario Martina, che fu incaricata di predisporre una proposta di riforma, e di farlo in tempi brevi (il nuovo testo fu poi in effetti approvato a novembre); […] E fu annunciata, per il mese di novembre una grande convenzione programmatica, la «costituente delle idee», affidata alle cure di Gianni Cuperlo, a cui era stato dato il compito di costruire per la prima volta una Fondazione di cultura politica del partito. Dunque, qualcosa si mosse e si approdò ad un qualche risultato.
Le parole di Zingaretti erano sincere, e tuttavia, anche in questa occasione, c’era qualcosa che non convinceva, nelle accuse rivolte al modo di essere del Pd. In particolare, le critiche al «regime correntizio» rischiavano di rivelarsi come le classiche grida manzoniane. Perché il Pd continuava a vivere questa condizione di «feudalizzazione»?
Ben presto la segreteria di Zingaretti si scontrò con la realtà oramai cristallizzata del modo di essere «feudale» del Pd: mancando totalmente procedure e meccanismi democratici che costruiscano un serio rapporto tra i momenti della discussione, della partecipazione e della decisione, le scelte del segretario sono sempre sotto tiro, o contraddette da altri comportamenti. E la confusione, o l’indecisione, prevale; in un successivo paragrafo analizzeremo il caso della riforma elettorale e delle politiche istituzionali, ma si possono fare altri esempi. In quella fase, in particolare, oggetto del contendere era la «discontinuità» o meno rispetto alle scelte del governo Renzi, la loro «difesa» o la loro revisione. Come e chi decideva sulla «linea» da seguire? Come si faceva a stabilire, ad esempio, se nel partito prevalevano in quel momento coloro che puntavano a riformare o a cancellare il Jobs Act o se invece era più rappresentativa la posizione di quanti ne rivendicavano la paternità? Ad esempio: il neo-responsabile delle politiche del lavoro nella segreteria nominata da Zingaretti, Peppe Provenzano, aveva espresso i suoi obiettivi, tra cui la revisione del jobs Act. Ed aveva inoltre riconosciuto come fosse stato un errore aver abolito l’Articolo 18. A quel punto, il Sen. Andrea Marcucci, capogruppo al Senato, salta su e “stoppa” tutto: «Ho il dubbio che Peppe Provenzano abbia sbagliato partito. Le sue considerazioni sul lavoro, sul Pd, e sul centro, sono totalmente diverse da quanto ha detto ieri in direzione il suo segretario Zingaretti. Se qualcuno avverte il nuovo componente della segreteria, fa una cosa utile» (Adnkronos, 19 giugno 2019).
Troppo facile ma inevitabile, per noi, qui, la battuta: era Provenzano ad aver «sbagliato» partito, o era «sbagliato» il partito? Forse, se in quel momento, il Pd (tutto) avesse più apertamente lanciato, e poi sostenuto con continuità, la proposta di una revisione profonda e/o dell’abolizione del Jobs Act, la posizione in questo senso enunciata poi durante la campagna elettorale del settembre 2022 sarebbe risultata più credibile.