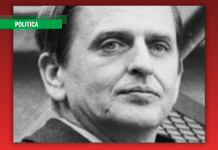Il governo Meloni si appresta a varare un nuovo codice di comportamento per le organizzazioni non governative (Ong) che effettuano soccorsi nel mar Mediterraneo. Ne abbiamo parlato con Alessandro Rocca, giornalista e autore del libro ResQ – Storia di una nave e delle donne e degli uomini che la fecero (People, 2022), centosessanta pagine di voci diverse che si giustappongono nel raccontare di come un’idea apparentemente folle, quella di allestire una nave per salvare vite nel Mediterraneo, può concretizzarsi, pur in un momento storico eccezionale come quello della pandemia, attraverso la mobilitazione della società civile e la capacità di fare rete di realtà grandi e piccole sparse in tutta Italia. Rocca fa parte del direttivo dell’associazione ResQ – People saving people, che ha preso vita nel dicembre 2019 e ha messo in mare la vecchia Alan Kurdi, 39 metri e all’attivo già 900 persone tratte in salvo: con il nuovo nome di ResQ People è salpata per la prima volta il 7 agosto 2021 e, in due missioni, ha già salvato 225 uomini, donne e bambini.

La terza premessa la spiega Rocca in questo modo: «Noi ci siamo, ma non dovremmo esserci. Queste sono operazioni di ricerca e soccorso che dovrebbero svolgere la nostra Marina militare, come ai tempi dell’operazione Mare nostrum (operazione militare e umanitaria messa in atto tra l’ottobre 2013 e l’ottobre 2014 nello Stretto di Sicilia a seguito del tragico naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013 in cui ci furono 366 morti accertate, ndr), l’Unione europea, le istituzioni. ResQ, insomma, non dovrebbe esistere».
Invece, ResQ esiste, ed è nata proprio dall’urgenza di solcare il Mediterraneo causata da quella che anche Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) descrive come una «sostanziale latitanza e, comunque, inefficacia delle attività di ricerca e soccorso da parte delle autorità europee ed italiane sul Mediterraneo centrale», che si conferma essere una delle rotte più attive e pericolose a livello globale, e dove dall’ottobre 2013 hanno perso la vita quasi 20mila persone (dati Unhcr). Le imbarcazioni di organizzazioni umanitarie come la ResQ people che da giugno hanno effettuato operazioni di soccorso sul Mediterraneo sono una quindicina. In realtà, però, secondo gli ultimi dati del Ministero dell’interno rielaborati dal Cir (Consiglio italiano per i rifugiati) per il periodo 1 gennaio- 11 agosto 2022, solo una minima parte (16%) degli sbarchi in Italia è stata effettuata tramite l’ausilio delle Ong, mentre la parte restante degli arrivi è avvenuta in autonomia mediante imbarcazioni di fortuna o mediante altri eventi Sar della Guardia costiera italiana o di unità mercantili.
Gli ultimi anni di ricerche hanno definitivamente smontato l’annosa questione delle navi Ong come pull factor (fattore di attrazione) per le partenze dalle coste nordafricane: tra tutti citiamo lo studio di Matteo Villa ed Eugenio Cusumano, che tra il 2014 e il 2019 rilevavano che nei giorni in cui le navi delle Ong si trovavano al largo della Libia non si notava un aumento delle partenze. Sulla questione ha mostrato un cambiamento di rotta addirittura Frontex, l’agenzia europea per il controllo delle frontiere esterne, in seguito alle dimissioni nell’aprile di quest’anno del controverso direttore Fabrice Leggeri, sospettato di aver coperto alcuni respingimenti di massa nel Mediterraneo. Eppure, nonostante queste evidenze, in un’intervista di poche settimane fa Giorgia Meloni ha dichiarato, citando la stessa Frontex, che «alcune Ong rappresentano un fattore di spinta dei flussi di migranti illegali, con conseguenze sia sugli arrivi che sui morti in mare», e si ipotizza che all’interno del Codice di condotta per le Ong che il governo è in procinto di varare sia inserita, proprio in questo senso, la raccomandazione di non comunicare la propria posizione a imbarcazioni che stanno per lasciare le coste tunisine o libiche.
«Una raccomandazione inutile, oltre che assurda», spiega Rocca, «perché qualsiasi nave in navigazione, da quella di soccorso, al mercantile, alla nave da guerra, ha l’obbligo di mantenere il transponder acceso e la propria rotta tracciabile. Esistono delle applicazioni come VesselFinder, ad esempio, dove inserisci il nome della nave e ti viene segnalato esattamente dove questa si trova: non c’è bisogno, insomma, che ci sia una corrispondenza tra presunti trafficanti ed eventuali altri personaggi. La questione del pull factor è un problema inesistente, utilizzato da chi vuol fare propaganda e non ha altri argomenti, per andare dietro alle promesse fatte durante la campagna elettorale, quando aveva assicurato al proprio bacino elettorale che sarebbero cambiate alcune cose».
Quella di essere un pull factor è solo una delle accuse mosse alle Ong, che forse devono al loro sguardo libero e indipendente su quello che succede al di là del Mediterraneo – in primis, in Libia – il fatto di essere criminalizzate sul piano politico e mediatico, e di essere soggette all’applicazione di misure discriminatorie come quella del Codice di condotta. Le ipotesi che circolano relativamente al nuovo Codice si presentano come regole di comportamento che, se violate, implicherebbero pesanti sanzioni amministrative e impedirebbero alle persone di sbarcare.
Alcune di queste raccomandazioni, come il fatto di poter intervenire solo in caso di pericolo e l’obbligo di comunicare il proprio intervento e di coordinarsi con le autorità competenti, sono «cose che già si fanno in mare», spiega Rocca, ribadendo il fatto che le navi delle Ong, così come ogni soggetto che naviga, sono obbligate a rispondere alla legislazione internazionale, a fronte della quale codici di questo tipo non hanno alcun valore giuridico. Ci sono poi, però, altre questioni. L’obbligo di «un solo rescue per missione», prima di tutto: le navi umanitarie dovrebbero chiedere il porto sicuro alle autorità e portare a terra le persone immediatamente dopo ogni intervento, senza rimanere in zona Sar «in attesa di altre imbarcazioni». In contrasto, poi, con la seconda premessa cui accennavamo inizialmente, il porto sicuro potrebbe anche non essere il più vicino, come è avvenuto pochi giorni fa alla nave Life Support di Emergency, a cui è stato assegnato il porto di Livorno dopo aver soccorso 70 naufraghi in zona Sar libica. Commenta così Rocca: «L’autorità può assegnarti un porto lontano perché ritiene che sia più adatto ad assistere le persone da far sbarcare, ma questo significa far navigare altre 20-25 ore persone già pesantemente provate da mesi o anni di viaggi nel deserto, in mare, da detenzione, stupri e torture». E, ancora, i soccorritori potrebbero dover chiedere alle persone a bordo di manifestare il proprio interesse sull’eventuale domanda di protezione internazionale, in modo tale che sia il Paese di bandiera della nave a farsi carico dell’accoglienza una volta avvenuto lo sbarco.
Una direttiva che, in un certo senso, andrebbe nella stessa direzione degli sbarchi selettivi cui ci ha abituati il ministro degli Interni Piantedosi negli ultimi mesi. E che, ancora una volta, dilaterebbe il tempo trascorso sulla nave, in netto contrasto con quanto dettato dalla Convenzione di Amburgo. «Il soccorso di fatto termina quando le persone sono sbarcate in un porto sicuro – spiega Rocca – e solo a quel punto si può verificare chi ha diritto di asilo o di un altro tipo di protezione. Come fai a dire che una persona non ha diritto di sbarcare semplicemente perché è un ragazzo di ventidue anni robusto e in buona salute? Magari viene da un Paese in guerra, magari ha subito persecuzioni, magari non può professare la sua religione o la sua tendenza sessuale. Intanto la fai sbarcare».
Una volta a terra, poi, ci sarebbe da ristrutturare un sistema di accoglienza fragile e impostato su un carattere di emergenza che non esiste. «Dovrebbe essere rivisto il regolamento di Dublino (che determina che il primo Paese dell’Ue di arrivo sia quello responsabile dell’esame della domanda di protezione internazionale, ndr) facilitando dei percorsi di redistribuzione in Europa e aprendo dei corridoi umanitari che permettano alle persone giunte in Italia di raggiungere i Paesi europei dove vogliono arrivare perché magari lì hanno un amico o un familiare. L’accoglienza dovrebbe, inoltre, puntare all’inclusione delle persone e non all’istituzione di nuovi Centri di permanenza per il rimpatrio o centri di simil-detenzione», suggerisce Rocca che, infine, conclude: «Quello a migrare è un diritto universale. Siamo tutti figli dell’immigrazione, nessuno escluso.”