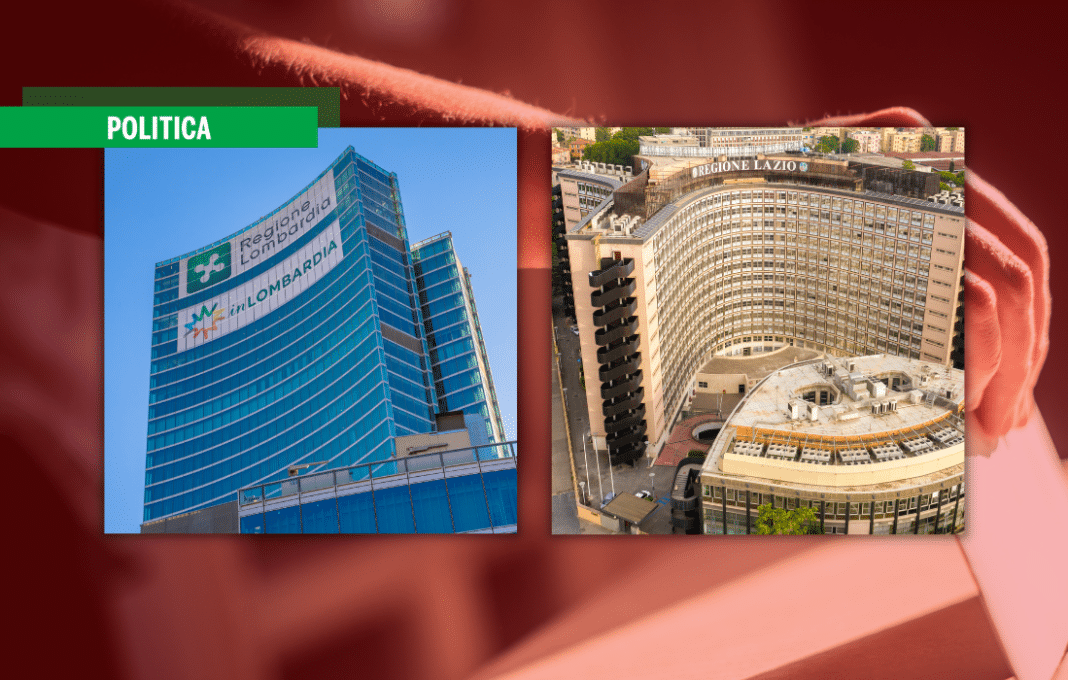Le elezioni in Lazio e Lombardia – dove era chiamato al voto un quinto degli italiani – confermano la distanza abissale che ormai separa la politica dai cittadini, che in massa disertano le urne. Il risultato finale ci dirà come si sono distribuiti i voti ma la tendenza è già chiara: la destra chiama a raccolta i suoi, a sinistra è il deserto: partiti e liste che grottescamente difendono la loro cittadella, mentre intorno è il fuggi-fuggi. La democrazia è in crisi, questo è il verdetto, e chi dovrebbe rianimarla è incapace di cogliere la gravità della situazione, tutto concentrato a ritrovare un’identità. Tra tutti, è il Pd che appare come vascello nella tempesta, privo di comando, dove gli ufficiali sono tutti animati a discutere sul da farsi.
Perché il confronto in atto nel Pd tra i candidati alla segreteria – molto educato, mica il calor bianco delle primarie americane – avrà un esito che, al di là del risultato, fa già sorgere spontanea la domanda: dove andrà il Pd? La cui risposta non è affatto scontata, ben al di là delle elezioni regionali. Un nuovo segretario/a dovrebbe voler dire un rinnovato gruppo dirigente. Se, come ricordava Andrea Carugati sul Manifesto, «non c’è nulla di strano nel fatto che la minoranza dell’ultimo congresso punti ora a tornare maggioranza nel partito», potrebbe darsi che a riprendere le redini saranno proprio coloro che più hanno contribuito alla perdita di consensi attuale. Dal 2008, le prime elezioni del neonato partito a guida Veltroni, al 2022 il Pd ha più che dimezzato i suoi voti, perdendone 6,6 milioni (dei 12 che aveva). Con Bersani, nel 2013 ne perse già 3,4 e gli subentrò Renzi; Bersani se ne andò e il Pd ne perse altri 2,2 nel 2018. E Zingaretti e poi Letta non hanno fatto di meglio, non riuscendo a frenare l’emorragia. Come conferma quest’ultima tornata elettorale, per quanto locale.
L’artificiale contrapposizione tra “riformisti” (che sono poi ex renziani) e gli altri, sparsi in varie “correnti”, nasconde, infatti, il vero dramma di questo partito: che dovrebbe essere un intero ceto dirigente a farsi da parte, ammettendo di aver ridotto il partito ai minimi termini. E invece no: sono tutti in gara a farsi avanti, dietro al ruvido Bonaccini che «non sa che farsene di una sinistra minoritaria». Come se la sua stessa candidatura non fosse l’indicazione che quella sinistra diverrà ancor più minore. Un partito che non sa riflettere sugli errori fatti e sulla strada da intraprendere è un partito destinato a sciogliersi. Ammaliato com’era stato dalla «politica liquida» che si doveva confare a una «società liquida», sarà il partito a liquefarsi.
Encomiabili appaiono sia lo sforzo di Elly Schlein che di Gianni Cuperlo di soccorrere il malato al capezzale. La prima, puntando sulla sua “novità” di esterna che raccoglie consensi sparsi “nella società”; il secondo rimarcando un più apparente messaggio “di sinistra” che vada a riscaldare il cuore dei vecchi militanti. Ma la contesa appare segnata, per due ragioni: perché al gruppo dirigente che ha guidato il partito in questi anni, a livello centrale e locale, corrisponde una “base” e un certo “blocco di potere” che è comunque maggioritario (vedi Emilia-Romagna) e perché lo stesso messaggio dei due contendenti “outsider” è confuso, insufficiente. Nessuno sembra aver capito che per riprendersi – se non “rifondarsi” – il Pd dovrebbe chiedersi perché ha perduto consensi, dove sono andati gli elettori e simpatizzanti che ha deluso. Dovrebbe chiedersi chi vuole rappresentare e perché, quale idea di paese e del mondo vuole proporre oggi che sia diversa da quella che aveva. Certo, ad ascoltarli, sia Elly che Gianni, viene da pensare che sono tornate certe parole , perfino «idee di sinistra». Ma non c’è un’analisi e non vi è critica di cosa non va nel mondo.
Il “programma” di Schlein è farcito di tutte le parole “giuste” – disuguaglianze, diversità, sostenibilità – ma non si dice cosa va intaccato per cambiare rotta (la lista delle cose che non vanno è lunga, ma non ci si chiede perché). Quello di Cuperlo è più sostanzioso, ma pecca anch’esso di superficialità, e oltre a dire che il mondo è “guasto”, malato – con le cure del caso che si dovranno apportare – non si va. Sembra non si sia capito che è l’impianto concettuale e ideologico che va cambiato, perché si è dimostrato non solo inadatto ma lontano da ciò che una forza di sinistra dovrebbe perseguire. Non c’è analisi e, di conseguenza, non c’è soluzione che derivi da una disamina dei danni e di come incidere.
Il substrato neoliberista rimane. Non c’è critica del capitalismo: non basta dire che questo «sorveglia vite e consumi», non si può dire che «il clima è stato alterato dall’essere umano» perché non è stato un generico “essere umano” ad alterarlo, ma il modello di sviluppo capitalistico, che è predatorio della natura e dei popoli che sono stati sottomessi e sfruttati. Si arriva addirittura ad affermare che «il capitalismo degli ultimi quarant’anni ha tolto al mercato la capacità di dare valore alle cose»: ma come? Sarebbe forse il mercato che dà valore alle cose? Il mercato non è etico, per definizione, persegue solo il profitto. Poi, certo, ci si premura subito di ribadire che, per correggere le storture del mondo, si deve intervenire, ma ciò «non significa più Stato» (per l’amor di Dio!). Ci vuole più democrazia, si dice, ma non è per dare voce a chi è escluso (come si potrebbe supporre), ma «per rispondere alla sfida dei monopoli tecnologici». Il linguaggio liberal persiste.
Non viene ricordato – nonostante si ribadisca l’importanza della “memoria” – come sia stato il movimento operaio con le sue lotte a tenere a freno lo strapotere del capitale, negli anni Sessanta e Settanta (non si trova la parola ‘lotta’ nel programma di Cuperlo, si parla solo della «negozialità di fabbrica», e in quello di Schlein è tutta tradotta in termini di battaglie civili). E, però, dopo aver ribadito che comunque la società è “liquida” – altro mantra liberal – si ammette che le classi esistono ancora, sono più frammentate, e l’ascensore sociale non funziona più, perché è lo Stato a non funzionare. No! L’ascensore sociale non funziona perché l’economia ha preso il sopravvento sulla politica e il meccanismo anti-egualitario è intrinseco al capitalismo (vedi Piketty). In più, una società corporativa, ferma, familistica e “frammentata” (nei suoi strati bassi) com’è quella italiana, classismo ed esclusione divengono la regola.
Il Pd, da parte sua, ha poche colpe (sic). «La democrazia è più debole», si dice (ma cosa vuol dire se non che in molti non ci credono più?), «perché ha strumenti fragili per ridistribuire risorse». O è forse perché si è lasciata l’economia prevalere sulla politica? Ed è stato il “sistema” «a indebolire la capacità della sinistra di rappresentare parti intere di società» (o è stata la sinistra a rinunciare?). La sinistra ha creduto nella post-modernità – viviamo nel presente, le ideologie sono superate – per accorgersi ora che la destra una ideologia ce l’ha e un’ideologia, una visione del mondo a venire, ci vuole. Insomma, non c’è alcuna analisi di cosa non va nella società (non basta dire vogliamo un lavoro giusto, un fisco equo), quali storture esistono: ci vuole una critica del capitalismo predatorio. Non quel generico «tenere insieme le ragioni della produzione con quelle della vita e della dignità».
Bonaccini, per parte sua è in linea com’è con quanto il Pd ha rappresentato in questi anni, tanto che davvero vien da chiedersi come possa una linea che si è dimostrata perdente trovare un così sicuro consenso nel partito. Ma il fatto è che il vizio d’origine perdura. Sin dai tempi dell’Ulivo, quando D’Alema affermava al congresso dei Ds che «l’Ulivo è il futuro dell’Italia», il Pd non è ancora riuscito a risolvere quell’ambiguità di fondo: voler essere “di sinistra” guardando ai ceti medi, dimenticandosi sempre più di quelli popolari, nell’idea bacata che questi siano marginali e, in definitiva, inglobabili in una prospettiva “progressista” inter-classista «a scatola chiusa».
Così, il Pd va all’elezione della sua figura di vertice lasciando la sinistra più orfana che mai, ove non vi sono credibili alternative per il consenso di quei ceti che tanto bisogno avrebbero di una voce che li rappresentasse il luogo dei “messaggi identitari” di cui loro non sanno che farsene. Di elezione in elezione, l’elettorato italiano, confuso, ha perso i suoi antichi riferimenti, senza trovarne dei nuovi, e tanto il Pd che i suoi competitor a sinistra e al centro paiono incapaci di “risintonizzarsi” con una società che guarda altrove. Ormai delusa da una «democrazia dei garantiti» che non parla più dei suoi problemi.