La giornata della memoria dovrebbe durare tutto l’anno. Anche per questo vogliamo qui riprendere e raccontare un pezzo di storia collettiva ancora poco conosciuto, ma importante. Tra il 1933 e il 1941 più di 18mila ebrei, perlopiù tedeschi e austriaci, trovarono rifugio a Shanghai, città esempio di un cosmopolitismo vitale e complesso basato sui principi di equilibrio dello yin e dello yang. Grazie ai cosiddetti “visti per la vita” rilasciati dall’allora console cinese a Vienna, Ho Feng Shan, lo “Schindler cinese” (nella foto), furono salvate migliaia di persone dagli orrori del nazismo. La storia di un “miracolo”, com’è stata definita, di persone che hanno fatto scelte coraggiose, ambientata in Cina, a conferma della dimensione non solo europea ma globale della Shoah.

A memoria di questa vicenda, si incontrano luoghi significativi: la sinagoga Ohel Moshe, costruita nel 1927 dagli ebrei che già si erano stabiliti a Shanghai alla fine del XIX secolo, e lo Shanghai Jewish Refugees Museum, il Museo dei rifugiati ebraici, inaugurato nel 2007; sul cui sito ufficiale si precisa come le immagini e i vari documenti custoditi testimonino, fra le altre cose, «l’aiuto e il sostegno reciproco fra i cinesi e gli ebrei» che si trovarono ad affrontare contemporaneamente degli eventi drammatici: l’occupazione giapponese (1937-1945) e la Shoah. Un’integrazione certo difficile, ma riuscita. Gli ebrei furono costretti dai giapponesi, alleati dei nazisti, a vivere nel “ghetto” di Honkou, ma bisogna sottolineare come non furono mai perseguitati né isolati. «Di fatto l’antisemitismo non è mai stato una realtà né per la Cina, né per il Giappone», sottolinea Elisa Giunipero.
Ma perché proprio a Shanghai? Perché la “Parigi d’Oriente” era rimasta l’unica città ancora accessibile agli ebrei. Divenuta “porto aperto” già a metà dell’Ottocento, come si legge nella premessa del libro, per via delle varie concessioni straniere in continua interazione e dialogo con la parte cinese della popolazione. Teatro dell’elaborazione di una sintesi cosmopolita unica nel suo genere, di commistione più che di mutua esclusione. In linea con i principi dello yin e dallo yang, complementari, mai opposti. Gli ebrei di Shanghai poterono dunque sopravvivere e salvarsi, anche perché i giapponesi, refrattari al coinvolgimento nello sterminio degli ebrei, non cedettero alle pressioni naziste che pretendevano di estendere la “Soluzione finale” anche alla Cina, come si può leggere nel saggio di Agostino Giovagnoli all’interno del libro. Al tal fine, pare che oltre al “macellaio di Varsavia”, Josef Meisinger, la delegazione tedesca in Oriente portò con sé anche contenitori di gas Zyclon B, lo stesso utilizzato nei campi di concentramento. «La Shoah», ci dice la professoressa Giunipero, «è qualcosa di universale per quello che ci insegna e ci lascia. La storia che, insieme ad altri, ho voluto raccontare nel libro è una spia che evidenzia ancora di più la dimensione non solo europea ma globale della Shoah. Per questo è un qualcosa da raccontare», perché non si dimentichi e non si ripeta. Mai.
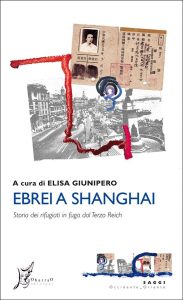
«Ho Feng Shan, già questo è indicativo, non parlò mai dei suoi “visti per la vita”, fu sempre molto discreto», ci racconta la curatrice del libro. Infatti, la sua storia fu scoperta solo molti anni dopo, anche grazie al lavoro di ricerca e collazione di fonti e documenti della figlia, Ho Manli. Ho Feng Shan si inventò un vero e proprio sistema per salvare queste persone, approfittando del fatto che in quel momento Shanghai, per una serie di coincidenze (occupazione giapponese, governo fantoccio, presenza delle concessioni straniere), era praticamente scevra da stretti controlli burocratici. Poté così, contro il volere dei suoi superiori, rilasciare un gran numero di visti e passaporti che nessuno avrebbe visionato e che permisero a molti ebrei di raggiungere la Cina, ma anche di dirigersi altrove. Mise in pericolo la propria vita, ma non poté fare altrimenti. In quella circostanza non c’erano differenze di alcun tipo, ma soltanto la ferma consapevolezza di non potere e non dovere restare indifferenti.
Elisa Giunipero ci riporta una frase che il console avrebbe detto rispondendo a chi gli chiese il perché delle sue azioni: «Ho pensato che fosse naturale provare compassione e volere aiutare. È il punto di vista umano, è così che dovrebbe essere». Ecco, in un periodo del genere Ho Feng Shan ha avuto il coraggio di essere umano, “semplicemente”. Come lui tantissime altre persone, uomini e donne, molti ancora sconosciuti, che hanno risposto all’orrore disumano del nazismo con il coraggio di chi conserva la propria umanità, costi quel che costi, come chi, ad esempio, continua ad allungare una mano nel Mediterraneo senza esitazione alcuna. Perché si tratta di persone, di vite umane. E tanto basta. Questo prezioso frammento, come scrive Giovagnoli, «conferma l’attualità della Shoah e quanto sia importante la sua memoria, non solo in Europa ma in tutto il mondo, per evitare che, in altra forma e in altre circostanze, possa ripetersi».
Nella foto: l’immagine della copertina del libro Ebrei a Shanghai. Storia dei rifugiati in fuga dal Terzo Reich (O barra O, 2018)






