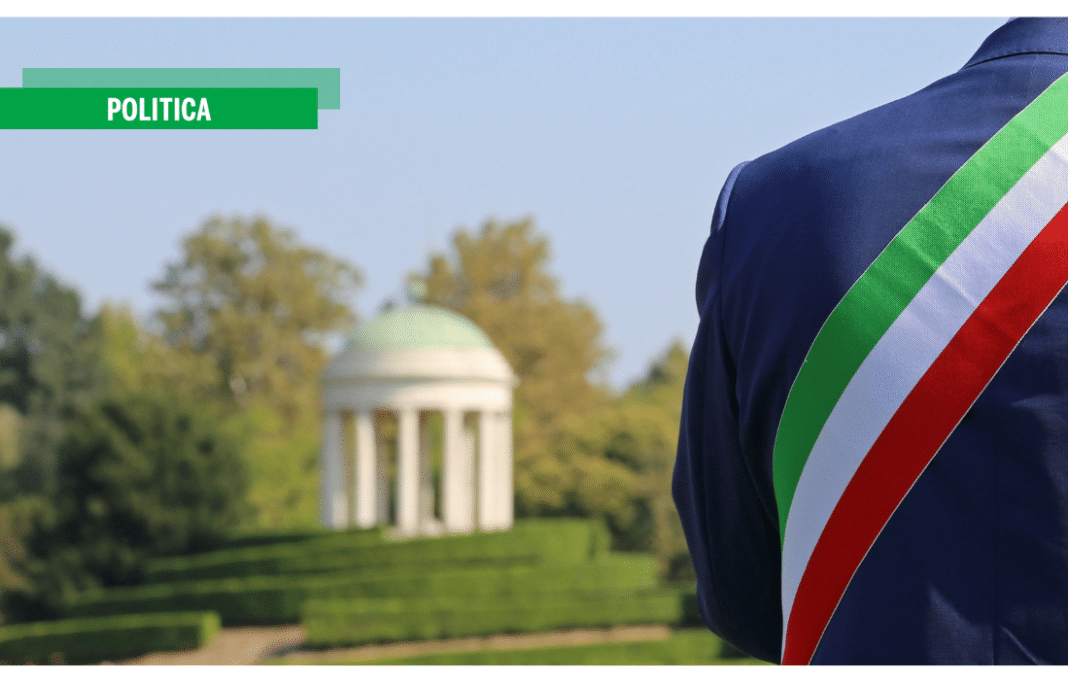Ma a quale reale necessità risponde l’elezione diretta del presidente della Repubblica, o del presidente del Consiglio, del cosiddetto “sindaco d’Italia”? La risposta è la governabilità, la stabilità e la durata dei governi. Sarebbe questa la via per realizzare le riforme di cui il Paese ha bisogno. Un tale argomentazione è assolutamente priva di prove empiriche e di fondamenti storici. I primi decenni dell’Italia repubblicana dimostrano che non esiste alcun nesso necessario tra stabilità dei governi e processi riformatori. Dal 1946 sino al 1981, quando si sono succeduti decine di governi, tutti a guida democristiana, contrastati da una forte opposizione politica e sindacale, mentre il Paese era percorso da aspri conflitti, si sono realizzate le riforme che hanno reso moderno il Paese, fatto approdare a un gradino più avanzato di dignità civile milioni di italiani.
Nel 1949 viene varato il piano Ina-Casa, che nel corso di 14 anni assicurerà un’abitazione decente a centinaia di migliaia di famiglie operaie. Nel 1950 viene avviata la riforma agraria, che, pur con tutti i suoi limiti, spezza l’assetto secolare del latifondo, un vero pezzo di feudalesimo sopravvissuto all’età contemporanea. Nello stesso anno nasce la cassa per il Mezzogiorno, che avvierà profonde trasformazioni strutturali del territorio e della società meridionale. Nel 1962 viene nazionalizzata l’energia elettrica e realizzata la riforma della Scuola media unica, per elevare l’alfabetizzazione dei cittadini secondo il dettato costituzionale. Ma è con gli anni Settanta, com’è noto, frutto di un biennio di lotte operaie e popolari senza precedenti, che fiorisce una stagione fertilissima di riforme. Nel 1970 viene varato lo Statuto dei lavoratori, la legge sul divorzio, cui segue, nel 1971 , l’istituzione degli asili nidi e la scuola a tempo pieno, mentre nel 1974 vengono varati i Decreti delegati sulla democrazia nelle scuole, che coinvolgono la rappresentanza delle famiglie. Riforme destinate a modificare gli assetti sociali si alternano al quelle per il riconoscimento dei diritti civili: nel 1975 il nuovo diritto di famiglia elimina la figura millenaria del capofamiglia quale detentore unico della potestà; nel 1978 viene legalizzato l’aborto; nel 1978, viene istituito il sistema sanitario nazionale, una della maggiori conquiste di civiltà della storia d’Italia. Quali riforme può vantare il secondo governo Berlusconi, durato dal 2001 al 2005, o il quarto Berlusconi, dal 2008 al 2011, o quello di Craxi, dal 2083 a 2086? Giusto per richiamare gli esecutivi di maggior longevità. E’ evidente che non è la stabilità e durata dei governi a costituire la condizione di una strategia riformatrice dei gruppi dirigenti, ma qualcos’altro. Non dovrebbe sfuggire a una analisi meno superficiale, una fatto paradossale. Alla instabilità dei governi della cosiddetta seconda repubblica (una invenzione retorica, per farci simili alla Francia e alla sua grandeur), corrisponde nei fatti una coesione strategica dei partiti politici: sostengono tutti un programma neoliberista, tutti, con variazioni tattiche di poco conto, e con qualche eccezione dei Cinque stelle, convergono al “centro”. Dunque, per un sistema politico sostanzialmente così omogeneo, dovrebbe essere più agevole che in passato, intraprendere riforme di ampio respiro. In realtà, se si eccettua la fase d’avvio del Movimento 5 stelle l’Italia è rimasta, per diversi anni, senza una opposizione. Priva di un partito realmente riformatore e di una conflittualità programmatica. Non esistevano grandi ostacoli per chi governava. Oggi l’opposizione l’ha creata il governo Meloni. Un’opposizione, al momento, in gran parte esclusivamente verbale. In realtà l’instabilità che viene lamentata non è dovuta a contrapposizioni strategiche delle forze in campo, a conflitti che coinvolgano gli interessi di vasti strati sociali, come accadeva tra gli anni Cinquanta e Settanta, ma a competizioni di potere, al confliggere di cordate elettorali in competizione, alla ressa confusa di diversi appetiti individuali. I partiti infatti, che non rappresentano più classi sociali, raggruppamenti definiti, sono in gara fra loro unicamente per gestire le risorse pubbliche. Il fine della politica, soprattutto in Italia, si è ridotto alle manovre per accedere a tutti i luoghi di potere pubblico o semipubblico che consentono la fruizione di danaro, l’acquisizione di influenza, visibilità, gestione di clientele necessarie al consenso elettorale e alla riproduzione del ceto politico. I partiti non mirano soltanto alla vasta platea di luoghi di comando e di gestione di risorse rappresentati dal governo, dal sottogoverno, dalle varie autority, ecc, ma anche dalle grandi e ricche corporazioni pubbliche e semipubbliche, come Rai, Eni, Enel, Leonardo, Fincantieri, Trenitalia, ecc. Senza qui considerare le occasioni di lucro offerte dalla gestioni degli appalti e in genere dai rapporti con le imprese a livello locale. La pratica dello spoil system mostra oggi in trasparente filigrana l’ orizzonte strategico entro cui si muovono i partiti. Se riusciamo a liberarci della nebulosa retorica che offusca il cielo del Paese, e le menti dei contemporanei, noi comprendiamo che, di fatto, tranne qualche isolata eccezione, le forze politiche costituiscono una Seconda Pubblica Amministrazione, gestita da soggetti privati. La prima si occupa della macchina statale e dei servizi, la seconda, nella faccia rivolta ai cittadini, gestisce l’acquisizione del loro consenso in perpetua competizione dei suoi attori, per il fine sostanziale della conservazione degli assetti vigenti. La tutela dello statutus quo è infatti per quasi tutti i soggetti il “perimetro costituzionale” da non valicare. Non a caso le leggi elettorali degli ultimi decenni sono state congegnate per impedire l’ingresso di nuove forze nell’agone competitivo, e soprattutto per ostacolare l’irruzione del conflitto di classe nella dinamica spartitoria del spoglie pubbliche perseguite dai raggruppamenti maggiori. Dunque l’assetto è: i partiti, che sono organizzazioni private, operano per gestire le risorse pubbliche, riproducendosi in gran misura con il sostegno delle medesime. E allora, di fronte a tanta stabilità, qual è il fine dei progetti di snaturamento della nostra Costituzione? La prima risposta è che bisogna dare in pasto ai cittadini, considerati solo come elettori, un qualche risultato dell’azione governativa. In cambio di consenso i partiti vendono infatti narrazioni riformatrici. E’ uno scambio di mercato tra voti e pubblicità elettorale. Lo slogan della governabilità fa parte dell’armamentario retorico inaugurato negli anni Ottanta da Bettino Craxi. Ma dietro il vuoto progettuale e operativo dei nostri partiti si cela in realtà una vocazione autoritaria di tutti i poteri politici nelle società avanzate. La ricerca di uno Stato forte è un’aspirazione di vecchia data delle classi dirigenti capitalistiche. Barbara Spinelli ha ricordato che è stata la Trilaterale, nel 1975, a esprimere, in un documento pubblico, l’esigenza di una “democrazia decidente”, quale risposta ai conflitti e alle aspirazioni socialisteggianti della fine degli anni Sessanta ( vedi Il Fatto quotidiano del 12 maggio). Un’aspirazione in apparenza paradossale. Non viviamo nel Regno del pensiero unico neoliberista? E questo non chiede ed impone l’assoluta libertà del mercato, e la più o meno completa marginalità dell’agire statuale? E allora, se lo stato deve limitarsi a stabilire solo le regole, mentre le libere forze dell’impresa si autoregolano, garantendo da sole lo svolgimento di una società libera e dinamica, a chi e a che serve un governo forte? I
padri fondatori del pensiero neoloberista da Friedrich von Hayck, a Milton Friedman hanno fatto del termine libertà una bandiera al vento, a partire dai titoli delle loro opere. E con questo vessillo ideologico hanno conquistato il mondo. Ma non c’è bisogno di scomodare Marx per svelare che la libertà teorizzata dal pensiero economico neoliberista riguarda in realtà la figura degli imprenditori: sono loro che devono essere lasciati liberi dai condizionamenti della lotta sindacale organizzata, dalla pressione fiscale finalizzata al welfare pubblico, dalle regole di protezione degli interessi collettivi e dell’ambiente. Ma c’è un anello che collega tale rivendicazione libertaria all’autoritarismo nascosto in questo pensiero. La libertà incondizionata pretesa è al tempo stesso la libertà di comando dell’imprenditore ( o del manager) in qualità di capo, che nell’agone competitivo deve avere il controllo assoluto su tutti i membri che operano nell’impresa.Un potere di
comando del singolo che richiede ubbidienza del collettivo. Ma l’autoritarismo preteso per la fabbrica viene progressivamente rivendicato per l’intera società. E’ un processso cui assistiamo da anni. L’abbiamo visto in Italia, ad esempio, non solo in tanti ambiti della vita economica privata, ma anche nella sfera pubblica: nella sanità, con la trasformazione delle Usl in Asl , cioè in in aziende, con conseguente disciplinamento interno. Oppure nell’Università, che dopo i trattati di Maastricht, col cosiddetto Processo di Bologna (1999) , ha assunto in Europa la figura del New Pubblic Management, come viene definito il processo di aziendalizzazione del settore pubblico. Ancora più evidente è in Italia il rivolgimento subito dalla scuola, dove il preside è diventato il dirigente, e l’aziendalizzazione è stata accompagnata da un nuovo assetto gerarchico interno. Dunque l’esigenza per niente sotterranea, lo spirito che domina il tempo, è quella di adattare ogni forma di realtà sociale alla struttura dell’ azienda, sottoporla alle sue gerarchie, ai suoi meccanismi di disciplinamento. Non è un caso che il cosiddetto presidenzialismo venga perorato anche in ambito di centro sinistra: esso costituisce un coerente esito dell’ideologia che esalta la libertà: quella di chi comanda. Ma a questo punto tutto dovrebbe apparire chiaro allo sguardo dell’osservatore non ingannato dalla pubblicità elettorale. I partiti , senza più legami con le grandi masse popolari, privi di prospettive strategiche, ridotti a un confuso coacervo di interessi in conflitto, promettono agli italiani un capo azienda, un manager di Stato che consenta l’efficienza a la prontezza d’azione che essi non riescono a garantire. Vogliono un comandate sopra di loro, perché l’opera di predazione di chi vince la competizione elettorale avvenga in buon ordine e con regole certe.