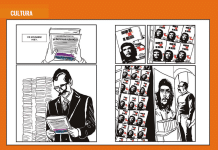Scritto e diretto da Antonio La Camera, e prodotto da PlayLab Films, Las Memorias Perdidas de los Árboles è stato presentato in anteprima mondiale alla 80esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove è stato premiato come miglior film cortometraggio nell’ambito della Settimana Internazionale della Critica. Le prossime proiezioni, dopo Udine il 3 ottobre, il 10 a Trieste e il 16 a Bolzano.
Attraverso il dialogo immaginario tra due alberi, e la rievocazione di memorie antiche risalenti all’infanzia, in Las Memorias Perdidas de los Árboles affronta tematiche importanti. Racconta di dolore, di solitudine e di depressione come di «qualcosa che colpisce e trascina negli abissi», ma anche di anaffettività. «Sapevo come ti sentivi ma non ho avuto il coraggio di parlarti…ho lasciato che scomparissi».

Avere avuto la possibilità di girare nella foresta amazonica peruviana è stata sicuramente un’opportunità unica per lasciarsi tutto alle spalle e “ricominciare”, allontanarsi fisicamente e spiritualmente dalla propria quotidianità, facendo tabula rasa per lasciare spazio al nuovo.
Detto ciò, essendo cresciuto nella Calabria rurale in realtà mi sono sentito subito a mio agio nella foresta nella quale ho passato molto tempo da solo, sia di giorno che di notte. E in quei momenti di solitudine, in un ambiente così primordiale e misterioso, la nostra possibilità di ascolto interiore si amplifica e siamo più propensi a connetterci col nostro inconscio e a sentire (non solo con l’udito) l’ambiente che ci circonda.
Tutto ciò credo sia possibile in qualsiasi ambiente naturale, che sia la foresta amazzonica peruviana o le montagne del Pollino. La vera unicità sta nel riuscire a ritagliarsi questi momenti sempre più messi da parte nelle nostre quotidianità, quando invece sono imprescindibili per conoscersi e capire effettivamente quello che ci fa stare bene o meno.
Ciò che colpisce maggiormente nel film è la capacità delle immagini di comporre un linguaggio, di raccontare una storia, anche laddove il senso non viene affidato alla parola. Giochi di luci, ombre, suoni e colori che, rievocando forse i primissimi giorni di vita e allontanandosi dalla mera riproduzione della realtà, sembrano parlare ad ognuno di noi. Quanto la tecnica è stata di aiuto per arrivare a questo potente risultato?
In ogni opera, la parte tecnica che dà vita alla forma stessa dell’opera riveste ovviamente un ruolo fondamentale. Senza di essa il contenuto non può prendere vita e l’opera non esisterebbe. La mia esperienza mi ha portato nel corso del tempo a confrontarmi in prima persona con tutti gli aspetti tecnici che compongono la nascita di un film: dalla fotografia al montaggio, passando per il suono fino ad arrivare agli effetti visivi. Questo mi ha sempre dato modo di lavorare in maniera organica alle mie opere avendo la possibilità di sovrapporre le fasi di pre-produzione, produzione e post-produzione che di solito sono separate in maniera abbastanza rigida. Soprattutto in questo caso specifico, avere la capacità tecnica di girare e montare il materiale immediatamente facendo nel mentre una bozza di sound design e di color, mi ha dato la possibilità di avere un’idea più chiara di quello che stava nascendo, di correggere eventuali errori in corso d’opera e di sperimentare in maniera libera assecondando l’istinto. Credo che seguendo un processo tecnico e produttivo più canonico sarebbe stato molto più complesso e per certi versi impossibile realizzare la stessa opera, anche perché nei mesi successivi al workshop ha cambiato diverse forme prendendosi un tempo che sarebbe impensabile in un contesto canonico. Avere avuto invece la possibilità tecnica in prima persona di “prendermi cura” di tutta questa fase, di provare, sbagliare, riprovare e sbagliare ancora, mi ha dato la possibilità di spingere al massimo il materiale fino a farlo arrivare alla sua forma definitiva.

Nella storia c’è tanto del mio vissuto personale con mio fratello e più in generale del mio rapporto col “non detto” e con i sensi di colpa. La spinta che ha portato alla nascita della storia è stata molto istintiva come spesso accade quando hai poco tempo (in questo caso specifico il tempo del workshop) e si è messi con le spalle al muro senza poter stare troppo a pensarci su. In questi contesti credo che le parti più nascoste del proprio vissuto, se si è disposti ad ascoltarle, escano fuori con forza e, senza che ce ne rendiamo conto, iniziano a manifestarsi nelle opere che mettiamo in scena. A me capita spesso di capire molto tempo dopo il vero senso e la spinta motrice che ha portato la nascita di un’idea e per certi versi mi sentirei in difetto se sapessi tutto in modo esatto già all’inizio del processo, togliendomi così la possibilità di poter scoprire in corso d’opera quello che sta accadendo.
«Nell’oscurità nella quale vagavo, ho visto le ombre grigie di memorie che non sapevo di aver perduto». Sono pochi i dialoghi presenti nel film, ma emerge cuna loro autentica poeticità. Che rapporto ha con la scrittura?
Il mio rapporto con la scrittura è molto conflittuale. Di tutte le fasi che portano alla nascita di un’opera cinematografica è per me la più complessa e sofferta, anche perché è il momento in cui le possibilità sono sterminate e capire dove si sta andando diventa una sfida. In questo caso c’è stata sia una fase di scrittura strutturale preliminare (fatta più che altro di appunti sparsi poi riorganizzati), ma soprattutto una fase di scrittura post riprese, che si è mossa in parallelo alla fase di post-produzione e che è durata diversi mesi. Soprattutto come calibrare i dialoghi, il peso da dare a ogni singola parola, è stato un processo che ha richiesto molto tempo, dove da un lato l’obiettivo era quello di creare un contrappunto narrativo alle immagini e di convogliare una dimensione emotiva, dall’altro c’era anche la volontà di non attingere a un vocabolario inutilmente complesso ma di restare con la parola il più semplici e sinceri possibile. In questo senso, la straordinaria capacità di esaltare la semplicità del quotidiano di Ungaretti è stato un faro da seguire durante la fase di scrittura.
Nel 2022 lei è stato ammesso all’esclusivo CreatorsLab: “una conversazione” è il tema da sviluppare nel workshop. Ed è qui che, sotto la supervisione di Apichatpong Weerasethakul, Palma d’oro al Festival di Cannes 2010, realizza Las Memorias Perdidas de los Árboles. Quanto è stato decisivo il confronto con questo maestro del cinema contemporaneo per riuscire a raccontare in un modo così coraggioso la storia che aveva in mente?
Il rapporto con Api (così lo chiamavamo durante il workshop) è stato decisivo nel nostro sentirci liberi di raccontare quello che sentivamo. Di base durante il workshop lui non entra mai troppo nel dettaglio del progetto dando suggerimenti o consigli troppo specifici: quello che fa è molto più interessante. Riesce a creare uno spazio creativo stimolante, dove ci si sente liberi di poter condividere le proprie idee e soprattutto se stessi, liberi da ogni giudizio e privi di qualsiasi forma di competizione che si sarebbe facilmente potuta creare dato che eravamo 50 registi in totale. Eppure nulla di tutto ciò è mai accaduto proprio grazie all’enviroment “protetto” che Api riesce a creare. Ogni giorno meditavamo dalle 6 alle 7 del mattino, dopodiché si aprivano lunghe conversazioni inerenti temi specifici. In alcuni casi più che un workshop di cinema sembrava di essere immersi in una seduta di psicoterapia di gruppo. Api ci ha condotto in un viaggio fisico e spirituale, aiutandoci ad entrare in contatto con delle parti molto profonde di noi stessi, mettendo in discussione quello che il cinema può essere e guidandoci con gentilezza e curiosità verso dimensioni espressive che potessimo sentire più vicine ai nostri mondi interiori e possibilmente distanti dai nostri riferimenti cinematografici che, volenti o meno, ci influenzano in continuazione.