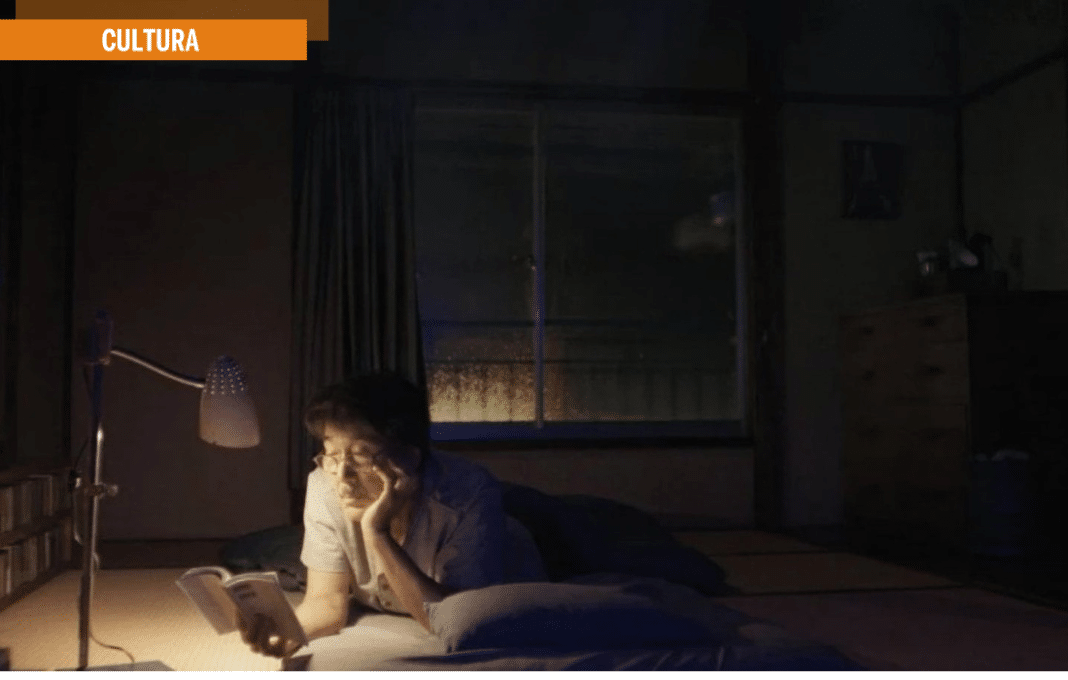In poco più di due settimane ha raggiunto quote importanti di spettatori. Parliamo di Perfect Days, l’ultimo film di Wim Wenders, candidato agli Oscar, opera complessa e straordinariamente poetica, un’imprescindibile riflessione sul cinema e sul suo linguaggio.
Protagonista è Hirayama (Kōji Yakusho, già vincitore del premio come miglior attore al Festival di Cannes), un addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo che trascorre una vita apparentemente ordinaria, scandita da gesti quotidianamente reiterati, ma ogni volta osservati da una diversa angolatura, da un diverso punto di vista, e sui quali il regista sembra orientare lo sguardo – e la sensibilità – dello spettatore, affinché possa soffermarsi su quanto non è immediatamente visibile e percepibile. Una originale ricerca sull’immagine che parte da lontano, dal documentario Tokyo-Ga, presentato al Festival di Cannes del 1985 nella sezione Un Certain Regard, che Wenders realizza nella primavera del 1983. E dopo quarant’anni, Wenders torna in Giappone, facendo sue molte delle intuizioni del regista giapponese Yasujirō Ozu, al quale il documentario era dedicato. Un omaggio a quell’armonia che Dario Tomasi individua nella composizione strutturale del cinema di Ozu, in particolare in Fiore d’equinozio (Higanbana, 1958), dove le immagini costituiscono quasi un prolungamento, nel tempo, di particolari stati d’animo vissuti dai personaggi, tanto da configurarsi, secondo lo storico del cinema, come “immagini-sentimento”.
L’apertura degli occhi, al mattino, di Hirayama – stesso nome peraltro del protagonista del film di Ozu -, e il susseguirsi dei gesti compiuti dall’uomo, spingono lo spettatore ad attivare una visione ulteriore su quanto si delinea come semplice accadimento del quotidiano. Al di là della sofisticata tessitura drammaturgica, ciò che affiora prepotentemente nella ripetizione dei gesti, nei prolungati silenzi, è la tenacia stessa del regista nell’andare ad intercettare le innumerevoli possibilità e i nuovi scenari per declinare e rappresentare le immagini. Una ricerca sorretta da una autentica e salda tensione conoscitiva e da uno sguardo costantemente puntato sulla realtà. È la capacità dell’artista di porsi in relazione col mondo e, al contempo, di riflettere sul linguaggio cinematografico quale fondamentale strumento di indagine per veicolare idee e pensiero.
Hirayama è appassionato di letteratura (uno dei libri che appare nel film è Urla d’amore della scrittrice Patricia Highsmith, di cui Wenders ha adattato Ripley’s Game per il suo film del 1977, L’amico americano) e di fotografia: l’uomo possiede una macchinetta analogica con la quale tenta di catturare l’intima essenza delle cose, quanto di inafferrabile sembra esservi nell’immagine, soffermandosi sui dettagli, su una particolare luce, un impercettibile movimento di foglie. Perfect Days, scritto da Wenders insieme a Takuma Takasaki, rievoca e riparte da quell’antica e quanto mai necessaria riflessione sulle possibilità di rappresentazione dell’immagine, di cui in Tokyo-Ga – realizzato durante una pausa dalle riprese del film Palma d’oro a Cannes, Paris, Texas (1984) –, si confrontava, oltre che con alcuni collaboratori di Ozu, anche con Werner Herzog.
Tra i promotori del Nuovo cinema tedesco degli anni Settanta, Wenders sperimenta, fin da subito, una modalità di rappresentazione totalmente nuova rispetto alle norme codificate dal cinema classico che ponevano, in particolare, l’accento sulla linearità della storia. Lo stato delle cose (Der Stand der Dinge) del 1982, premiato a Venezia con il Leone d’oro al miglior film, mette a nudo proprio il dispositivo cinematografico, esibendone e rivelandone le innumerevoli possibilità nel momento stesso della creazione. Esemplare è la scena in cui una donna racconta a una bambina il motivo del suo pianto: «Piango perché è così straordinariamente bello e io non riesco ad afferrarlo. So che è soltanto una questione di chiaroscuri, ma guardo tutto questo e tutto ciò che vedo è… niente. … In natura è tutto un grande chiaroscuro, cioè l’unico modo in cui puoi dipingere questo è di accostare le zone chiare a quelle scure, altrimenti non è niente. Tutto ciò che vedi è chiaro e scuro, fatto di ombre e di luci. Vedi? L’onda è la luce, e lo spazio tra le onde, i cavalloni, è l’ombra. Ed è questo che dà la forma». In Perfect Days sarà Tomoyama (Tomokazu Miura) a rilanciare un medesimo interrogativo, quando chiede a Hirayama: «Le ombre sono più scure quando si sovrappongono?». La risposta, probabilmente, risiede in quell’incontro di luci e ombre – i cui inserti nel film sono a cura di Donata Wenders -, in quel gioco impalpabile e poetico che allude all’invisibile bellezza dei rapporti interumani e del rapporto con la natura, quale condizione interna di godimento e di ricerca.
Niccolò Farra – il protagonista del film Identificazione di una donna, presentato a Cannes nel 1982 quando Wenders incontra per la prima volta Michelangelo Antonioni – all’amico che gli chiede del suo prossimo film e dell’immagine femminile ideale di cui è alla ricerca, risponde di preferire, nel rapporto con una donna, il silenzio, «un tipo di rapporto come con la natura … davanti al mare, in mezzo a un bosco, da solo che fai? Guardi in silenzio. Però, senza che tu te ne accorga, un dialogo c’è!».
Hirayama non è un eroe solitario del quotidiano: nell’osservare il mondo non vi è malinconia, né rassegnazione, né tantomeno rinuncia, ma una incessante e silenziosa ricerca del ritmo lento e naturale delle cose e finanche dei rapporti, ai quali si mostra capace di rispondere con interesse e affettività (si pensi all’incontro con la nipote Niko – Arisa Nakano – e al personaggio di Mama – Sayuri Ishikawa – di cui il protagonista è segretamente innamorato). Più che i gesti sono i movimenti del personaggio a ridisegnare nuovi percorsi interiori, come quelli impercettibili che vediamo sul volto del protagonista nel finale, capace di passare dalla delicatezza di un sorriso a una profonda e sincera commozione, in risposta a una ricettività latente e alle intime risonanze interne. Percorsi sostenuti da una colonna sonora iconica che include brani, tra gli altri, degli Animals, di Lou Reed, Patti Smith e Nina Simone che, sulle note di Feeling Good, accompagna l’intenso primo piano del volto di Hirayama nel finale («It’s a new dawn, it’s a new day, it’s a new life for me and I’m feeling good»).
Racconto e sguardo, ricerca sull’immagine e rappresentazione. È questa la grande sfida sottesa al cinema di Wenders: andare a vedere cosa c’è sotto l’immagine. Probabilmente è la ricerca affidata dal regista a Hirayama, al suo modo ‘gentile’ di osservare la realtà, anche attraverso la fotografia. Strumento attraverso il quale Thomas, nel film di Antonioni Blow-up (1966) – considerato da Wenders importante per la sua formazione di giovane studente -, porta avanti la sua indagine su quanto si nasconde dietro l’obiettiva materialità fenomenica. Ed è proprio qui che la ricerca sull’immagine di Antonioni diviene più incisiva: «Noi sappiamo che sotto l’immagine rivelata ce n’è un’altra più fedele alla realtà, e sotto quest’altra un’altra ancora, e di nuovo un’altra sotto quest’ultima. Fino alla vera immagine di quella realtà, assoluta, misteriosa, che nessuno vedrà mai. O forse fino alla scomposizione di qualsiasi immagine, di qualsiasi realtà».
La domanda che Wenders ha rivolto ai suoi colleghi, tra cui Herzog e Antonioni, nel documentario Room 666, in occasione del Festival di Cannes del 1982, «Il cinema è un linguaggio che sta scomparendo o un’arte che sta morendo?» ha indubbiamente trovato in Perfect Days una delle sue più sorprendenti e poetiche risposte.