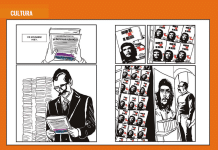Sarà presentato alla 74esima edizione del festival di Berlino (15 febbraio-25 febbraio), sezione Forum, Il cassetto segreto la nuova opera di Costanza Quatriglio, “racconto sentimentale che dalle mura di casa abbraccia la Sicilia, l’Europa e il mondo, in un secolo di storia”. In attesa di vedere il suo nuovo lavoro alla Berlinale, l’abbiamo incontrata per parlare della sua opera d’esordio L’isola che è uscita in home video (con Mustang Entertainment nella versione restaurata in 4K dai laboratori di Cinecittà) a vent’anni dall’anteprima mondiale a Cannes. Il film, che è stato ospite alla festa Festa del Cinema 2023 di Roma nella sezione autonoma e parallela di Alice nella Città, è corredato di diversi contributi extra tra cui il making of “Racconti per L’isola”, presentato a Venezia nel 2003.
La storia di Teresa e Turi, i due giovanissimi protagonisti de L’isola cresciuti in una famiglia di pescatori sull’isola di Favignana e alle prese con l’importante passaggio dall’infanzia all’adolescenza, è una storia senza tempo dalla quale emerge l’originalissima poetica di Costanza Quatriglio, che mette costantemente in gioco lo sguardo dello spettatore al quale si chiede di andare sempre più in profondità, soprattutto nei momenti di sospensione del racconto quando a emergere è la ricerca sulle immagini.
Costanza, come ha inizio questa tua personalissima ricerca?
L’isola arriva nel momento in cui, molto giovane, ho cominciato a fare cinema – il film, uscito nel maggio 2003 a Cannes, era stato girato nell’arco del 2002 – avvicinandomi fin da subito al mondo dei bambini e degli adolescenti. Avevo molto desiderio di interrogare quell’età di passaggio della vita. Perché, prima ancora de L’isola, avevo realizzato i miei primi documentari a Palermo, Ècosaimale? e Il bambino Gioacchino, nei quali i protagonisti erano bambini palermitani, e poi un film sulle adozioni internazionali, L’insonnia di Devi, dove la storia era raccontata dal punto di vista dei bambini e degli adolescenti adottati in Italia, che avevo accompagnato in un viaggio in India. In questi film realizzati prima de L’isola indagavo il mondo interiore dei bambini e degli adolescenti, mentre per quanto riguarda L’isola non parlerei di indagine, parlerei piuttosto di adesione.
Che effetto ti fa rivedere l’Isola?
Ho sempre sentito una forte adesione al mondo interiore di Teresa e di Turi. E, a distanza di vent’anni – vent’anni pieni di vita e di mestiere -, guardando L’isola nelle fasi del restauro, ho pensato che questa adesione la sento ancora molto e mi riconnette con una parte profonda di me che appartiene fondamentalmente a uno sguardo di adesione al reale, anche nella trasfigurazione fantastica. Turi e Teresa, entrambi personaggi inventati, attingono a sentimenti, sguardi, desideri che, in parte, erano anche i miei, i miei di bambina nell’isola di Favignana dove io trascorrevo le estati. Allo stesso tempo erano anche tanto universali, in quanto possono essere considerati i desideri delle bambine e dei ragazzi di ogni tempo e luogo. Direi, quindi, che negli anni del mio esordio ero molto attenta a raccontare il mondo dei bambini e degli adolescenti e, se nei documentari precedenti c’era stata la volontà di indagare dei mondi – il mondo dei bambini di strada di Palermo, dei ragazzi adottati – cosa che ho fatto anche dopo con il documentario sui minori stranieri non accompagnati, Il mondo addosso, ne L’isola invece c’è proprio un’adesione totale.
Quanto c’è di autobiografico nel racconto de L’isola?
Di autobiografico c’è tutto e non c’è niente. La trama non ha nulla di autobiografico, ma i sentimenti di Teresa e la relazione che Teresa ha con questa isola, che è una relazione di grande libertà, sicuramente corrisponde a un sentimento che io, da donna adulta, riconosco essere stato il sentimento di me bambina quando passavo le estati nella mia isola del cuore. È l’infanzia. In qualche modo è come se il film fosse la trasposizione magica di un ricordo. È come se, attraverso questo film, avessi costruito all’età di 28, 29 anni – quando ho girato L’isola – un ricordo sentimentale, a misura mia.
Il racconto, quindi, di risonanze interne, di rielaborazione di memorie antiche…
Di una memoria antica che, però, è in realtà condivisibile da tutte e da tutti, perché tutti noi siamo stati ‘l’isola’. ‘L’isola’ ci riguarda, in qualche modo. È un’isola interiore quella che ci portiamo dietro e che ci portiamo dentro.
Questa universalità delle immagini, che emerge e colpisce molto nel tuo film, è quello che caratterizza il cinema d’autore, un cinema senza tempo, attualissimo anche a distanza di anni, proprio perché rappresenta, prima ancora dei fatti, le dinamiche interne dei personaggi.Quanto è significativo per te, nella composizione delle immagini, il rapporto tra il personaggio e lo sfondo, tra il personaggio e l’ambiente?
Il rapporto tra personaggio e ambiente è un rapporto molto importante in termini di narrazione, perché gli ambienti raccontano i personaggi e i personaggi sono inclusi dentro l’ambiente che li contiene. È l’ambiente stesso a risuonare dentro di loro. I personaggi non possono che essere il frutto dell’interazione con l’ambiente, e della loro appartenenza all’ambiente. Teresa, con la sua indole, col suo puntiglio, con il suo desiderio di essere parte del mistero della vita (pensiamo alla nascita del vitellino o alla preghiera al nonno in fondo al mare), non può non essere legata alla natura stessa dell’isola.
Nelle immagini dell’ambiente più ariose che ho costruito con la macchina da presa, le proporzioni sono abbastanza chiare: Teresa è un puntino, i personaggi in mezzo al mare sono dei puntini. Quindi c’è il senso di un cosmo, di qualcosa di molto più grande e misterioso che li contiene.

In qualche modo, anche il crollo del muro è connaturato al muro stesso. È come se quel muro non fosse che destinato a crollare. Io non lo sento come un ostacolo, lo sento piuttosto come un’occasione.
Molto bella è l’immagine, evocata dalle parole di Teresa, di questo incontro tra ‘isola’ e’ ‘rusasi’: è come se l’incontro tra le reti utilizzate dai pescatori per formare le pareti che dal fondo del mare affiorano a pelo d’acqua, e i contrappesi di tufo, richiamasse un altro tipo di incontro. Quindi ti chiedo: qual è, per te, oggi, un incontro auspicabile nel cinema italiano? E quali le tematiche più urgenti?
Se mi parli dei blocchi di tufo, cioè dei ‘rusasi’, e del mare, io ti dico che quella per noi è un’immagine molto potente perché significa, in qualche modo, una riconciliazione tra la pietra e l’acqua: quando il tufo è nel fondo del mare torna ad essere l’elemento che sta lì dalla notte dei tempi, quindi ha a che vedere con l’imperitura natura dell’isola.
Quello che io penso sia auspicabile nel nostro cinema, a livello di incontro, è quello tra i bisogni reali di ciascuno e di ciascuna di noi e la rappresentazione di questi bisogni. Penso che il grande exploit del film di Paola Cortellesi ci dimostra, non solo il talento straordinario di questa donna che è stata capace di fare un grande racconto mettendosi nei panni di un grande personaggio e anche sapendolo dirigere molto bene, sapendo fare un bel film. Ma ci dimostra anche che c’era un deficit di narrazione. Allora, perché venga colmato il vuoto di narrazione c’è bisogno di più libertà, c’è bisogno di osare nei racconti. Che riguardano i bisogni degli esseri umani, anche quello di riconoscersi in ciò che vedono.
E da parte di noi spettatori e spettatrici c’è stata una risposta sorprendente al film di Cortellesi, C’è ancora domani. Che ne pensi?
Gli spettatori e le spettatrici hanno risposto in modo così caloroso perché hanno sentito che quel film toccava delle corde a loro care. Ecco, quindi l’incontro riguarda, a mio parere, la capacità del nostro di cinema di cogliere i bisogni degli esseri umani, il bisogno che gli esseri umani hanno di sentirsi radicati in un mondo comune, di non essere soli al mondo. Perché se noi facciamo sentire gli esseri umani soli al mondo, sempre un passo indietro rispetto alla rappresentazione del mondo, allontaniamo, non avviciniamo. Se, invece, il cinema ci racconta di noi, di chi siamo noi, allora ci avvicina.
Secondo te quanto lo sguardo femminile riesce ad intercettare meglio determinati bisogni?
Piuttosto credo che lo sguardo femminile, proprio perché è stato troppo relegato a essere uno sguardo non ufficiale, non legittimato, ha per sua natura quell’entusiasmo della novità. Ma il problema è sempre lo stesso: dove ci sono i soldi non ci sono le donne. È ora che più donne gestiscano budget importanti perché non bisogna cadere nella trappola del film realizzato da mano femminile che racconta qualcosa di intimo o in modo intimistico. Non è così che se ne esce.
Quest’ultima edizione della Festa del cinema di Roma ha dato molto risalto al talento femminile: penso, oltre alla proiezione del tuo film nella versione restaurata ad Alice nella città, a C’è ancora domani di Paola Cortellesi, che hai citato, e a Tante facce nella memoria di Francesca Comencini. Come se si fosse manifestata l’urgenza, in questo preciso momento storico, di affrontare, attraverso uno specifico sguardo, tematiche profondamente umane, oltre che storiche e sociali. Sbaglio?
Diciamo che per troppo tempo anche la grande letteratura è stata considerata la letteratura al femminile. Quello che noi dobbiamo evitare è che il cinema fatto dalle donne diventi il cinema delle donne, il cinema al femminile. Però dobbiamo essere anche noi donne, in qualche modo, a rifiutare questa etichetta. Ma non è facile, perché nel momento in cui senti che hai voce e che la tua voce può essere ascoltata in questa bolla del cinema al femminile, non sempre è facile avere la forza di dire: ‘No! Guardate che io non voglio stare dentro quest’etichetta qua!’ Perché a volte è più urgente dire le cose piuttosto che spendere fiato per questi discorsi che sono duri a morire.
Cinema di finzione e cinema di realtà: in entrambi, è evidente il tuo processo di scavo costante e necessario, sia rispetto al racconto sia rispetto alla composizione delle immagini. Che rapporto c’è tra cinema di finzione e cinema di realtà? Penso, ad esempio, al tuo film Con il fiato sospeso.
È un rapporto innanzitutto di interscambio, non posso pensare il cinema se non in un modo che, da qualche parte, riguarda il mondo in cui viviamo. Quindi, anche il film più straordinariamente fantastico, più straordinariamente d’avventura o addirittura di fantascienza, non può non relazionarsi alle cose umane. Per me questo è dirimente. Poi, personalmente, il cinema di finzione che finora ho realizzato si è nutrito in qualche modo di uno sguardo sul reale. Però senza steccati, senza confini netti tra cinema di finzione o documentario.
Qualunque sia la modalità di racconto, l’artista deve quindi mantenere saldo il legame, il dialogo, con la realtà, anche rielaborandola in termini di rappresentazione. A riguardo, mi viene in mente il film di Ocelot, Dilili a Parigi, nel quale il regista affronta il tema fondamentale della negazione dell’identità umana della donna, e lo racconta mediante la sparizione del corpo di queste giovani donne e bambine che scompaiono misteriosamente. È un racconto di fantasia calato assolutamente nella realtà, nel presente. Perché questa scelta?
Sì, perché la realtà si può raccontare in miliardi di modi diversi. Raccontare la realtà non significa essere passivi nei confronti della realtà. Raccontare la realtà significa, al contrario, costruire mondi che possono proporre visioni del mondo, una visione del mondo. E la visione del mondo la proponi se tu sei capace di interpretare il mondo in cui sei. Attenzione a non scambiare ‘visione del mondo’ per dottrina. Mi riferisco a qualcosa di molto meno palpabile che riguarda chi sei. Se sei mite o abitato dal mito della forza, se hai una connessione con una dimensione spirituale o no, se pensi il bene o no, e così via. Perché il momento in cui guardi attraverso la macchina da presa, è in quel momento che tu definisci lo spazio del mondo che vivi.
Le musiche hanno sempre un ruolo fondamentale nei tuoi film, sia a livello evocativo che drammaturgico. Penso alla suggestiva e poetica colonna sonora de L’isola, composta da Paolo Fresu e anche al brano 87 ore dei 99 Posse nel film 87 ore – Gli ultimi giorni di Francesco Mastrogiovanni. Come le immagini le musiche e perché le affidi a quel compositore in particolare?
Da quando ho cominciato a fare cinema, quando faccio un film penso alle musiche prima ancora di realizzarlo, prima di mettere le mani in pasta. Mi piace immaginare il mondo musicale che può accompagnare il mio film perché sento che la musica è parte integrante della narrazione, ma anche per il sapore, per il tono. Ho avuto la fortuna di lavorare con grandi musicisti. Ho cominciato con Paolo Fresu, ho lavorato con Paolo Buonvino, con Teho Teardo, con Luca D’Alberto, ma anche con Marco Messina, con Vladimir Denissenkov… Quando decido di parlare con un musicista del film che devo fare, io cerco, nella relazione col musicista, un rapporto di complicità, di scambio e di crescita comune. Quello che mi piace e che, nella mia esperienza, ho avuto la fortuna di sperimentare, è di poter essere, in questo dialogo, sempre molto presente. Questa combinazione degli atti creativi, di dialogo tra la creazione della musica e la macchina da presa porta al risultato che c’è nel film. Non è mai accaduto che io lavorassi alle musiche di un mio film dopo aver fatto il film, a film finito.
Qual è l’autore, l’autrice che senti più vicino?
Faccio sempre fatica a rispondere a questa domanda perché amo talmente tanto il cinema e talmente tanto i generi di cinema, tutti diversi fra loro, che per me è molto difficile fare una graduatoria di film preferiti, o di autori e di autrici preferiti. Nel momento in cui ne dico uno me ne vengono in mente tanti altri. È come se dovessi scegliere se respirare con un polmone o con un altro.
Così come se tu mi avessi chiesto qual è il mio cinema, io farei molta fatica a rispondere, proprio per questo diffido dagli autori che dicono «Il mio cinema», che sanno definire perfettamente qual è il loro cinema perché, secondo me, il cinema è un modo di vivere, e quindi cristallizzare il modo di fare cinema, definendolo per ora e per sempre, per me è un limite.