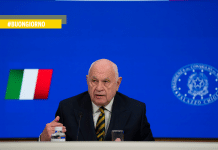La Biennale itinerante del sociale (Bis) ha aperto le sue porte alla prima edizione, un evento unico organizzato dall’Associazione Pachamama. Questo progetto itinerante attraversa due continenti fino al 28 agosto, con tappe in quattro città: Brescia e Roma già toccate nel mese di maggio, Genova (8-14 luglio) e Iquique (Cile) dal 22 al 28 agosto.
Per la fondatrice e presidente dell’associazione, Paula Jesus, fotografa e regista per Unicef, Pachamama – in lingua quechua “madre spazio tempo” – rappresenta la Terra ideale: un luogo capace di ospitare e proteggere i diritti umani e ambientali. Paula, nata in Cile da una famiglia poco tradizionale simile a una tribù indigena, vede in Pachamama un luogo senza confini fisici e temporali, un’energia che abbraccia tutto e tutti.
«Da migrante, desideravo creare qui in Italia un luogo dove sentirmi veramente a casa. Le lettere di Pachamama mi ricordano l’eco del Sudamerica e i sentimenti del Sud del mondo».
L’associazione è nata con l’obiettivo di fondare la Biennale itinerante del sociale (Bis), un osservatorio attivo che, attraverso la fotografia di reportage, esplora le problematicità e le contraddizioni della nostra modernità, tra cui guerre umanitarie, crisi ambientali, migrazioni e razzismi. Un movimento per il cambiamento, una finestra sul mondo che invita a vedere, comprendere e agire consapevolmente per costruire un mondo più giusto e sostenibile. Alla Bis partecipano tredici fotografi internazionali: Isabella Balena, Patrizia Riviera, Giambalvo&Napolitano, Paula Jesus, Pino Bertelli, Israel Fuguemann, Stefano Sbrulli, Dario De Dominicis, Joseph Gazzano, Johan Berna, Matteo Placucci e Murat Yazar. Tutti sono impegnati attivamente nel campo dei diritti umani e ambientali. Le loro opere raccontano storie potenti e viscerali, offrendo uno sguardo critico sulla nostra realtà.
Per Paula, questa rappresenta l’edizione zero, un impulso verso qualcosa che nei prossimi anni si posizionerà come un osservatorio sui diritti umani. Un luogo dove fotografi già affermati e nuovi talenti possano riconoscersi e sentirsi a casa.
«Creare una rete, un percorso, un itinerario lungo le tracce delle città che ci ospiteranno. La Bis è partita da Brescia, la città dove attualmente vivo. Insieme a Marco Cola, co-fondatore, lavoriamo ogni giorno per rendere la Bis sostenibile e solida».
A Genova, grazie ad Arianna Maestrale, collaboratrice dell’associazione, si è avviato un dialogo con le scuole dei quartieri genovesi dove si terranno laboratori con bambini che vivono in una realtà attarversata dal fenomeno della tossicodipendenza e della prostituzione. «Grazie alla partnership con l’associazione San Marcellino, che ci ha aiutato a conoscere meglio il territorio e le dinamiche interne che lo caratterizzano – racconta la fotografa – possiamo portare il progetto nelle scuole, in quegli istituti dove l’innamorarsi della bellezza è un diritto negato e mai riconosciuto».
Paola Jesus, come sono stati scelti il team di fotografi e gli ospiti per questa prima edizione della Bis?
Abbiamo aperto una call che non ha avuto l’esito sperato; tuttavia, la rilanceremo verso novembre 2024. Il team di Pachamama ha creato una rete per trovare i reportage più adatti alla nostra prima edizione. Io mi sono occupata principalmente della direzione artistica, insieme alla curatrice e giornalista Simona Isacchini. Paolo Finistrella ha lavorato sulle traduzioni, fondamentali per il carattere itinerante della Biennale. Ad aiutarci nella ricerca dei fotoreporter sono stati colleghi, gallerie, giornalisti, attivisti e cooperanti internazionali. La risposta è stata entusiasmante: molti si sono mobilitati e così abbiamo creato una collettiva composta da diversi autori. In ogni città, la Bis presenterà una serie di mostre fotografiche, talk, workshop e proiezioni cinematografiche. Le attività si svolgono sia nei centri urbani che nelle periferie, coinvolgendo una vasta gamma di spazi museali pubblici e privati, tra cui: MO.CA – Centro per le nuove Culture, Officine Fotografiche, Palazzo Ducale e il Museo Regional di Iquique. Con l’itineranza, la Bis si avvicina a diverse realtà sociali, economiche e culturali, costruendo reti e sinergie per agire localmente con un pensiero globale.
Qual è stato il feedback ricevuto dalle comunità locali delle città che ospitano la Bis, in particolare nelle aree più delicate come le baraccopoli di Iquique?
Le città e le istituzioni coinvolte hanno mostrato fin da subito grande disponibilità, abbracciando il progetto con entusiasmo e sorprendendoci positivamente. In Cile, la nostra consigliera sul campo, Francisca Oñate Oyaneder, ricercatrice universitaria presso la Scuola di architettura e design Pucv di Valparaíso, ha stretto legami con i nostri partner locali a Iquique. Grazie a Ruco, il primo festival d’arte contemporanea della regione, possiamo operare in sinergia con le necessità e le criticità del territorio, attraversando le baraccopoli della città. La situazione a Iquique è estremamente critica: è diventata una città migratoria di confine, con l’arrivo di molti venezuelani. Parallelamente, sono aumentate la prostituzione e la tratta di donne e bambine. Iquique è una terra di confine che vede nuovi traffici di droga e una rapida crescita della tossicodipendenza. Dal punto di vista ambientale, è un disastro: un luogo di estrazione mineraria, inquinamento marino e dell’aria. Inoltre, Iquique è una delle discariche tessili più grandi al mondo, ricevendo container dall’Italia, Bangladesh, Pakistan e Nord America.
La Bis porta l’arte ai margini della povertà.
Il nostro lavoro a Iquique esprime al meglio cos’è e perché è nata Pachamama. Oltre a organizzare mostre fotografiche all’interno del Museo regionale delle Belle Arti, impegneremo i nostri sforzi a lavorare con i bambini e le bambine che vivono nelle discariche tessili. Ci saranno diversi laboratori di microeditoria e fotografia. Porteremo il cinema all’aperto nelle baraccopoli e dialogheremo con le scuole che vivono condizioni di fragilità sociale ed economica.
Quali sono i tuoi sogni o aspirazioni per il futuro della Biennale itinerante del sociale?
Vorrei che la Bis diventasse un vettore di cambiamento individuale e collettivo. Il mio sogno è che questo percorso, che è un itinerario lungo le vie della consapevolezza, non si fermi mai. Gli obiettivi di questa Biennale si possono raggiungere solo se c’è un team solido, dove giovani donne siano riconosciute e valorizzate, e dove possano apprendere l’una dall’altra, in una sorta di nostra Pachamama.
L’autrice: Sara Alawia è un’attivista dei diritti umani
In apertura: Paula Jesus, Pakistan