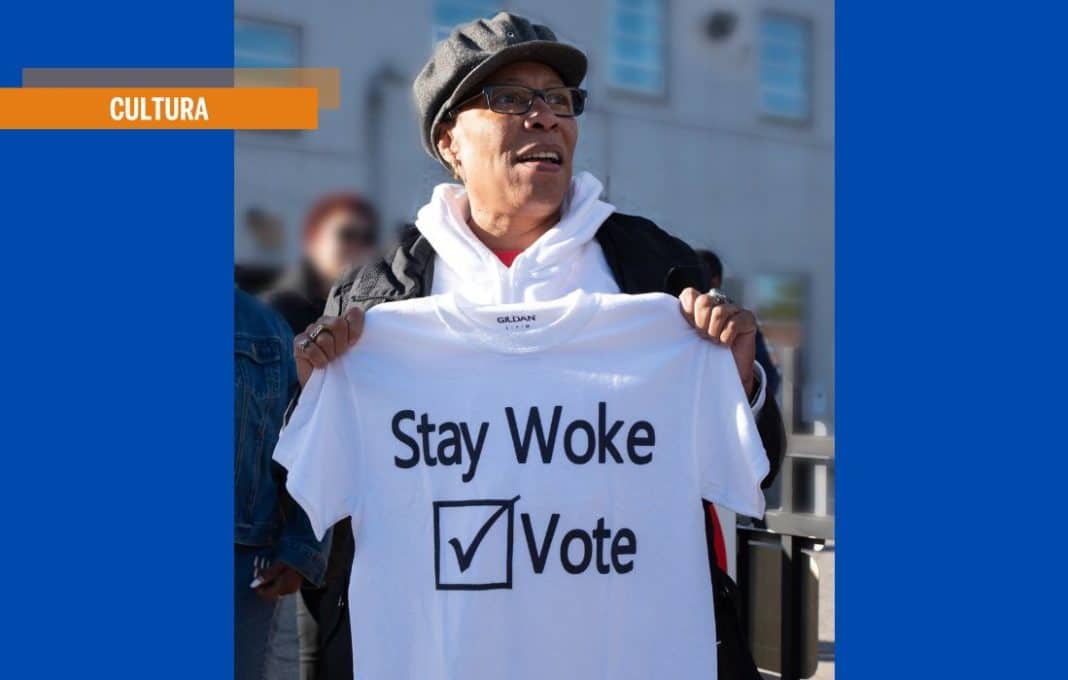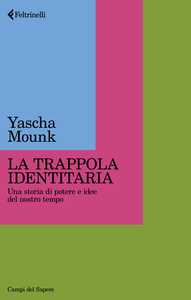Un mutamento epocale. Una svolta paradigmatica nelle strutture del pensiero, della società e della politica a cui, ancora oggi, tocca dare un senso e una forma. Questo, in molti saggi, sembra il lascito più cospicuo degli anni Sessanta e Settanta al nostro presente. È con tale assunto, ad esempio, che Michel Benaysag e Gerardt Schmidt esordiscono nel celebre L’epoca delle passioni tristi, e simile è il punto di partenza di Michael Sandel nel suo recente La tirannia del merito. Molti, tuttavia, restano gli interrogativi in sospeso. Quali le cause, quali le radici di una tale svolta? Raramente le analisi politologiche e sociali si soffermano sull’analisi dei processi storici; e, come un sasso che, lanciato sul mare, ne increspa la superficie senza tuttavia scendere sul fondo, l’impressione è che il nocciolo della questione non sia stato ancora colto.
È su questo silenzio che si sofferma meritoriamente l’ultimo saggio di Yascha Mounk, La trappola identitaria. Una storia di potere e idee del nostro tempo (Milano, Feltrinelli, 30 euro). Qual è l’argomento? Il titolo – fedele trasposizione, bisogna dirlo, di quello originale – lo preannuncia: è la storia di come gli ambienti liberal statunitensi abbiano progressivamente abbandonato gli ideali e gli scopi universalistici che fino agli anni Sessanta-Settanta avevano permeato la politica dei partiti di “sinistra” e di come l’abbiano sostituita con quella che l’autore, nel voler evitare il termine ormai ideologicamente connotato di “filosofia woke”, preferisce definire come “sintesi identitaria”.
È un processo le cui radici non sono prossime: e infatti Mounk le rintraccia nelle aule della Parigi pre-sessantottina, dove un giovane Michel Foucault, nel rigettare “le grandi narrazioni” della scienza, ne sottolineava i legami con l’autorità governative e con tutte quelle “micropolitiche” che impedivano agli individui di sviluppare compiutamente la propria identità. Le segue quindi negli Stati Uniti: e qui le formulazioni foucaultiane ispirano, in un primo tempo, l’analisi post-coloniale di Edward Said, e, in un secondo, il concetto di “essenzialismo strategico” con cui Gayarti Chakravorty Spivak giustificava l’assunzione in chiave identitaria dei propri tradizionali marcatori fisici e culturali da parte degli intellettuali membri di minoranze oppresse. L’autore arriva, infine, ai primi decenni del XXI secolo, quando i principi cardine della “sintesi identitaria”, una volta elaborati e diffusi nei campus universitari, hanno raggiunto un pubblico più vasto grazie all’azione dei social network.
Quella qui delineata, ovviamente, non è una concatenazione deterministica di cause ed effetti. Né Foucault, né Said e né tanto meno Chakravorty Spivak potevano antivedere l’esito delle loro elaborazioni. Ma nemmeno noi possiamo disconoscere le esigenze e i bisogni che hanno condotto alla diffusione delle cosiddette “politiche identitarie”: quelle di gruppi sociali che, ancora oggi, sono oggetto di discriminazioni implicite ed esplicite, più o meno avallate dall’opinione pubblica e dalla comunità sociale. Non dobbiamo spingerci fino agli Stati Uniti per incontrare degli esempi. Basta restare in Italia: e basta pensare alla questione femminile. Conosciamo tutti i dati sui femminicidi. Ma è solo la punta di un iceberg di una minorità ben più radicata, e persistente. Era il 2023 quando in Italia il 43,3% delle donne tra i 19 e i 34 si dichiarava inattiva – cioè non iscritta a nessun corso di studio, e non interessata a cercare un lavoro. Adesso siamo alla fine del 2024, ma non c’è ragione di credere che la situazione sia cambiata.
E nemmeno Mounk, ovviamente, disconosce queste esigenze e questi bisogni. È un altro il punto su cui dissente: sulla capacità della “sintesi identitaria” di saper offrire a tali problemi una soluzione valida. Molti, elenca l’autore, possono essere invece i pericoli che cela. Quello di alimentare una maggiore disuguaglianza, innanzitutto. Le “politiche sensibili alla razza” aiutano i gruppi afroamericani in condizioni di disagio economico. Ma aiutano anche quei gruppi che nel disagio non vivono più da anni, tralasciando tutta quella fascia di popolazione che necessiterebbe comunque di un sostegno statale – e qui il pensiero corre agli hillbilly dei Monti Appalachi, resi celebri anche in Europa dall’autobiografia di J. D. Vance. E inoltre: le “politiche sensibili alla razza” potrebbero, secondo l’autore, essere profondamente controproducenti. Esempio di ciò è la gestione statunitense della pandemia da Covid-19, quando il Center for Disease Control incoraggiò gli Stati a vaccinare in primo luogo i lavoratori essenziali. Perché loro, e non le persone con più di 65 anni? Perché, mentre i lavoratori essenziali erano composti per la maggior parte da gruppi etnici storicamente oppressi, la popolazione anziana era, per lo più, bianca. La decisione era teoricamente equa. Aumentò tuttavia il numero dei morti: non solo tra gli anziani bianchi, ma anche e soprattutto tra quelli di colore, che, privi della copertura sanitaria, non poterono usufruire nemmeno del vaccino.
Quale la soluzione? Mounk prova a prospettarla verso la conclusione del libro. Fulcro di quest’ultima è un sentito elogio del social-liberalismo e dei suoi valori universalistici – in primo luogo, quelli di autodeterminazione collettiva e di libertà politica. Sono prospettive, argomenta l’autore, che lungo tutta l’età contemporanea hanno garantito il progresso dell’umanità; se hanno fallito, ciò è successo non per alcune loro falle intrinseche, ma perché non sono state applicate con l’universalità necessaria.
Alcune domande, tuttavia, restano sul piatto. Se questi principi sono stati così efficaci, perché sono stati abbandonati? Non è un processo che possa essere unicamente ricondotto alle pieghe di una pur densa storia delle idee. Mounk – e di questo gliene va dato atto – connette il successo della “sintesi identitaria” non solo a un processo intellettuale, ma anche a un processo politico e sociale: quello della decolonializzazione, e della formazione di élites politiche bisognose di ideologie inedite, capaci di caratterizzarne lo scopo e l’azione. E ciò potrebbe spiegarne la diffusione in Asia e in Africa. Ma in Occidente?
Mounk non ha mai mostrato, negli altri suoi libri, grande fiducia nel progresso. Ne La trappola identitaria sembra cambiare rotta: è vero, la storia dell’umanità è una storia di catastrofi continue, ma ciò che ha caratterizzato la prima fase dell’età contemporanea è stato il progresso delle collettività occidentali. Ma proprio la sfiducia in quest’ultimo sembra caratterizzare la maggior parte degli intellettuali da lui citati. Lo sono Chakravorty Spivak, Said, Foucault; ma si potrebbe anche provare a risalire controcorrente, e contro la foce, e allora troveremmo Marcuse, Adorno, Heidegger. È sfiducia nelle capacità del potere politico di garantire a tutti il libero sviluppo delle proprie capacità, sicuramente. Ed è anche e soprattutto sfiducia nelle capacità del potere politico di utilizzare a fin di bene lo sviluppo tecnologico. Le carneficine della Grande Guerra, lo scoppio della bomba atomica, sono i punti più eclatanti di un cambiamento di mentalità lungo e tortuoso, che molti decenni ha impiegato prima di risalire a galla. Su questo c’è ancora molto da scrivere. Ma è appunto questo il pregio dei buoni saggi: quello di porre sulle questioni affrontate non punti, ma virgole, per consentire a chi verrà nuovi sviluppi e nuovi discorsi – e questo, a La trappola identitaria, gliene va dato atto.
L’autrice: Chiara Martinelli è ricercatrice a tempo determinato in Storia della Pedagogia all’Università di Perugia
Nella foto: la deputata statunitense Marcia Fudge mostra una maglietta che recita lo slogan “Stay Woke: Vote” nel 2018