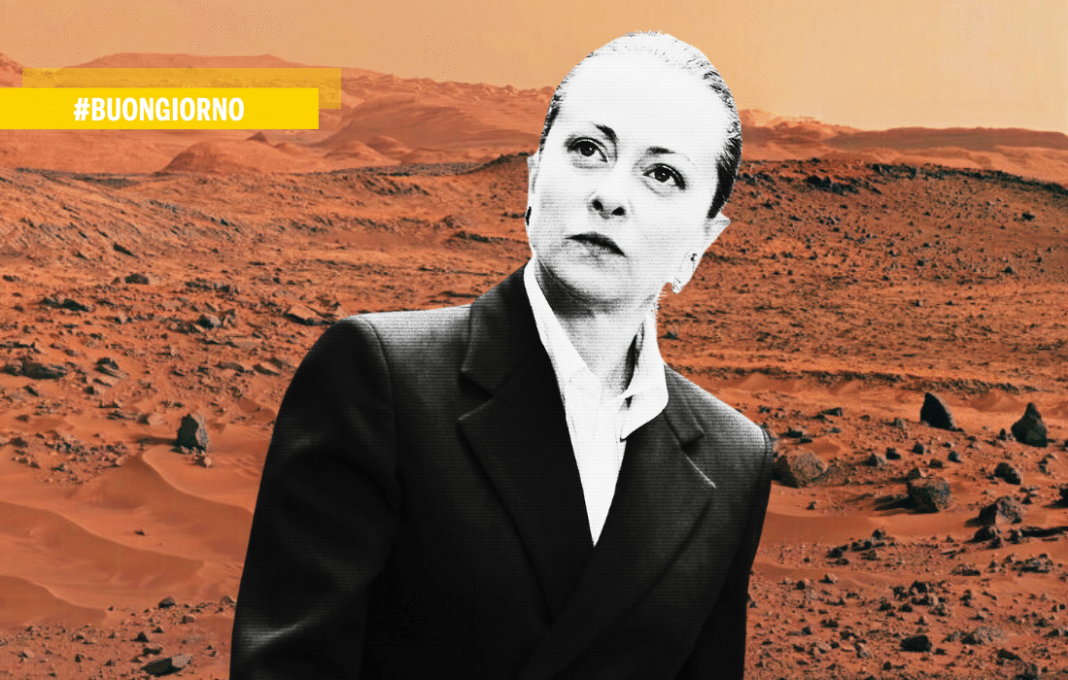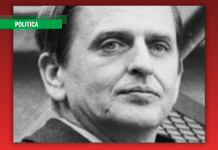C’è un Paese dove lavori e resti povero. Dove sei utile finché produci, ma invisibile quando chiedi diritti. È l’Italia del 2025, dove oltre sei milioni di persone, pur lavorando, non arrivano a mille euro al mese. Dove quasi undici milioni di lavoratori guadagnano meno di 25 mila euro lordi l’anno. È un’Italia che ha smesso di garantire, che ha reso il lavoro una scommessa quotidiana. E la perdita è sempre dello stesso giocatore.
L’83,5% dei rapporti di lavoro cessati nel 2023 è durato meno di un anno. Uno su due meno di novanta giorni. La precarietà non è una deriva: è la regola. È costruita con metodo, alimentata da contratti a termine, part-time obbligati, qualifiche basse e ricatti salariali. È un’architettura sociale in cui il lavoro non libera, ma incatena.
Questo modello è stato venduto come modernità. È solo un capitalismo che si nutre di disuguaglianza, che scarica i rischi su chi lavora e protegge solo chi incassa. E quando l’inflazione morde, quando il carrello della spesa pesa come un affitto, ci si sente dire che serve “flessibilità”. Flessibilità, cioè disponibilità a rinunciare a tutto: tempo, stabilità, diritti, salute.
I referendum dell’8 e 9 giugno sono un’occasione storica. Non per correggere qualche stortura, ma per mettere in discussione l’impostazione stessa del lavoro in Italia. Sì per chi non ha voce nei talk show. Per chi si alza all’alba e torna quando i figli dormono. Per chi ha visto il futuro ridotto a un contratto di tre mesi. Un sì collettivo, necessario, radicale. Un no secco a chi ha trasformato il lavoro in povertà a norma di legge.
Buon lunedì.