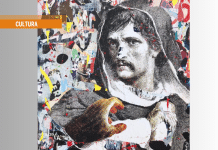Sul Corriere della Sera è andato in vetrina il caso del ristoratore di Bologna che chiede una «mancia obbligatoria del 5%» per salvare i locali dalla crisi. Chiamarla mancia è un esercizio di maquillage: se è obbligatoria è prezzo. E il prezzo si espone sul menu, si fattura, sconta l’Iva, entra nella busta paga. Tutto il resto è fumo che sposta un pezzo di salario dal conto dell’impresa al portafogli del cliente.
I conti della ristorazione sono stretti, l’energia morde, l’inflazione ha gonfiato gli acquisti: vero. Il punto però è il lavoro. Turni sfiancanti, part-time di comodo, straordinari elastici: il sistema regge se il cameriere vive di propine? In Italia i minimi li fissano i contratti, non le collettine al tavolo. Se il modello d’impresa sta in piedi solo con l’obolo coatto, il problema non è la “tirchieria” dei clienti, è la fragilità del modello.
Qui entra in scena l’informazione. Un grande quotidiano che rilancia la trovata come “soluzione” dovrebbe almeno inseguire le domande elementari: chi incassa quel 5%? come si ripartisce? è tracciato? i contratti sono rispettati? Senza queste risposte si mette il timbro di qualità su uno scivolamento culturale: il rischio d’impresa diventa tassa al tavolo, la trasparenza evapora nell’angolo delle buone intenzioni.
La via corretta è meno glamour e più adulta: prezzi chiari, conti puliti, controlli veri. Se serve, si alzano i listini e lo si dice. E se ancora non torna, si cambia organizzazione o si chiude: si chiama concorrenza. Il salario non si baratta alla cassa; e una stampa che si rispetti non vende il trucco come innovazione, ma lo smonta riga per riga, dalla prima all’ultima.
Buon lunedì.