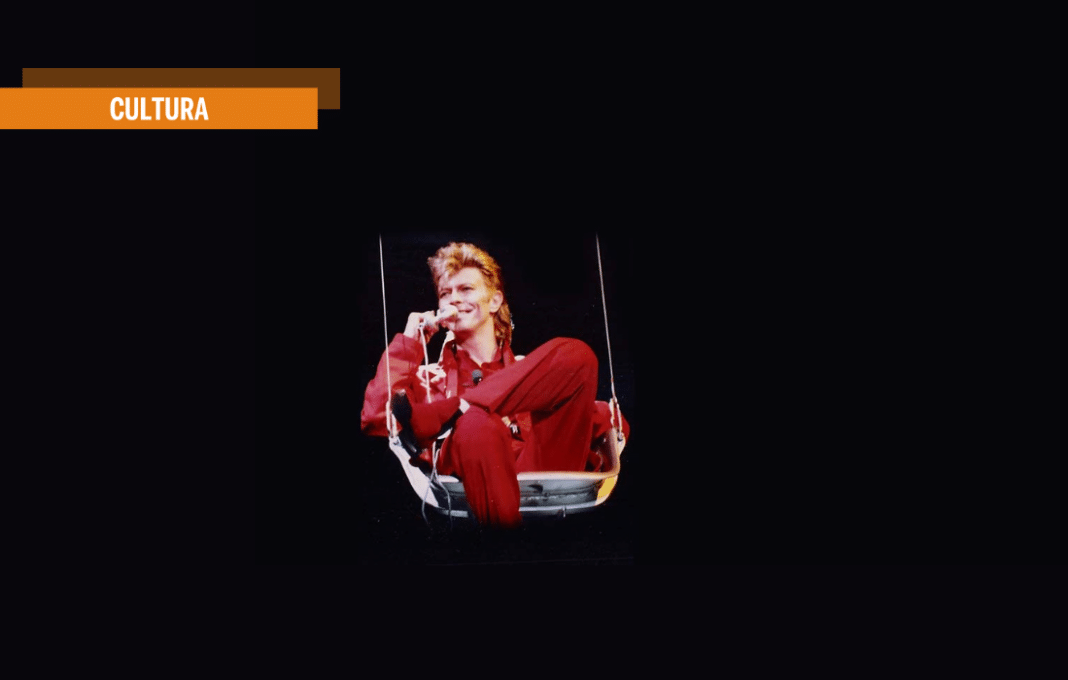Nel piccolo romanzo di formazione musicale che è stata la mia adolescenza negli anni Novanta, Bowie è apparso a Wembley nel 1992 - già icona, già imbalsamato in una fronte troppo alta, capelli cotonati - al Freddie Mercury Tribute. Lì con Annie Lennox aveva cantato “Under Pressure”, di cui noi neonati al rock scoprimmo che non era solo un pezzo dei Queen, ma anche suo. Poi, dopo una versione furiosa di “All the Young Dudes” col palco zeppo di stelle di vent’anni di storia, e una didascalica di “Heroes” - in cui stava col dito alzato a mimare le parole -, Bowie aveva zittito la folla recitando il padre nostro. In ginocchio avanti a tutti.
Tre anni dopo era riapparso in un’edizione completamente diversa: il video di “The Heart’s Filthy Lesson” venne inserito tra le rotazioni di Mtv, che all’epoca funzionava da vangelo per teenager. In quella veste, Bowie appariva inquietante in tutto, e soprattutto era decisamente un altro. Musicalmente, e nell’immagine. Nel nuovo album non c’era nulla che assomigliasse al Bowie di Wembley. 1.Outside rappresentava un universo disturbato: Bowie impersonava un detective che indagava su spaventosi delitti fatti a regola d’arte, sacrifici umani in cui le vittime lasciavano audio a futura memoria. Era impossibile mettere insieme i due Bowie, il crooner maestro di cerimonie di un rock dei tempi andati, e quell’interprete di un industrial rock striato di psicosi fatte ritmo e vigorosi tratti jazz. I passi successivi furono tormentati: il remix fenomenale di “Hello Spaceboy” coi Pet Shop Boys (“questo caos mi sta uccidendo”), infine un album con basi drum ‘n’ bass, e un singolo ancora più strano, “Little Wonder”, con un video - i video contavano tantissimo - in cui dialogava coi suoi avatar giovanili pescando occhi da tazzine di caffè, in un montaggio agitato che restituiva l’accelerazione schizofrenica della dance underground di quegli anni. Con quel brano nel 1997 Bowie si esibì addirittura a Sanremo, nello sconcerto generale di un’impossibile aderenza al nazionalpopolare. Non riuscivo, da adolescente, a seguire Bowie. Non riuscivo a desiderarlo, non mi faceva abituare, né affezionare. Venne in concerto all’Olimpico di Roma: ma qualcosa lo infastidì, dopo un’ora sola se ne andò senza più tornare, tra i fischi dei desideranti. Approfondendo la sua storia, scoprii che quel Bowie cinquantenne schivo con la cresta rossa, quel Bowie era solo l’ennesimo capitolo di una mutazione mai finita. Che ogni sua novità veniva presto dimenticata: lui agiva in anticipo - precorreva i tempi e i loro ritmi. Era un mutante - e io mi ero perso decine di passaggi. Potevo ricostruirli, ma intanto lui continuava a cambiare, secondo una dialettica di semplicità e Per continuare la lettura dell'articolo abbonati alla rivistaQuesto articolo è riservato agli abbonati
Se sei già abbonato effettua il login