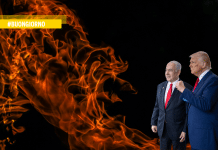C’è un Paese che si racconta efficiente, moderno, pronto a ospitare il mondo sotto i riflettori delle Olimpiadi. Poi c’è Pietro Zantonini, 55 anni, morto di freddo durante un turno di vigilanza notturna in un cantiere olimpico a Cortina. Mentre la retorica correva più veloce delle ruspe, lui era chiuso in un gabbiotto grande quanto un bagno chimico, con una stufetta come unica difesa da –15 gradi, costretto a ronde esterne ogni due ore. Lavorava con un contratto a termine, lontano da casa, perché quel salario serviva a tenere in piedi una famiglia. Questo è il punto di partenza. Tutto il resto è contorno.
Si dirà che le cause vanno accertate, che c’è un’autopsia, che la magistratura farà il suo corso. Vero. Ma intanto un uomo è morto sul lavoro, in condizioni che chiunque definirebbe proibitive. Turni notturni di dodici ore, gelo costante, subappalti, vigilanza esternalizzata, responsabilità che si disperdono lungo la filiera fino a diventare un’ombra. Le Olimpiadi promettono eccellenza, ma si reggono su lavoratori invisibili, compressi tra scadenze e risparmi, dove la sicurezza diventa una voce da minimizzare.
Il fratello lo dice senza retorica: “Era lì per mantenere la famiglia”. È la frase che inchioda tutti. Perché racconta un sistema che normalizza l’eccezione, che trasforma il rischio in routine, che accetta il freddo estremo come dettaglio logistico. E quando arriva il comunicato di cordoglio, puntualissimo, scopri che il cantiere “non è di competenza”. Nessuno è mai competente quando il prezzo è una vita.
Milano-Cortina 2026 dovrebbe essere una vetrina. Oggi è uno specchio. Dentro si vede un Paese che applaude i grandi eventi e chiude gli occhi sulle condizioni di chi li rende possibili. Pietro Zantonini è morto lavorando. Tutto il resto è una giustificazione che non scalda.
Buon lunedì.
Foto WM