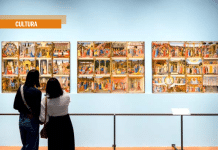Lo scorso anno, ha visto il ricorrere dei dieci anni dal tragico suicidio di David Foster Wallace. Per nessuno più che per l’autore di Infinite Jest è vero quanto Pasolini, nell’articolo I segni viventi e i poeti morti, sosteneva sulla modalità sempre differente, con cui la morte articola – sigillandola- la vita, grazie alla «luce retroattiva che essa rimanda su tale vita».
E Foster Wallace è finito fagocitato, suo malgrado, dalla propria ipertrofica, sovrabbondante, sovreccitata creatività. I tarli implacabili della depressione, delle ossessioni paranoiche, i masochismi sovversivi di cui sono capaci il paradosso e l’ironia – tutti tratti, che letterariamente hanno dato corpo alle pagine spiazzanti e felicemente discontinue dei romanzi, dei racconti e degli scritti giornalistici di questo scrittore già classico tra i contemporanei – ne hanno acceso e, al tempo stesso, corroso impietosamente la vita.
Il Cambridge Companion to David Foster Wallace da poco pubblicato a cura di Ralph Clare per il decennale, elogia – a farlo è Matthew Luter – il primo romanzo dell’autore statunitense La scopa del sistema per la sua originale rilettura di Thomas Pynchon, laddove l’incompiuto Re pallido, uscito postumo, è qualificato da Clare Hayes-Brady come un felice tentativo «di re-iscrizione all’interno delle convenzioni letterarie ottocentesche». Un’oscillazione, dunque, fra le tradizioni del postmoderno e del moderno, al cui centro orbitano numerosi racconti, che pertengono ora all’uno ora all’altro di tali poli e ora a entrambi. Diversissimi tra loro e formalmente disomogenei, i racconti possono essere fulminanti, come le pagine di Incarnazioni di bambini bruciati, asciutte al punto da toglierti il fiato, con la morte di un neonato descritta come «un tanto di vapore lassù in alto, che cade come pioggia e poi risale». Rabdomantica e magmatica è, invece, una storia come Caro vecchio neon, nella quale la solitudine che conduce al suicidio trova nell’impostura – logico-intellettuale, prima ancora che psicologica – la sua più gelida premessa.
Eppure, a restare ancor oggi vivo e memorabile della torrenziale opera dello scrittore americano è proprio Infinite Jest, cioè a dire il Foster Wallace più provocatorio, vorace e antagonistico. Ed è forse per questo motivo che il libro non cessa di essere tradotto, letto, discusso e riproposto in America e fuori. Non era certo sfuggito – quando a metà degli anni Novanta Infinite Jest si impose – che un qualcosa di anomalo avesse preso forma. Ma ciò che allora poteva sembrare un ambizioso, irritante e grottesco pastiche non faceva certo presagire un futuro così brillante. E Infinite Jest adesso sta lì, specola discorsiva sopra un caos epistemologico che in due lustri – non solo in America, ma a livello planetario – si è fatto sempre più acuto.
Il Pasolini de I segni viventi e i poeti morti definiva la vita un «continuum indecifrabile, approssimativo, mitico e violentemente fisico insieme, ambiguo e menzognero». Gli anni Settanta e Ottanta hanno segnato il trionfo delle filosofie del continuum, del molteplice, della differenza. La letteratura postmoderna ha trovato la strada spianata grazie a categorie teoriche quali flusso rizomatico o divenire molecolare. Anche Infinite Jest s’avventura per tali sentieri, ma in maniera schizofrenica, celebrando del flusso l’impasse e dell’impasse la discontinuità. A tutti i livelli: sul piano ideologico, formale, discorsivo.
Alla fine è soprattutto una dinamica a distaccarsi da quanto uscito dalla penna di Wallace: una scrittura che è incessante creare, divagando e lanciando l’arpione dell’entrelacement programmaticamente a vuoto. Ecco, così, sfilare una giostra di andirivieni narrativi destinati a incepparsi, scivolando via in maniera nevrotica, ma decisamente fascinosa. Come Infinite Jest, il misterioso e sfuggente film che del romanzo è il titolo e il centro. Ammesso e non concesso che di centro ve ne sia uno.