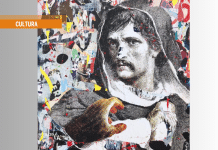Sgomberiamo il campo da ogni visione nostalgica e romantica. Le Olimpiadi di Roma, di 60 anni fa, furono già una grande occasione di business. Cemento a pioggia per realizzare gli impianti, fra cui lo stadio olimpico, gli atleti non propriamente legati allo spirito di De Coubertin, (molti erano professionisti come oggi). Certo le cifre che giravano erano minori e Roma forniva uno scenario perfetto per i Giochi. Lo Stadio era stato realizzato già nel periodo fascista ma durante la guerra venne utilizzato come autoparco, ristrutturato per la XVII edizione delle Olimpiadi, doveva essere e fu il fiore all’occhiello dell’operazione sportiva quanto commerciale. Si era nella Roma del boom economico e della “Dolce vita”, quando le star di Hollywood la visitavano in continuazione senza le limitazioni imposte dal puritanesimo statunitense. E contemporaneamente c’era lo scenario ultramillenario della città eterna, il mito che si riproponeva ammantato di modernità e rivolto al futuro. E i miti, in quei giochi, assumevano forma umana in cui l’impresa atletica proponeva, o lasciava presupporre l’immortalità. La guerra era finita da 15 anni e quale miglior modo per esorcizzarla che trovare figure in grado di incarnare una nuova epoca.
Il primo ad emergere fu un ragazzo americano dal carattere difficile, all’epoca si chiamava Cassius Marcellus Clay, nato a Louisville, nel Kentucky, un fisico agile ma imponente e un nome di battesimo da antico romano, vinse con facilità la medaglia d’oro categoria mediomassimi. Raccontò l’anno dopo di aver gettato la medaglia nel fiume Ohio per protestare contro la segregazione razziale del governo statunitense (secondo altri l’aveva persa in un ristorante) fatto sta che diventato poi pugile professionista – nel 1964 divenne campione del mondo dei pesi massimi – cambiò il proprio nome in Mohammed Alì e nel 1967 venne arrestato perché si rifiutò di andare a combattere in Vietnam.
La seconda fantastica figura dei giochi fu Wilma Rudolph, in Italia immediatamente ribattezzata “La gazzella nera”, con un classico retroterra coloniale. Ventesima di ventidue figli di una famiglia povera del Tennessee, nonostante un principio di poliomelite che la costrinse a crescere con un apparecchio correttivo, si impose alle Olimpiadi romane come vera e propria regina, vincendo 100 mt, 200 mt e staffetta 4X100 femminile. In tutte e tre le gare ottenne anche il record del mondo (quello sui 200 mt non venne omologato per il vento favorevole) ma la sua immagine conquistò la prima pagina non solo dei quotidiani sportivi.
Ma colui che per l’impresa raggiunse l’apogeo fu Abebe Bikila, maratoneta etiope, prima medaglia d’oro di un atleta africano alle olimpiadi. Era nato nel 1932, in un villaggio e visse la crudele occupazione italiana del proprio Paese. Agente di polizia era entrato a far parte della guardia del corpo personale dell’imperatore Hailè Selassiè, il Ras Tafari (Re dei re) che si era reinsediato al trono il 5 maggio del 1941, giorno della liberazione dal dominio italiano. Abebe Bikila corse, per scelta tecnica dell’allenatore scandinavo che conosceva il tracciato, a piedi nudi. Il percorso voleva celebrare, partendo dal Campidoglio, il 10 settembre di un caldo pomeriggio, la grandezza di Roma per terminare all’Arco di Costantino. Fu una incoronazione vera e propria, Bikila non era dato come favorito, il suo record personale era di circa 2 ore e 21 minuti, rispettabile ma non stratosferico. Eppure in quella corsa, che chi c’era racconta ancora come magica, l’atleta sembrava non faticare ma sfiorare i sampietrini. Vinse con il record mondiale, 2 ore e 15 minuti circa, vinse come se fosse stata la cosa più semplice di questo mondo.
Anche il “maratoneta scalzo” purtroppo, contribuì a costruire l’iconografia di un Africa ferma nel tempo, dove “neanche avevano le scarpe”, poco conta che da quel momento in poi il predominio africano sulla media e lunga distanza divenne una costante nello sport mondiale. Sessanta anni dopo fa ancora notizia vedere un’atleta proveniente dal continente europeo, competere con chi si allena negli altipiani dell’Africa Orientale (Eritrea, Etiopia, Somalia) o del Kenia.
Ma c’è un aspetto che la stampa italiana si guardò bene allora di ricordare e per cui ancora prevale disagio. All’epoca era pressoché impossibile parlare pubblicamente dei crimini commessi dal colonialismo italiano in Libia come in Etiopia, prevaleva ancora la narrazione degli “italiani brava gente” che erano andati in quelle terre non per depredarle ma per costruire strade, scuole, ospedali, per portare la “civiltà”. Eppure le sensibilità per decostruire il falso mito, come titola l’ottimo libro pubblicato il mese scorso da Left, poteva già entrare in campo. L’anno prima c’era stato in Italia il secondo congresso degli scrittori africani ed erano presenti le anime più forti della lotta al colonialismo. Nei mesi precedenti in numerosi Paesi, soprattutto di area francofona, si era conquistata l’indipendenza. Non era chiaro quanto ci fosse in questo di formale e quanto di sostanziale (la moneta in circolazione era ed è ancora, forse per poco, il Cfa, il Franco delle Colonie d’Africa) ma un passo avanti sostanziale era stato fatto. E i movimenti di liberazione sorti in molti paesi sembravano poter dare una spallata a domini che duravano da secoli.
Ma nulla di tutto questo fu tema di discussione pubblica a Roma durante le Olimpiadi. Ancora non erano divenuti storia ufficiale i bombardamenti col gas, gli eccidi di civili, proprio contro la resistenza etiope, come quello di Debra Libanos. Solo dal 19 febbraio al 21 maggio del 1937 furono migliaia gli etiopi, magari colpevoli di avere con se un coltello, massacrati dalle milizie fasciste e dagli occupanti. Quando, il 5 maggio del 1941, l’Etiopia venne liberata, per smacco venne impedita qualsiasi rappresaglia nei confronti degli italiani rimasti. Ma all’epoca Abebe Bikila era solo un bambino che mai e poi mai avrebbe potuto pensare, in una perfetta nemesi, di conquistare Roma a piedi nudi e da solo, senza armi né violenza ma fra gli applausi di chi ammirato lo guardava correre.
Nel 1959, un’allora giovane storico aveva pubblicato un libro dal titolo L’Africa aspetta il 1960, nel 1965, lo stesso pubblicò 1935-1941, la Guerra d’Abissinia, scatenando polemiche tremende perché ledeva l’onore dell’esercito italiano. Nel 1976 uscì il primo di quattro volumi su Gli italiani e l’Africa Orientale e a seguire due sull’occupazione in Libia, Tripoli bel suol d’amore. L’autore è oggi uno dei massimi storici italiani, si chiama Angelo Del Boca e continua a rovistare nell’immenso armadio della vergogna rappresentato dal passato coloniale italiano.
Abebe Bikila non c’è più, se ne è andato giovane. Dopo aver rivinto la maratona a Tokio, alle olimpiadi successive, subì un grave incidente stradale che lo costrinse sulla sedia a rotelle. Partecipò alle paraolimpiadi di Heidelberg nel 1972, nel tiro con l’arco. È morto il 25 ottobre 1974, a seguito di una emorragia, aveva 41 anni ma le sue braccia alzate nel tramonto romano, nonostante le patetiche omissioni, sono rimaste nella storia.
Leggilo subito online o con la nostra App
SCARICA LA COPIA DIGITALE