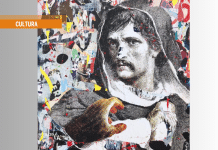La nuova edizione delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone, il festival che da oltre quarant’anni riporta al pubblico contemporaneo la meraviglia del cinema delle origini, è sicuramente tornata ai livelli pre-pandemia, in termini di pubblico internazionale e di possibilità di fruire appieno delle strutture festivaliere, in primis il Teatro Verdi. E anche quest’anno, dal primo all’8 ottobre la programmazione cattura con una ricchezza di titoli inediti e di nuovi filoni di ricerca. Questo cinema ad un occhio superficiale e anestetizzato dall’intrattenimento contemporaneo forse potrà sembrare fuori dal tempo ma a vederlo qui a Pordenone, sul grande schermo, appare in tutta la sua meraviglia e attualità.
Per parlarne abbiamo incontrato Jay Weissberg, direttore del festival ma anche giornalista, critico cinematografico e scrittore.

Nella mia vita professionale ho sempre cercato di conciliare il cinema classico con quello contemporaneo. Gran parte dei miei colleghi ritiene che il cinema in senso moderno abbia inizio con Tarantino, o tutt’al più con Cassavetes. C’è un pregiudizio non solo da parte del pubblico, ma anche all’interno dell’industria cinematografica, nei confronti del cinema delle origini. Per me questo è sempre stato motivo di frustrazione: ai miei occhi non è importante che una cosa sia nuova, ma che sia fatta bene, con creatività. Se diamo un’occhiata alla produzione cinematografica del 1907 ad esempio non possiamo non renderci conto di quanto questi film siano innovativi. Quindi, sì, è bello poter lavorare sia nell’ambito della critica cinematografica che del festival di archivio, ma anche frustrante, perché non posso, come critico dedicare abbastanza tempo e risorse al cinema delle origini.
Quest’anno il PorSilent film festival di Pordenone torna a riscoprire le donne che hanno fatto il cinema muto. In particolare c’è un focus su Norma Talmadge che all’epoca fu una delle attrici più apprezzate dal pubblico e che poi è stata completamente dimenticata.
Insieme a Chaplin, Pickford, Fairbanks è in assoluto una delle interpreti più importanti del cinema muto, figura molto apprezzata dal pubblico, in grado di fare grandi risultati di botteghino. Una artista poliedrica, in grado di passare dalla commedia al dramma e di interpretare caratteri molto diversi in modo sempre molto naturale, priva cioè di una eccessiva teatralità, ma dotata di una grande espressività e mimica. Cominciò con la Vitagraph e fece tantissimi film di successo, soprattutto melodrammi. Dopo l’avvento del cinema sonoro interpretò solo due film, che andarono male, e questo creò il falso mito che non fosse una buona attrice. Fu dipinta con malevolenza sia a livello professionale che personale. Mettiamoci anche che lavorò con tanti grandi registi ma non si legò mai a nessuno, come invece Greta Garbo e Clarence Brown. Tutto ciò la relegò all’oblio più di altri attori dell’epoca del muto. Ma era una attrice raffinata e abbiamo motivo di pensare che avesse anche un significativo ruolo produttivo e capacità imprenditoriale.

Sì, è sempre interessante e disturbante l’idea dello sguardo dell’altro, sull’altro. E trova espressione anche nella rassegna di quest’anno sul cinema coloniale olandese, e nella proiezione di Nanouk Of the North (Nanouk l’Eschimese) di Flaherty: questo film è stato molto criticato perché rappresenterebbe sempre la prospettiva dell’uomo bianco, ma appare comunque un tentativo di rapporto, di superamento di un atteggiamento “orientalista” e stereotipante verso le altre culture, così diffuso in Occidente. Ecco il concetto di Ruritania è intriso di tutto questo.
Ruritania è i nome di un fantomatico, sontuoso e arretrato regno balcanico, teatro di intrighi a corte, scambi di persona, re e usurpatori, fughe e rapimenti, che appare per la prima volta nel celebre romanzo di Anthony Hope Il prigioniero di Zenda e poi in innumerevoli film.
Sì, è un tema di grande rilevanza che non è mai stato trattato in modo approfondito in ambito internazionale. Sull’argomento c’è un po’ di letteratura anglosassone, dobbiamo molto ad esempio al libro Inventing Ruritania di Vesna Goldsworthy, che rappresenta bene come questo colonialismo dell’immaginario, di “orientalizzazione” sia stato applicato ai Balcani, visti in modo paternalistico come società primitive, turbolente, litigiose, contrapposte a un Nord, a un Occidente sviluppato, razionale, superiore. L’argomento è molto attuale, e merita un punto di vista internazionale, se pensiamo che sono stati identificati oltre 250 film muti sul tema, e solo in Italia tra il 1911 al ’25 sono stati girati almeno 65 film ambientati in luoghi come la “Silistria”, versione italiana della Ruritania. Quindi c’è molta ricerca da fare. E poi ci sono i topoi correlati: quello del doppio, sempre presente in questi film, l’attenzione e il fascino esercitato dalle vicende di nobili e regnanti, persone al di sopra della gente comune. La critica ha sempre negato dignità culturale a questa vasta produzione cinematografica, che tratta temi che le elite culturali delle società democratiche contemporanee vorrebbero dire superati, e ma che, l’abbiamo visto con le celebrazioni per la morte della regina Elisabetta, ancora oggi riescono a creare grande partecipazione popolare.
La critica non ha saputo quindi cogliere che attraverso questi film la società cercava di rappresentare se stessa e non a caso sceglieva i Balcani,
diversi sì, ma non così tanto, tutto sommato piuttosto vicini.
Esatto, non si è scelta la Cina, l’Africa, alla fine siamo tutti europei. Loro sono come noi ma non sono noi, e questo è motivo di grande fascinazione. C’è poi una linea sottile tra la realtà e la fiction. Ho voluto programmare anche diversi cinegiornali, per avere un’idea realistica dei Balcani dell’epoca. Ed è interessante indagare quanto la realtà stessa di quei luoghi e di quelle persone si sia lasciata influenzare dall’immagine cinematografica che si aveva di loro in un continuo rimando tra realtà e fiction.