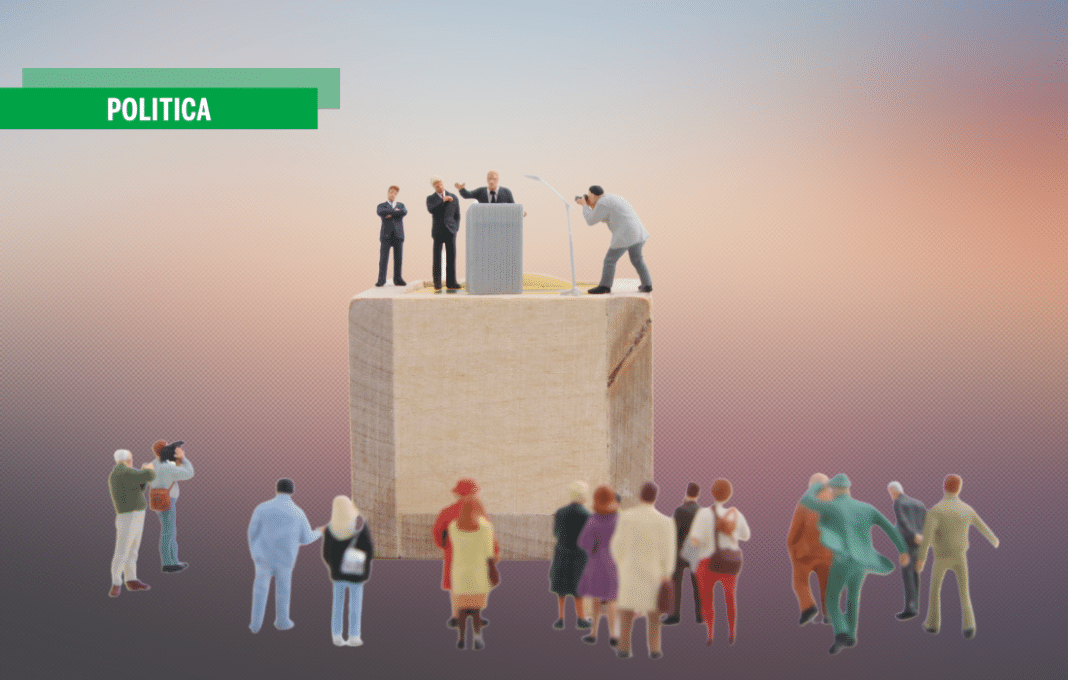La riflessione di Pier Giorgio Ardeni su Left (qui) analizza con sagacia e mestiere i “non detti” dei programmi di candidatura di Bonaccini, Cuperlo e Schlein. L’idea di fondo è che non vi sia differenza sostanziale tra i tre candidati, almeno se messi a confronto con la loro capacità di esprimere una posizione critica al modello dominante. Non tutti saranno d’accordo con questa tesi.
Del resto, le differenze e le somiglianze sono sempre funzione della prospettiva di analisi. Se osserviamo dall’alto due catene montuose molto diverse, per esempio gli Appennini e le Ande, esse ci appariranno simili e per mostrarne le differenze servirà uno sguardo più ravvicinato. Per seguire il ragionamento di Ardeni, quindi, sarà anzitutto necessario chiedersi qual è la “giusta distanza” a cui stabilire il punto di osservazione. Ci si accorgerà, a questo punto, che le due tesi apparentemente contrapposte (i tre candidati sono uguali, i tre candidati sono diversi) sono entrambe plausibili.
A riguardo, propongo una terza prospettiva non tanto costruita sulla maggiore o minore distanza dall’oggetto e, quindi, sulla ricerca della giusta distanza. Piuttosto, difenderò l’idea che – a prescindere dalla loro maggiore o minore differenza – nessuna delle tre candidature affronti il tema che giustamente Ardeni sottolinea nell’incipit del suo pezzo: come colmare il vuoto abissale che ormai separa la politica dai cittadini, che in massa disertano le urne. La crisi del “rapporto di rappresentanza” non trova però spazio in nessuno dei tre candidati. Bonaccini lo affronta con il “metodo Renzi”: decisionismo, velocità, disintermediazione. Una sorta di cura omeopatica, dal momento che questi elementi sono stati l’antitesi della cura per la crisi del rapporto di rappresentanza. Un potere fondato sul carisma personale, la rapidità e il leaderismo. Concentrare più scelte, obiettivi, messaggi, in un lasso di tempo sempre più ristretto. Orientamento al risultato come mantra e “il fare” come metrica. Le parole d’ordine del new public management trasformate in un manifesto politico.
Renzi ha vinto perché ha rinunciato, strategicamente, tanto alla memoria (effettivamente ormai ridotta a un mero orpello liturgico, a un rito senza rituale, dalla classe dirigente del centro-sinistra), quanto alla lentezza necessaria dei processi decisionali intermediati e organizzati. Bonaccini pare volerlo seguire sulla stessa strada, confermando gli elementi alla base della crisi del rapporto di rappresentanza. Il secondo contendente, Gianni Cuperlo, ha costruito la sua proposta sul recupero della memoria, che appare però del tutto liturgica e con qualche vago richiamo alla dottrina (come appunto sottolinea Ardeni). Elly Schlein sembrerebbe, da questo punto di vista, un punto mediano tra i due: con lo sguardo in avanti e rivolto al “futuro”, come Bonaccini, ma più attenta di questo a non apparire come una rottamatrice del passato. Semplicemente, sostiene che la sua età e storia le impedisce di posizionarsi rispetto a “ciò che fummo”, senza appunto rinnegarlo o abbracciarlo in toto. Tre posizioni che, come prima sostenuto, non mettono in piedi nel piatto e non affrontano il problema sollevato da Ardeni: la politica lontana.
Perché nessuna di queste tre posture guardano in faccia il problema alla base della crisi del rapporto di rappresentanza, che ha tre dimensioni principali. La prima è, se vogliamo, semantica e si dipana dall’idea che le diseguaglianze – economiche, sociali e di riconoscimento – siano cresciute in virtù di scelte politiche intenzionali che hanno (ri)disegnato mercati, rapporti di produzione e relazioni di potere tra individui, classi e territori. Non c’è niente di “naturale” o inevitabile in esse. Come sono state create dall’uomo, possono essere combattute in nome dell’uomo.
È, questo, il messaggio del Forum Diseguaglianze e Diversità. Le scelte fatte negli ultimi decenni hanno reso opaca la distinzione tra profitto e rendita, smantellato la protezione pubblica, favorito i profitti delle grandi imprese rispetto alla concorrenza, trasformato il lavoro in un dono, abbinato la povertà alla colpa e relegato la diversità territoriale a un residuo passatista da dimenticare. Per questo bisogna anzitutto ritrovare il senso delle parole: lavoro è diverso da “dono”, il “merito” non si esaurisce nell’impegno individuale, “l’eccellenza” non esiste senza fallimento, l’innovazione non è riservata ai pochi, le diseguaglianze non sono solo o tanto il prezzo del progresso e la tecnologia non offre mai soluzioni “automatiche” alle quali affidarsi a occhi chiusi. A questo scopo, però, non bastano le strategie discorsive, siano esse radicate nella memoria come nel caso di Cuperlo, nell’innovazione “verde” e “civile” come in quello di Schlein o nell’adozione del vocabolario efficientista di Bonaccini.
Appunto, a prescindere dalle differenze non è sufficiente creare “nuovi discorsi pubblici” che magicamente svelino alle persone che sì, finalmente, le catene sono visibili e quindi possono essere spezzate. Creare nuove storie e “narrazioni” è certamente importante, anzi è fondamentale. Ma queste, per essere efficaci, devono radicarsi in spazi esperienziali, nella fisicità di una sfera pubblica aperta alla capacità di futuro, nella formazione di luoghi intermedi per l’elaborazione politica, nel riconoscimento del policentrismo territoriale delle persone-nei-luoghi e delle loro appartenenze al “terrestre”, come ci insegna l’ultimo Bruno Latour. Lo schiavo che passa la sua vita a remare al ritmo della frusta, scrive Terry Eagleton in un vecchio ma ancora importante libro sull’ideologia, non deve attendere la narrazione che gli sveli i suoi interessi oggettivi. Piuttosto, questi si trasformeranno in azione politica quando si daranno le condizioni socio-spaziali per la mobilitazione collettiva, la formazione di un’identità condivisa con gli altri rematori, la messa in comune della condizione individuale dove il bisogno “vicino all’esperienza” (le catene mi tagliano la carne) si connette a una soluzione collettivamente più giusta (nessuno deve vivere in catene). Gli inter-essi, in fin dei conti, inter-sono.
È l’esperienza-in-comune e le storie che da questa nascono a definire i quadri di senso, non la “narrazione” in sé e per sé. Sono gli “assemblaggi” dissonanti negli spazi-in-comune che generano le condizioni materiali e simboliche per gli impegni congiunti orientati a un futuro più giusto. Questa “domanda di futuro” deve però accompagnarsi a una “offerta di futuro”. Perciò è importante che gli “assemblaggi dissonanti” siano produttivi di effetti istituzionali: di ruoli, candidati, politiche pubbliche, progetti che funzionino da attrattori per interessi, saperi e poteri. Ma come farlo? Come passare dal regno del prescrittivo a quello del possibile? Qui il secondo tema non affrontato da nessuno dei tre candidati. A chi stanno parlando? Quali sono i “soggetti sociali” del loro messaggio? Occorre, per rispondere, non cercare il nuovo soggetto collettivo – sia esso il proletariato globale o i “lavoratori della conoscenza” o qualche altro gruppo/classe – in grado di incarnare in modo finalistico la realizzazione del divenire progressivo della Storia. La Storia non ha altra direzione che quella che siamo collettivamente in grado di darle. Per questo, ciò che conta è rimettere al centro i meccanismi di produzione del futuro come fatto politico. Mentre il tempo è una dimensione fisica, il futuro dipende da condizioni e meccanismi socio-culturali.
Mark Fisher – raffinato interprete delle conseguenze culturali del thatcherismo – ha reso celebre l’icastica affermazione per cui è più semplice pensare alla fine del mondo che alla fine del capitalismo. La ratio dell’affermazione va cercata nella capacità del capitalismo di produrre fatti – spesso fatti bruti privi di giustificazione pubblica – racchiusi in un eterno presente. Oggi però, sull’onda della “policrisi” di cui scrivono Adam Tooze ed Edgar Morin, la macchina del futuro si è rimessa in moto. Irruzione della crisi climatica nella vita quotidiana, migrazioni di massa, shock tecnologici, erosione della legittimità delle istituzioni democratiche, pandemie, guerre, lacerazioni dei legami di solidarietà tra classi, territori e generazioni. Il ritorno degli eventi ci dice che la Storia non è finita, come suggerisce Ardeni nel suo ultimo libro sul “ritorno della storia” (2022), senza per questo indicare una direzione specifica. La “policrisi” genera domanda di protezione e controllo, ha spiegato bene Paolo Gerbaudo in “Controllare e proteggere (2022).
Oggi è questa la posta in gioco: il futuro non genera speranza, ma timore. Non si basa su impegni condivisi e capacità comune di aspirare, ma ha lo sguardo rivolto all’indietro verso ciò che si è perduto. Nessuna “narrazione” separata dall’esperienza quotidiana potrà rispondere alla crisi del rapporto di rappresentanza e alle sue cause profonde, da qualunque distanza ci si ponga.