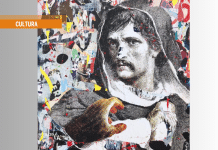Molti stereotipi gravano sull’Africa a cominciare dall’idea che sia un continente immobile, senza storia. Niente di più falso. Come si evince anche leggendo il bel libro di Marco Aime e Andrea de Giorgio Il grande gioco del Sahel (Bollati Boringhieri) che racconta il vivacissimo passato di quella striscia che attraversa 12 Stati – dal Gambia all’Eritrea – e che oggi purtroppo, è diventata una cicatrice sul mondo: zona di tratta di esseri umani, di traffico di cocaina e di incursioni di jihadisti.
Per molti secoli invece il Sahel significava «la fine del viaggio, la fine della sete, il riposo, la sicurezza, la ricchezza, l’altra faccia del deserto», racconta Marco Aime, antropologo culturale dell’Università di Genova, raccontando città dalla storia millenaria come Timbuctù.
Nell’immaginario collettivo l’antica città maliana ha sempre rappresentato un affascinante altrove, ma poco si conosce la sua storia di città di cultura che vantava prestigiose università.
Professor Aime come è avvenuto che il Sahel da oasi di cultura e del traffico dell’oro sia diventato il luogo del traffico di droga e dei nuovi schiavi?
Timbuctù è un nome che è entrato nella fantasia. Molta gente non sa dov’è, ma sa che è lontana. Nel 1300 aveva due università, esattamente quando nella nostra penisola cominciavano le repubbliche più antiche. In quelle università africane insegnavano intellettuali che venivano da tutto quel vasto mondo che andava dall’Andalusia all’India. Avicenna per esempio insegnava lì e vi lasciò trattati di astronomia.
Facciamo un passo indietro per poi arrivare all’oggi. Come era il Sahara nei secoli passati?
Il Sahara non è mai stato troppo deserto, è sempre stato abbastanza trafficato, fin dall’antichità. Spesso si è sentito dire che il deserto avesse isolato l’Africa, ma non è così. Sahel vuol dire sponda. Dal Mali arrivavano grandi quantità di oro. Il mito di Timbuctù entrò nell’immaginario occidentale anche grazie a un geografo catalano che la raccontò come l’Eldorado africano. Intorno all’anno mille era arrivata nel Sahel la scrittura insieme all’Islam. Timbuctù non nacque come villaggio, ma come città, ricca, letterata e colta. Ancora oggi i suoi abitanti sono un po’ come i fiorentini: “meglio di loro non c’è nessuno”, sono un po’ snob, aristocratici, memori dei fasti del passato. Tanto che quando lascia la città dicono che vai in campagna. Oggi la realtà è cambiata ma resta quel pensiero.
L’idea che Africa fosse isolata, dunque, non dice il vero?
L’Africa era perfettamente inserita nel mercato che collegava tutto il Mediterraneo e tutta l’Europa. Non comunicava solo con il Medio Oriente e con l’Asia. Lo scambio riguardava le merci ma anche le culture. Timbuctù è famosa anche per i manoscritti che conserva. Quanti siano nessuno lo sa. Si parla di decine di migliaia. Parliamo di una città letterata in cui si usava la scrittura comunemente e l’arabo come lingua ufficiale. Il commercio transahariano ha una caratteristica: filtra l’inutile. Attraversare il deserto è pericoloso. Ha senso sfidare il rischio solo per trasportare cose di alto valore. Il Sahara nel medioevo era presidiato dai Tuareg che controllavano un territorio. Per ogni tratto dovevi pagare loro un pedaggio. La protezione costava. E siccome la fatica era tanta, viaggiavano solo stoffe pregiate, oro, avorio, schiavi soprattutto. Ma anche rame e sale.
I Tuareg di fatto controllavano il deserto?
Esattamente. Noi li vediamo in modo romantico come gli uomini blu. Nella realtà locale sono percepiti come gente che taglieggiava nello scortare il trasporto delle merci. Il mito dei Tuareg nasce con il mito dell’oro e del sale. In questa area Timbuctù si giova di una posizione speciale. Il fiume nasce a 200 km dall’oceano Atlantico, ma invece di andare a ovest va a est e incontra un altopiano e fa un’ansa per poi scendere. La città sorge nel punto più a nord. È una sorta di hub, di piattaforma intermodale. Divenne uno snodo commerciale. Come tutte le città carovaniere cominciò a decadere nel 1600, quando il cammello perse la battaglia con la caravella, e tutto l’asse si spostò sull’Atlantico.
Oggi i trafficanti di coca, tabacco e nuovi schiavi seguono le mappe medievali?
Il traffico di coca arriva dalla Colombia con gli air cocaine, scaricati nel Sahel. La droga viene poi caricata sui camion. Sono gli stessi che a pagamento ospitano migranti.
Chi controlla questi traffici?
I gruppi jihadisti. Il Sahel sarà il nuovo Afghanistan. Tutti oggi parlano di Sahehilstan. Tutto è iniziato nel 2011 quando Gheddafi fu ucciso dai francesi. Nel sud della Libia c’era la sua guardia speciale di Tuareg, armati dai russi, i quali d’un tratto si trovarono senza avere un referente. Voltarono la testa verso sud e andarono in Mali occupando tre quarti del Paese. Poi arrivarono i francesi, anche perché nel deserto c’è l’uranio. Solo di recente Macron ha lasciato il Paese. «Ci costa troppo», ha detto «e non riusciamo a risolvere niente». Al posto dei francesi sono entrati i russi, i mercenari del gruppo Wagner. Nel Sahel si sono creati gruppi filo jihadisti. Non sono omogenei. Alcuni sono filo Al-Qā’ida, altri filo Isis . Dopo la crisi dello Stato islamico molti di loro si sono spostati nel deserto del Sahara per i traffici della coca. Proprio il traffico di droga in Europa li sta alimentando. Ed è paradossale che i percorsi che fanno oggi la droga e i migranti seguano le stesse tracce percorse nel medioevo.
Il Sahael è diventato anche un grande cimitero a cielo aperto…
Le notizie drammatiche che ci arrivano dal Mediterraneo sono una infima parte di quel che accade. Il Sahara è un vero cimitero e non sapremo mai quanti sono morti di fame e di stenti nel deserto. Non ci sarà mai una anagrafe. Spesso i trafficanti non intercettati da alcuna pattuglia scaricano i migranti nel deserto e scappano, lasciandoli morire. Il grande gioco del Sahel oggi vede al centro i jihadisti. Ma vi hanno messo le mani prima la Francia, e oggi la Russia e la Cina che ha un grosso peso in Africa e ed esercita un controllo sui giacimenti di uranio. Il Sahel è attraversato dal grande fenomeno migratorio che vede persone in arrivo dal Sudan, dall’Etiopia perché quelli sono i corridoi. Le tracce di un tempo oggi sono peggiori di allora, più crudeli.
Dal Mali e da altre zone arrivano notizie di una pervasiva penetrazione dei contractor della Wagner. Tanto che si diffondono magliette con la scritta “Je suis Wagner”. Cosa sta succedendo?
Da un certo punto di vista sono stati molto abili. Ma non dimentichiamo il crescente sentimento anti francese seguito all’uccisione di Gheddafi. Va anche ricordato che 14 Paesi, ex colonie africane, sono legati dalla moneta unica, il franco francese, il cui valore viene determinato da Parigi. È colonialismo economico. Nel febbraio 1992 ero in Benin e d’un tratto fu comunicato che il franco veniva dimezzato di valore. Immaginate milioni di famiglie che si sono trovate così metà dei soldi, perché Parigi ha deciso così. Gheddafi stava proponendo un nuovo modello di moneta panafricana. Non a caso i francesi attaccarono la Libia in quel momento. L’odio verso i francesi è alimentato da due parti in Mali: dai religiosi islamici e dai militari. Per cui il paradosso è che i russi appaiono come il nuovo, pur di non essere francesi…
Così si spiega perché tanti Paesi africani si sono espressi in sede Onu e altrove contro le sanzioni alla Russia che ha invaso l’Ucraina?
Esattamente. La Cina da molti anni ha una massiccia presenza in Africa. Da un po’ c’è anche la Russia
E anche la Turchia?
Evidentemente. Il gioco è complesso.
L’Africa fa gola a molti?
Ha molte risorse e il Pil è in crescita. Il vero problema dell’Africa non è la ricchezza ma la distribuzione. Ci sono tante persone povere in Paesi ricchissimi. Il problema sono le grosse disuguaglianze legate a una scarsa rappresentatività sociale e alla scarsa alfabetizzazione. Anche se tutto sta migliorando. Sottolineo però che noi stiamo chiedendo all’Africa di fare quel passaggio che noi abbiamo fatto in secoli.
La scarsa rappresentatività sociale che favorisce le dittature cambierà con la crescita delle nuove generazioni?
È in atto un grande processo di cambiamento. Ora ci sono molte “democrature” o, per dirla con il premio Nobel nigeriano Soynka, ci sono tante «democrazie voodoo», ovvero finte democrazie in cui il leader coopta quattro cugini e si arrocca al potere. Questo è il limite. Ma non dimentichiamo che sono solo 60 anni che l’Africa è indipendente. Ormai il boom urbano è un fatto assodato. Sono sempre di più gli africani che vivono in città e sono soprattutto giovani. Hanno una visone diversa. Sono perfettamente globalizzati come i nostri giovani. Tutto ciò porterà a un cambiamento politico-economico dell’Africa. Però dobbiamo dare loro tempo. Non possiamo pensare che accada in pochi decenni. Dobbiamo tener presente anche che spesso gli Stati africani sono nati in maniera artificiale, non per un processo endogeno, ma per i comodi dei colonialisti.
Troppo spesso la cooperazione internazionale ha avuto un ruolo fallimentare? Basterebbe aiutare l’istruzione?
Secondo me basterebbe non sfruttarli. Teniamo conto che oggi nel nord del Congo ci sono i più grandi giacimenti di cobalto e servono per le batterie. L’ottanta per cento di quel cobalto è in mano ai cinesi. Alle multinazionali conviene un dittatore. Ripeto, smettere di sfruttarli farebbe molto di più delle finte cooperazioni.
Tra i settori in crescita c’è anche quello della moda?
Sicuramente c’è molta attenzione per l’abbigliamento, per lo stile. C’era nella tradizione e c’è nella vita urbana. Il settore della moda sta crescendo. L’Europa pare cominci a guardare agli stilisti africani e a importare qualche idea.
La moda si intreccia con la musica nel movimento della Sape di cui Papa Wemba è stato un grande interprete. Può dirci di più di questo fenomeno di cui parla African power dressing, (Genova University press), il libro di Giovanna Parodi da Passano che lei ha presentato?
La Sape è la moda dei giovani di Brazzaville che si vestono in modo elegante e vengono chiamati a matrimoni e feste per le loro scarpe lucidissime. Indossano giacche di colori sgargianti che su di noi farebbero effetto pagliaccio, ma sulla pelle scura risultano ben altrimenti. Hanno il culto della eleganza sfrenata, sono un po’ una élite.
Coltivano un’idea di eleganza che si lega a una visione pacifista?
Sì, c’è un gusto della bellezza molto dandy a Kinshasa e in altre città. Fonde stile occidentale ed elementi locali. Ma c’è anche un grande movimento di stilisti africani che propongono innovazioni molto interessanti.
La globalizzazione in questo caso non annulla le differenze. Rileggono la moda francese facendola propria, risemantizzandola. Che gioco c’è fra locale e globale?
La musica tradizionale africana è partita con gli schiavi. È passata attraverso i Caraibi, il Brasile le Americhe, ed è tornata da là. È stata rielaborata quando sono arrivati gli strumenti come la chitarra elettrica. Un amico congolese mi raccontava che negli anni Sessanta mentre in Italia ci si divideva tra fan dei Beatles e dei Rolling Stones, loro si dividevano tra fan di James Brown e Otis Redding, i due maghi del soul. La musica africana oggi è già passata attraverso tutte queste esperienze. La musica è una bella metafora della cultura africana, continuamente dà vita a generi diversi. C’è sempre stato questo rimescolamento, questa metabolizzazione da cui nasce sempre qualcosa di nuovo. A questo proposito consiglio di leggere il bel libro di Steven Feld Jazz cosmopolita ad Accra (Il Saggiatore) che racconta questo movimento eccezionale di reinvenzione del jazz nella metropoli. Non c’è frontiera che tenga. La nostra musica – dal blues all’hip hop – arriva tutta da lì.
Fin dal Cinquecento quando arrivarono nelle corti musicisti neri e cambiarono la storia della musica…
La scala pentatonica nacque nell’ansa del Niger. E poi con gli schiavi africani arrivò Oltreoceano diventando blues, bossanova e tutti gli altri ritmi caraibici. Tutto si è basato su quella scala.
Questa intervista è stata pubblicata su Left, novembre 2022