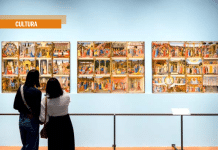A trenta anni dalla prima traduzione italiana dell’antico poema mesopotamico, un reading musicale al Teatro Basilica di Roma propone una lettura dell’epopea del re di Uruk e del suo amico Enkidu che illumina una visione della realtà umana ben diversa da quella della tradizione giudaico-cristiana e dal logos greco
Dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, quando le prime notizie sull’epopea di Gilgameš uscirono in Italia dalla cerchia degli specialisti, anche il grande pubblico iniziò a scoprire che l’Iliade e l’Odissea, i poemi che tutti conoscevamo, scritti nell’VIII secolo a. C. da un cantore dell’Asia Minore detto Omero, avevano nella letteratura sumerico-accadica un antecedente di 1500 anni. Eppure già da un secolo tavolette di argilla incise in caratteri cuneiformi, emerse dagli scavi archeologici, tra mito e storia testimoniavano agli studiosi europei le gesta del re di Uruk, fondatore della città sull’Eufrate: Gilgameš, l’eroe sumerico che molto prima della Bibbia aveva raccontato la storia del cosiddetto Diluvio universale. Ma le ragioni di un tale ritardo nella divulgazione delle scoperte tardarono a lungo ad emergere. Nel 1993 La saga di Gilgamesh fu finalmente pubblicata nella bella traduzione italiana del famoso assirologo Giovanni Pettinato, già traduttore del ricchissimo archivio di Ebla, emerso dagli scavi di Paolo Matthiae nella città siriana fiorita tra il 2500 e il 1600 a.C.
Questo articolo è riservato agli abbonati
Per continuare la lettura dell'articolo abbonati alla rivista
Se sei già abbonato effettua il login