In tempi di Mafia Capitale è lecito giocare con le tristi vicende del crimine e usarle per fare dell’intrattenimento noir? Forse sì, a patto di infilare nell’intrattenimento un potente effetto di realtà e alcune considerazioni antropologiche non del tutto ovvie.
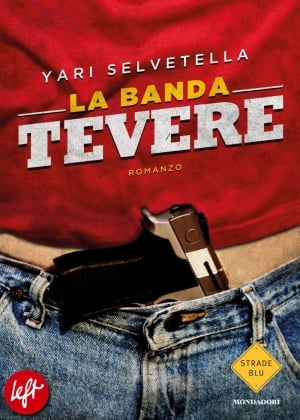
Il cinquantenne Tevere, così soprannominato per un tuffo spettacolare da Ponte Sant’Angelo, esce dal carcere di Rebibbia per iniziare una vita onesta, lavorando in una cooperativa di spazzini. Ma la figlia è incinta e senza soldi. Allora ricostituisce la vecchia banda per un colpo risolutivo, tra soci assai pittoreschi, vecchi amici-nemici e poliziotti corrotti. La trama ha un puntuale contrappunto nelle riflessioni sul genius loci della città. Poiché Tevere è anche un gran cuoco apprendiamo che «le ricette romane sono volubili come il popolo cui appartengono» dato che ognuno è convinto di sapere lui la vera ricetta: «pancetta no, pecorino certo parmigiano mah».
C’è poi l’inizio di un capitolo che è una criptocitazione dall’ incipit dell’Orologio di Carlo Levi: «A ridosso dell’alba, a Roma, non ruggiscono più i leoni; è il momento di ratti e scarafaggi. Persino gli sbadigli fanno rumore». Selvetella non si crede Gadda, non ha pretese letterarie e sembra confrontarsi soprattutto con ritmi e stilemi della fiction tv. Però ha creato almeno un personaggio memorabile, Tevere – spavaldo e fragile, coriaceo e sentimentale – destinato a restare per un po’ nell’immaginario. Mi chiedo solo se ne esistono ancora in giro.




