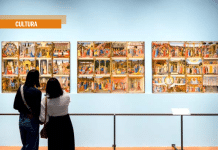Si può rappresentare l’orrore al cinema? Il regista ungherese László Nemes con il film Saul fia (Il figlio di Saul) ci è riuscito. L’orrore è la perdita dell’umanità, che muta gli uomini in “macchine”, costretti per giorni e giorni a sollevare cadaveri, ormai diventati “pezzi”, e a farli ingoiare dai forni crematori per poi disperderne le ceneri nell’acqua, affinché non rimanga più una traccia. La cinepresa, fissa sugli occhi vitrei e sul volto immobile di Saul Ausländer che si muove in spazi claustrofobici tra le voci di tante lingue europee, non dà tregua. Saul (Géza Röhrig) fa parte del Sonderkommando, l’unità speciale di ebrei obbligati dai nazisti a compiere lo sterminio di altri ebrei. «Che sensazioni si provano a stare così? Un uomo non può rimanere umano dopo aver cremato centinaia e migliaia di cadaveri in solo poche settimane», si chiedeva ad aprile scorso su Cinematrix László Nemes. Il suo film, nelle sale italiane dal 21 gennaio, già vincitore del gran premio della Giuria a Cannes, il 10 gennaio si è aggiudicato il Golden Globe come miglior film straniero e adesso corre per l’Oscar. Riconoscimenti meritati perché l’opera prima del 38enne regista ungherese irrompe con forza e originalità nella riflessione sull’Olocausto. Non con il distacco asettico della Storia o del documentario fotografico, e nemmeno con «l’impatto sentimentale» come ha ripetuto lo stesso regista dopo aver vinto il Golden Globe. No, dice Nemes, quello del film è «un approccio intellettuale di ricerca». Non un’operazione astratta ma compiuta «a un livello umano», per capire come mai «a un uomo viene tolta l’umanità». Se non si capisce questo, aveva precisato su Cinematrix, «ricadremo sempre nella distruzione e nella guerra». Nemes racconta una manciata di ore vissute come in trance da Saul che tenta di dare sepoltura al corpo di un adolescente che “crede” essere suo figlio, mentre intorno i suoi compagni si affannano in un coraggioso e vano gesto di ribellione. Saul vive in un mondo suo, non riconosce nemmeno la moglie, che lavora nel reparto degli oggetti e dei vestiti dei deportati.
Il figlio di Saul ha scatenato un dibattito vivace: il filosofo francese Didi-Huberman l’ha definito «Un mostro. Un necessario, coerente, benefico e innocente mostro» ed è stato accolto benissimo dal novantenne Claude Lanzmann – autore del documentario Shoah nel 1985 – il quale, aveva dichiarato a proposito del celebre Schindler’s list, che l’Olocausto era irrappresentabile al cinema. Venduto in 60 Paesi, il film in Ungheria ha ottenuto un successo inimmaginabile. «La reazione delle persone è stata straordinaria. Per essere un film d’arte sta raggiungendo i 100mila spettatori, là dove i film di cassetta arrivano a 150-200mila biglietti. Tutti i giornali, di destra e di sinistra, ne hanno parlato bene», racconta al telefono da Budapest Gabor Sipos, uno dei due soci di Laokoon filmgroup che l’ha prodotto. Alla prima a Budapest era presente anche il premio Nobel Imre Kertész, ex deportato ad Auschwitz, «che si è stupito molto», continua Gabor.
Lui, il suo socio Gabor Rajna, ma anche Nemes e il protagonista, il poeta Géza Röhrig, sono tutti quarantenni che vivono in Ungheria o che comunque vi sono nati ed è come se si fossero incontrati su un interesse comune profondo. «Non c’è niente di personale, è una cosa obiettiva. Dell’Olocausto ne abbiamo sentito parlare sempre, i nonni lo hanno raccontato ai figli, i figli ai nipoti. Noi ormai siamo la terza generazione. Abbiamo visto tutti i film sull’argomento. E tutti parlano di eroi sopravvissuti, di amori spezzati dalla guerra, del pianista super famoso, della bambina, della moglie ecc.». Quando László Nemes, al suo primo lungometraggio, si è presentato a Budapest con la sceneggiatura del film scritta insieme alla scrittrice Clara Royer, dopo aver trovato molte porte chiuse in Francia – dove si era trasferito all’età di 12 anni – la reazione è stata immediata. «Quando ho letto la sceneggiatura, mi sono chiesto: ma è un sogno? Io il film lo vedevo, lo capivo. Funzionava già dal primo momento, non so come. Per la drammaturgia, per il pensiero che c’era dietro», dice Sipos ricordando quel primo incontro nel 2012. Due anni per arrivare alle riprese, nel 2014, dopo aver superato «con una bella magia», le difficoltà sui finanziamenti, ottenuti grazie ad un fondo ungherese per il cinema oltre al contributo dell’associazione americana Claims Conference. Ma l’intuizione era giusta. «Finalmente, mi sono detto. Finalmente si parla di quelli che non sono sopravvissuti, di che cosa hanno fatto per trovare il modo di scappare anche se fisicamente non potevano farlo». L’Ungheria deve fare i conti con un passato pesante: 800mila ebrei, di cui 100mila bambini, deportati dai fascisti ungheresi nei campi di concentramento e mai tornati. «Il braccio destro di Mengele era un medico ungherese (Miklòs Nyszli, ndr). Dopo la guerra scrisse un suo diario che è conosciuto nel mondo intellettuale. Ma del Sonderkommando non si sapeva nulla e in Ungheria è come un tabù», continua il produttore che sottolinea come il film, da Budapest a Tokio, colpisca profondamente gli spettatori. «“Era proprio così”, ci hanno detto dei sopravvissuti di Toronto». Gabor Sipos usa la parola “vertigo” per esprimere la sensazione che provoca la visione del film. Ma quelle “macchine” che si muovono per cancellare persone e corpi, pongono domande, come si chiedeva Nemes. Forse, chissà, potrebbero scaturire nuove riflessioni sulle origini del nazismo. Intanto, un’importante traccia, a livello culturale, la troviamo nella ricerca recente che pone alla base del nazismo il pensiero razzista e antisemita di Heidegger come ha evidenziato in un suo saggio Emmanuel Faye (L’introduzione del nazismo nella filosofia, L’asino d’oro).
Nel campo di concentramento, inoltre, colpisce la determinazione di Saul che, pur oppresso dalla disumanità che lo circonda, cerca di dare sepoltura all’adolescente: quasi un estremo tentativo di salvare la dignità umana dall’annullamento totale. E anche qui riecheggia la ricerca sul pensiero che sta a monte del nazismo. Su Left di un anno fa (n. 2 del 2015), ricordiamo, Gianfranco De Simone aveva scritto, a proposito del concetto heideggeriano di essere: «C’erano uomini, gli ebrei, senza mondo, come le pietre, enti materiali». E quindi tali da essere resi inesistenti come denuncia magistralmente il film Il figlio di Saul.
(ha collaborato Francesca Zappacosta)