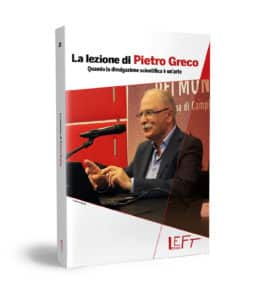È stato un terremoto vero quello di ieri, non una delle solite scosse a cui l’area flegrea è “abituata”. L’istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia ha registrato una magnitudo di 4,4, la più alta negli ultimi 40 anni. La popolazione ieri si è riversata in strada e chiede più informazione e più sicurezza. Una questione annosa denunciata anni fa su Left dal grande divulgatore scientifico Pietro Greco e in parte ancora irrisolta. Nell’ottobre 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Campi Flegrei che prevede per la prima volta anche un piano di protezione civile, ma ancora non basta. I piani di evacuazione sono poco provati, poche le esercitazioni fatte e in situazioni di panico non bastano. Intanto i cittadini denunciano che verifiche delle strutture iniziate nei mesi scorsi dopo lo sciame di ottobre sono state poche. Ecco cosa sono i campi Flegrei e come funzionano questi super vulcani spiegato da Pietro Greco:
Il 28 settembre 2017, nel giro di mezz’ora, tra le 15:28 e le 15:54, gli strumenti dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato nei Campi Flegrei, tra Pozzuoli e Bagnoli, a nord-ovest della città di Napoli, sei piccole scosse sismiche, di magnitudo Richter compresa tra 0,2 e 0,9, con un ipocentro molto superficiale, localizzato tra 800e 1.800 metri di profondità. Si tratta di piccole scosse, neppure avvertibili dalla popolazione.
Non è che sia tutti i giorni così. Ma è dal 2012 che nei Campi Flegrei si registrano tutta una serie di fenomeni – non solo scosse sismiche, ma anche deformazione del suolo e maggiore emissione di gas e attività delle fumarole – che hanno consigliato gli scienziati dell’Osservatorio Vesuviano di aumentare il “livello di attenzione”. Anche in senso tecnico.
Già, perché i Campi Flegrei sono un vulcano attivo – anche se magari meno appariscente del Vesuvio, con crateri quasi piatti, mentre quello vesuviano si eleva per 1300 disegnando la silhouette di Napoli – localizzato in un’area densamente popolata.
Prima del 2012 il livello di rischio di questo vulcano era classificato con il colore verde: “attività normale”. Negli ultimi cinque anni i fenomeni si sono intensificati e il livello di rischio è stato portato al gradino superiore, il colore giallo: il “livello di attenzione”, appunto. Niente di allarmante. Non ci sono indizi che il livello di rischio possa aumentare ancora, passando al colore arancio, “pericolo, anche se molto localizzato” o addirittura al colore rosso, “pericolo di eventi estremi”, ovvero di un’eruzione.
A crearlo, un po’ più di allarme, c’è stato un articolo, Progressive approach to eruption at Campi Flegrei caldera in southern Italy, pubblicato nel maggio 2017 sulla rivista Nature Communication, da un geofisico inglese, Christopher Kilburn, e da due geofisici napoletani, in forze all’Osservatorio Vesuviano, Giuseppe Di Natale e Stefano Carlino.
La tesi dei tre studiosi è che un’eruzione del vulcano dei Campi Flegrei è in tempi più o meno rapidi forse più probabile di quanto finora si è pensato. In realtà si tratta di una tesi controversa, non sposata affatto dai loro colleghi.
L’ultima eruzione del vulcano risale a mezzo millennio fa, al 1538. In tutto questo tempo non è che il vulcano dei Campi Flegrei se n’è sia stato tranquillissimo. Spesso ha generato fenomeni piuttosto localizzati, ma niente affatto banali: scosse sismiche, ma anche eventi di bradisismo, con salita e discesa del terreno piuttosto marcate. Negli ultimi 67 anni i fenomeni di accentuato bradisismo sono stati tre: tra l’aprile 1950 e il maggio 1952; tra il mese di luglio 1969 e quello del 1972; e ancora tra il giugno 1982 e il dicembre 1984. Risultato: dagli anni Settanta a oggi il suolo al porto di Pozzuoli si è sollevato di ben 4 metri. Queste attività non preludono necessariamente a un’eruzione. E, infatti, da mezzo millennio eruzione non ce ne sono state. E tuttavia, sostengono Kilburn, Di Natale e Carlino: utilizzando un nuovo modello di analisi, i fenomeni recenti risultano molto simili a quelli che hanno preceduto l’eruzione del 1538. Dunque, stiamo attenti.
Certo, sostengono i critici dei tre studiosi, altri modelli escludono che siamo ai preludi di un’eruzione imminente. Dunque nessun particolare allarme. Ma, appunto, massima attenzione.
Anche perché la storia non è del tutto rassicurante. I Campi Flegrei, infatti, sono tra i 10 o 12 “supervulcani” ancora attivi al mondo. Un altro famoso è Yellowstone, negli Stati Uniti. Si tratta di caldere, come le chiamano i geofisici, che si estendono per chilometri (10 per 15 chilometri, la caldera dei Campi Flegrei) e capaci, di tanto in tanto, di eruzioni catastrofiche. I Campi Flegrei ne hanno conosciute almeno due in passato di queste immani eruzione: quella dell’Ignimbrite Campana, di 39mila anni fa, quando il vulcano ha eruttato qualcosa come 300 km3 di magma e generato colonne incandescenti alte 40 chilometri, capaci di devastare un’area di 1.000 km2 e da far sentire i suoi effetti in tutta Europa. L’eruzione è stata così potente e gli effetti così estesi che alcuni studiosi l’hanno messa in relazione con l’estinzione dei Neanderthal, avvenuta proprio in quel periodo.
Molto dopo, 15mila anni fa, in un nuovo evento, noto come quello del Tufo Giallo Napoletano, i Campi Flegrei si sono ripetuti e hanno eruttato 50 km3 di magma.
Ma non spaventiamoci per questo. Non è di catastrofi simili che stiamo parlando ora.
Già, perché da 15 millenni il “supervulcano” dei Campi Flegrei è sostanzialmente tranquillo. L’ultima eruzione, quella già ricordata del 1538, è stata molto contenuta, anche se ha generato una collina: nota come Monte Nuovo. Nei 3mila anni precedenti i Campi Flegrei sono stati in sostanziale quiescenza. E così negli ultimi 500 anni, dopo il 1538.
Ecco, il pericolo massimo atteso è che in una caldera che, a differenza del Vesuvio, non ha un apparato centrale e si estende per decine di chilometri quadrati, si apra una bocca eruttiva in un luogo non prevedibile con sicurezza che produca fenomeni come quelli del 1538. Con – dicono gli esperti- lancio di bombe e blocchi di grosse dimensioni nell’immediato intorno della bocca; con flussi piroclastici (polveri e gas) pericolosi nel raggio di alcuni chilometri; con ricaduta di ceneri e lapilli a distanza anche di molti chilometri.
Ecco ciò che distingue lo Yellowstone dai Campi Flegrei. la posizione esposta nel caso americano è piccola, nei Campi Flegrei enorme. I fenomeni vulcanici in area napoletana avvengono in un’area molto densamente abitata: le persone esposte al rischio Campi Flegrei sono tra 500mila e un milione di persone. Il che lo rende uno dei vulcani più pericolosi al mondo, anche con eruzioni tipo 1538. Si aggiunga a questo che, a differenza del Vesuvio, la città di Napoli si trova sottovento rispetto alla direzione dei venti dominanti e, quindi, anche lei potrebbe essere coinvolta.
Ma quel è il problema specifico dei Campi Flegrei? Be’, è semplice. Lo indichiamo ora, a bocce (quasi) ferme. Non in condizioni critiche. Il problema è che non c’è un “piano di emergenza”. Un piano che, nel caso il livello di rischio aumenti preveda che deve evacuare, in che modo e dove deve andare. Questo piano, ancorché imperfetto, esiste per il Vesuvio. Occorre che ne sia elaborato uno anche per i Campi Flegrei e, magari, per il terzo dei vulcani attivi nell’area napoletana, il vulcano Ischia.
Questo è il momento di tradurre, senza allarmismi, le conoscenze scientifiche in concreti progetti di prevenzione. Se non ora, quando?
Articolo pubblicato su Left nell’ottobre 2017
Il convegno in onore di Pietro Greco
Torna per il quarto anno consecutivo l’appuntamento dedicato al giornalista, faro della divulgazione scientifica e collaboratore di Left, Pietro Greco. Dopo Luce, Tempo e Spazio, il 24 maggio alle 17 si tiene il convegno presso l’università Roma Tre, dal titolo Sull’acqua, scienza e bellezza. L’incontro, moderato da Marco Motta, giornalista e conduttore di Radio Tre Scienza, prevede interventi di Elena Pettinelli, Fisica presso l’Università Roma Tre, Franco d’Agostino, Assirologo ,direttore del dipartimento degli Studi Orientali della Sapienza, Annelore Homberg, Psichiatra e psicoterapeuta, presidente Netforpp Europa, Marcello Petitta, Climatologo dell’Università Roma Tre, Alessandro Chiarucci, botanico ed ecologo dell’Università di Bologna e presidente della Società italiana di botanica e Massimo D’Orzi, scrittore e regista. In collaborazione con le associazioni La scuola che verrà e Amore e psiche
Qui il libro di Pietro Greco edito da Left, presentato da Rossella Panarese, ideatrice e per anni conduttrice di Radio3 scienza
Foto in apertura Solfatara di Pozzuoli Di User:Kleuske – Opera propria, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=342298