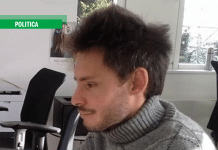Dovremo scrivere una storia del cinema attraverso le ribellioni delle donne. Non ne troveremmo molte. Dovremmo guardare nei film di Dreyer (vale la pena riascoltare le parole di Gertrud «ho molto sofferto, ma ho amato») o piangere nel finale de La notte di Antonioni insieme alla protagonista che legge una lettera d’amore a un uomo fatuo. Rivedere Bergman, forse Mizoguchi, o qualche raro film come Ipazia o Diavolo in corpo. Ormai è chiaro a tutti: nel rapporto fra un uomo e una donna c’è un convitato di pietra. Talvolta manifesto, altre volte meno visibile.

Viviane è maledettamente decisa a non voler più sottostare a quell’inferno matrimoniale. Sente l’odio sulla sua pelle e qualcosa che va oltre l’odio. Lo dice: «Tu vuoi il mio annientamento». Vallo a spiegare alla corte rabbinica. La stessa che siede lì marmorea da secoli nella assoluta convinzione che la donna è il male e che il suo ventre è destinato solo per la procreazione e la cura dei figli di Israele. Che cos’è rivoluzionario? Una donna che smette di credere che il talamo nuziale sia un altare inviolabile e il proprio uomo emanazione di Dio. Una donna che guarda nella direzione opposta. Come Viviane.
I registi tengono la macchina da presa all’altezza dello sguardo dei protagonisti facendo muovere le teste come se assistessero a una partita di tennis. Senza pallina. Come nel finale di Blow up. In questa vicenda paradossale e kafkiana (vengono in mente i tribunali dell’Inquisizione nell’atto di accanirsi contro le streghe prima di mandarle al rogo), scopriamo l’assassino ma fortunatamente il “cadavere” è fuggito con piedi e caviglie gonfie fuori dal labirinto della Legge. Il cinema si riscatta con questo film perché fa emergere l’immagine di una donna che si ribella, profanando quell’istituzione con il tocco femminile di una maglietta rossa e il gesto irreversibile di sciogliersi i bellissimi capelli neri.
La regia disegna con maestria la forma del film. L’ambiente angusto di un’aula di giustizia da cui il mondo sembra escluso è inquadrato con la fissità ieratica delle icone bizantine. Le movenze della protagonista esplorano un ampio recitativo che va da un casto naturalismo a pose che rimandano al cinema muto. Il tempo inesorabile e inviolabile delle istituzioni religiose è reso con l’insistenza delle scene, che si ripetono sempre uguali al fine di sfiancare ogni forma di rivolta. E lo spettatore vi è trascinato dentro. Viviane accompagnata solo dal suo onesto e vigoroso avvocato, compie una lotta senza pari contro una corte ottusa perché non umana, emanazione di una legge che è volontà di un Dio unico e assoluto, che ha eletto e circoscritto il suo popolo in uno spazio sacro in cui la donna rappresenta la vera minaccia.