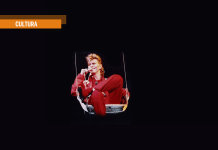Pang: “Turandot non esiste!”
Ping: “Non esiste che in Niente nel quale ti annulli!”
Pong, Pang: “Turandot non esiste!”
Tutto finisce con la morte di Liù nella Turandot in scena quest’estate a Caracalla. Non viene eseguito nessun finale, né quello di Alfano né quello di Berio. Niente duetto d’amore dunque, e nessuna soluzione drammaturgica: le luci si spengono sulle ultime note scritte da Puccini, che al sacrificio di Liù interruppe la composizione e morì, un anno e mezzo dopo, lasciando incompiuta la sua ultima opera.
Al regista Denis Krief, alla sua sesta Turandot, le idee non mancano, e se i movimenti scenici non sono interessanti, le scenografie contengono riferimenti di ogni tipo, dalla Cina degli anni 80 alle avanguardie coeve di Puccini, alla commedia dell’arte e altro ancora. Tanto per cominciare, il Mandarino-clown dell’annuncio iniziale intrattiene con un palloncino bianco (simboleggiante la luna) una danza giocosa che ricorda il Grande dittatore di Chaplin e il suo mappamondo, con lo stesso simbolico scoppio finale.
Krief impiega poche strutture dalle linee essenziali, portate a mano a scena aperta, tranne la lunga muraglia in legno e bambù di ispirazione costruttivista, che con i suoi moduli fissi e mobili fa da cornice, e insieme da barriera, al coro schierato in alto.
L’effetto è bello, ma in questo modo il popolo di Pechino non partecipa, si limita ad assistere e a commentare l’azione – come il coro della tragedia greca – e l’impiego di questa soluzione in tutti e tre gli atti finisce col renderla un po’ monotona. È straniante l’effetto per cui il coro si affaccia sempre ai moduli più alti, mentre Turandot viene portata in scena, all’interno di un cilindro aperto di plastica, allo stesso livello degli altri personaggi. Sovvertendo l’ordine cui siamo abituati, Krief porta a terra la principessa Turandot, divina apparizione invocata per un intero atto – addirittura la fa accovacciare accanto a Liù, durante l’aria di questa – mentre il popolo domina dall’alto.
Più che mitica e fiabesca, questa Turandot appare inconsistente, e se esiste, è solo in virtù di una proiezione, di un sogno, o di un incubo, di Calaf. È lui, per Krief, l’artefice di tutto e il secondo atto non è che la rappresentazione del suo sdoppiamento tra sogno e realtà: i giochi dei ministri Ping Pong e Pang, travestiti ora da maschere della commedia dell’arte ora da gangster, le giovani donne che si muovono in un’atmosfera da “In the mood for love”, i manichini metafisici di De Chirico e Carrà, e Turandot stessa, nel suo guscio rosso rotante. Iréne Theorin (Turandot) ha la potenza del soprano wagneriano ma il fraseggio e l’interpretazione lasciano a desiderare. Problemi di fraseggio anche per Jorge de Leòn, che risulta però abbastanza convincente nei panni di uno stralunato Calaf, mentre Maria Katzarava è una Liù un po’ troppo energica. L’orchestra è guidata con precisione ed efficacia da Juraj Valčuha, direttore dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai dal 2009.