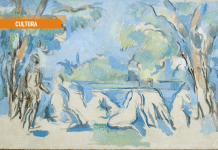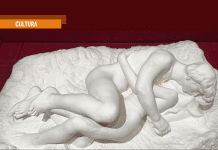Il Guggenheim di New York dedica una grande retrospettiva ad Alberto Burri dal 9 ottobre al 6 gennaio 2016. Per celebrare il centenario della nascita dell’artista umbro il museo nel cuore di Manhattan ne ripercorre tutta l’opera con la mostra The Trauma of Painting, organizzata da Emily Braun e realizzata con la collaborazione della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri che per questa occasione pubblica il catalogo completo delle opere di Burri in edizione bilingue.
L’intento, raccontano i curatori, è “esplorare la bellezza e la complessità del processo creativo che sta alla base delle opere di Burri”, tornando – a 35 anni di distanza dall’ultima mostra newyorkese dedicata all’artista – ad approfondire la figura di questo protagonista della scena artistica del secondo dopoguerra, nel quadro dei rapporti tra Stati Uniti e Europa negli anni Cinquanta e Sessanta.
E prima ancora, a partire dalla dolorosa esperienza che Burri fece proprio negli Usa, quando l’artista, che era medico caporale, fu fatto prigioniero nel 1943 e venne portato dagli americani in un campo di concentramento a Hereford, in Texas. In questo luogo di detenzione Burri, cercando di resistere in quella drammatica condizione, prese a disegnare e a creare utilizzando il carbone, lacerti di juta e altri materiali poverissimi.
La mostra al Guggenheim approfondisce poi la svolta che prese la ricerca di Burri al suo ritorno in Italia nel 1946 quando cominciò a creare quadri astratti caratterizzati da un sottile grafismo. Dal 1949, poi, ecco i Catrami, opere monocrome in cui” il colore viene ridotto alla sua funzione più semplice e perentoria e incisiva”, per dirla con le parole dello stesso Burri. Era il primo passo verso un’attenzione alla materia che si sarebbe fatta, negli anni successivi, sempre più esclusiva. L’artista umbro aveva così sviluppato in modo originalissimo uno spunto che aveva colto nell’ambiente romano e in particolare nel lavoro di Enrico Prampolini che già nel periodo futurista aveva realizzato opere con parti di colore e di sabbie e che nel 1944 aveva pubblicato arte Polimaterica. Come il Museo Guggenheim mette bene in evidenza con la sua straordinaria collezione, questo era un filone di ricerca che più o meno negli stessi anni era stato sviluppato da Jackson Pollock che, invece, aveva tratto ispirazione dalle “pitture di sabbia” della tradizione indiana in America.
Un altro importante capitolo della mostra nel museo newyorkese è dedicato ai Gobbi con cui Burri cancellava ogni divisione fra scultura e pittura. Il primo Gobbo nacque nel 1950 incastrando sul retro del quadro un frammento di legno che rende irregolare la superficie del dipinto. In quello stesso anno Alberto Burri realizzò il primo Sacco, un quadro eseguito intelaiando un frammento di tela proveniente da un sacco usato con le cuciture e i rattoppi bene in vista. Negli anni successivi riprese certi effetti di sgocciolatura del colore già presenti nei Catrami e aggiunse ai frammenti altri materiali di recupero, stracci, lembi di tessuto. Nello stesso tempo cominciò a servirsi d’altri residui, dalle carte alle lamiere, dai legni bruciati alla plastica. Nel 1954 la prima Combustione, il primo intervento con il fuoco su cellotx.
Alberto Burri rompe decisamente con la tradizione facendo della materia la vera protagonista dell’opera, ma non si tratta di materia bruta e inerte, in quanto dopo il trauma della guerra, diventa materia viva, carne e sangue di chi era stato al fronte e in senso più universale di un’umanità non arresa di fronte alla distruzione e alla violenza.
[social_link type=”twitter” url=”https://twitter.com/TizianaBarilla” target=”on” ][/social_link] @simonamaggiorel